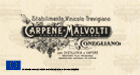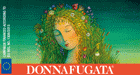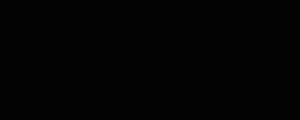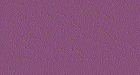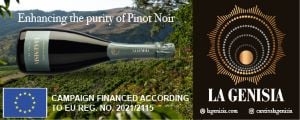Vino… è salute: il vino, oltre ad essere un alimento integrante della dieta mediterranea, ha effetti benefici sulla salute dell’uomo. Solo di recente, la scienza lo ha finalmente emesso queste importanti parole. Accostarsi al vino (con moderazione) per le azioni benefiche degli antiossidanti naturali contenuti nel vino (i composti fenolici, in particolare il resveratrolo), per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, tumori e malattie neurodegenerative. La consacrazione di questi "comandamenti" è arrivata sul finire degli anni Novanta dai più grandi studiosi delle principali Università del mondo.
Vino & Legge: nel 1963 arrivano le denominazioni (doc e docg) - soprattutto toscane e piemontesi - e le delimitazioni delle aree vinicole, produzione massima per ettaro, controlli di legge. Ma è il ’92 l’anno della "svolta" con norme più innovative: arriva la struttura "a piramide" (docg, doc, igt, vino da tavola), che introduce, in un certo senso, il concetto di "cru" alla francese. La prima docg è il Brunello di Montalcino, con il Decreto del Presidente della Repubblica del 1 luglio 1980. Con la 164/92, arriva anche il principio della scelta vendemmiale. E’ l’inizio della nuova epoca per il vino italiano: qualità, grazie alla selezione dei cloni; gestione attenta dei vigneti; ammodernamento delle cantine; stile, immagine e nuovo marketing per i vini italiani. Nel 1999, le docg sono 21 e le doc 306 (in Francia, circa 800). La produzione doc/docg in Italia è del 21% (55,9 milioni d’ettolitri, nel ‘99).
Innovazione in cantina, ma è la vigna che conta: il progresso nel mondo del vino c’è stato più in questi ultimi 30 anni che in 2000 anni. I veri cambiamenti, infatti, si sono avuti dagli anni Settanta, caratterizzati per le ricerche scientifiche applicate in vigna (è il luogo in cui si progetta il vino e si determina in modo decisivo il suo destino) e l’innovazione tecnologica in cantina (importante è stato l’arrivo dell’acciaio inossidabile e l’impiego del legno, non più come contenitore, ma come strumento di elaborazione del vino). In questi ultimi anni, è iniziata la corsa alla valorizzazione dei vitigni autoctoni, che rappresentano le principali qualità distintive dei vini. Uno dei principali simboli di questa "innovazione-rivoluzione" è stata la creazione, da parte dell’enologo-manager Ezio Rivella, della Castello Banfi di Montalcino, l’investimento nell’enologia di qualità più importante della storia italiana (250 miliardi in 20 anni).
Vino & Vinitaly: momento importante per misurare tendenze e gusti del mercato e per progettare il futuro dell’enologia: questo è Vinitaly, nato nel 1967 da un’idea di Angelo Betti. A Vinitaly sono rimbalzati gli effetti d’avvenimenti di gran peso: dallo scandalo al metanolo (1986), che proprio da Verona trovò una risposta inequivocabile da parte dei migliori produttori italiani, alla guerra del vino con la Francia (metà degli anni Settanta) per i vini da taglio, alle crisi economiche più dure (’73 e ’93) ed ai toni minacciosi di alcune amministrazioni americane che accusavano l’Italia di "dumping". Oggi il business del vino è stimabile in 16.000 miliardi.
Turismo e strade del vino: decolla, negli anni Novanta, l’enoturismo, ovvero il turismo da amanti della natura e della buona tavola in aree ricche di storia, di tradizione, di cultura, di vino. L’idea, che nasce da Donatella Cinelli Colombini, è importante per sviluppare i distretti enologici di qualità e per accrescere la cultura del vino. Le stime del Censis parlano, entro il 2004, di 15 milioni di presenze e 5.000 miliardi. La Regione Toscana è stata la prima a legiferare in tema di turismo del vino nel 1996, anticipando la legge nazionale sulle "strade del vino", che è del 1999.
Vino & Finanza: il vino è stato scoperto dalla finanza, tanto che non è più tanto strano vederlo abbinato ai "futures" (contratto d’acquisto differito nel tempo di un lotto di solito di sei bottiglie di altissima qualità). A rompere il ghiaccio in Italia è stata la Castello Banfi di Montalcino, sull’esempio dei grandi chateau francesi. A seguire altre aziende (Antinori, Frescobaldi, Fontanafredda …) hanno esplorato questo strumento finanziario, anche con il supporto d’importanti banche e mercant bank. Un matrimonio che avrà sicuramente ulteriori evoluzioni: "i futures sul vino sono una nicchia interessante e ha ottime possibilità di sviluppo", parola di Mediobanca.
Il vino e i suoi personaggi: Ezio Rivella, enologo-manager e ideatore del più grande investimento del vino in Italia, la Castello Banfi di Montalcino, e dei "futures sul vino"; Giacomo Tachis, creatore di vini "cult" (Sassicaia, Tignanello, Pelago) ed artefice, dagli anni Settanta, del Rinascimento del vino italiano nel mondo; Franco Biondi Santi, ovvero il Brunello di Montalcino, unico produttore italiano nei vini del secolo del "Wine Spectator" e patron della famiglia capostipite dell’antiquariato vinicolo in Italia; Piero Antinori ed Angelo Gaja, più volte incoronati "uomini del vino" dell’anno negli Usa; Gianni Zonin, il capitano della prima azienda vinicola privata italiana, che fornisce i vini alla Casa Bianca; la famiglia Frescobaldi che dà vita alla prima joint-venture italiana, con i Mondavi, famiglia d’origine italiana che ha fatto la storia del vino di qualità in California.
Vino & Cucina: se il vino italiano oggi è protagonista in tutte le tavole importanti, molto lo deve al successo della cucina italiana e dei suoi cuochi italiani superstar in tutto il mondo (la cultura e l’immagine della cucina italiana è un’arma di successo che deve essere ancora meglio sfruttata). Il futuro del vino - che è quello di "bere poco, bere bene" (il consumo, del resto, è passato dai 120 litri del 1900 ai 57 litri del 1996) - si muove con i wine-bar, enoteche, vinerie, osterie: il vino diventa la bevanda chiave e caratterizzante dell’offerta del locale; ma il wine-bar svolge un ruolo fondamentale nel far riscoprire anche le tradizioni locali e nel promuovere la conoscenza e le degustazione di altri prodotti tipici del territorio.
Premi, aste … gli italiani a ridosso dei francesi: agli inizi del 1900, il vino è un umile compagno di fatica (il consumo è a 120 litri a testa) e pochissime sono le fattorie imbottigliatrici e con proprie etichette, anche se raccolgono riconoscimenti di livello internazionale (in particolare, Brunello, Chianti, Barolo). Le grandi aste prendono piede a partire dagli anni ‘60/’70, soprattutto con prezzi record di Brunello e Barolo. Ma è nel 1999 che i grandi vini italiani alle aste internazionali compiono un salto di qualità, arrivando a ridosso dei famosi chateaux francesi e rivalutandosi più rapidamente degli altri. Questo non vuol dire che non siano sempre i francesi a condurre le danze, ma è comunque un importante dato di fatto per le nostre "blue chips". Le produzioni top d’Italia insomma hanno ormai compiuto davvero un salto di qualità: se nel ’98 la loro presenza alle grandi aste si era fatta massiccia ed abituale, ora è diventata addirittura qualificante: per un’asta internazionale, infatti, le etichette made in Italy sono indispensabili per essere considerata di "serie A". Nel 1997, il giro d’affari delle aste è stato di 200 miliardi di lire, di cui metà fatturato da Christie’s. Il record è in mano ai francesi: 310 milioni (nel 1985) per una bottiglia di 75cc di Chateau Lafite 1787; il "colpo" grosso più recente i 211 milioni (nel 1997) per una bottiglia da 450 cc di Chateau Mouton Rotschild 1945. La valutazione italiana più alta sono i 40 milioni (nel 1988) per un Brunello Biondi Santi 1888. Oggi le Riserve Brunello Biondi Santi 1888 e 1891 non hanno prezzo.
Le "blue chips" italiane: anche se il vero piacere è "bere bene" (nonchè la socialità del vino) ed il collezionismo ha ragioni oscure, sono sempre di più gli appassionati di bottiglie storiche o etichette considerate delle vere e proprie "blue chips". In primis, il toscano Sassicaia, venduto nel settembre ’99, a 2.200.000 lire la bottiglia (annata 1985), subito a ridosso dei leader mondiali, Romanée Conti e Chateau Petrus. Seguono altri italiani come il Brunello di Montalcino 1990 Case Basse a 800.000 lire, il Barolo Monfortino 1971 di Conterno e il Barbaresco Sori Tildin 1990 di Gaja, rispettivamente a 750.000 lire e 720.000 lire. E poi i Brunello di Biondi Santi (uno dei marchi più apprezzati anche nelle grandi aste storiche di Sotheby’s e Christie’s; la tenuta di Montalcino è da considerare la capostipite dell’antiquariato vinicolo in Italia), Castello Banfi "Poggio all’Oro", Pieve Santa Restituta; la coppia di Piero Antinori Solaia-Tignanello e quella del fratello Ludovico, Masseto-Ornellaia; l’Amarone di Quintarelli, Allegrini e Dal Forno; I Sodi di San Niccolò di Panerai; i Barolo di Sandrone, Gaja, Conterno, Ceretto, Giacosa, Mascarello. Ma un buon andamento nelle aste internazionali, lo stanno anche avendo alcune "creazioni" della nuova enologia italiana: un segno molto positivo nelle quotazioni delle aste anche per i "giovani" miti come l’umbro Sagrantino di Montefalco "25 Anni" di Arnaldo Caprai, il toscano Sammarco e la Vigna d’Alceo del Castello dei Rampolla, le Pergole Torte del toscano Montevertine, il "Pelago" della marchigiana Umani Ronchi, il Chianti Classico Riserva del Castello di Brolio, il Desiderio e la Vigna l’Apparita di Avignonesi ed ancora il Campaccio, il Turriga, il Guado al Tasso, il Siepi, il Fontalloro, il Sangioveto, il Redigaffi, il Saffredi, il Ricolma, il Messorio, il Terre Brune, il Montiano, il Montevetrano, il Flaccianello ...
Vino & Cultura: il più antico premio è del 1931: a Firenze, il Premio Ruffino Antico Fattore chiamava a raccolta numerosi artisti per l’elezione del miglior poeta dell’anno (tra i primi ad essere premiati i futuri Nobel, Montale e Quasimodo). A seguire altri premi Nonino, Colombini Cinelli, Ceretto, Masi. La cultura del vino sbarcherà poi anche con i musei della civiltà del vino, tra i più belli quello della Martini, Bersano, Lungarotti, Castello Banfi …
Italia, altre curiosità e date enologiche: dal 1911 al 1920, i danni della guerra e della filossera, tempi bui per la viticoltura italiana, alle prese con sistema vecchi di coltivazione, sradicamenti di vigneti, danni all’ecosistema; nel 1919, diventa senatore Luigi Einaudi, poi presidente della Repubblica, dal 1948 al 1954 (da giovane, a Dogliani, in Piemonte, era un pioniere della viticoltura); nel 1950, dopo la guerra, inizia la ricostruzione anche enologica dell’Italia: nascono l’Associazione Enotecnici Italiani e l’Associazione Italiana della Vite e del Vino per il progresso del vino italiano; dal 1950 al 1960, il vino sfuso è sempre forte - ma si comincia ad imbottigliare sempre più - e cresce anche l’export; dal 1985 al 1990, sono gli anni dei grandi eventi nel mondo del vino e la cucina italiana trascina al successo i vini italiani: sale il valore aggiunto delle produzioni italiane e l’enologia italiana arriva ai vertici mondiali della qualità.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025