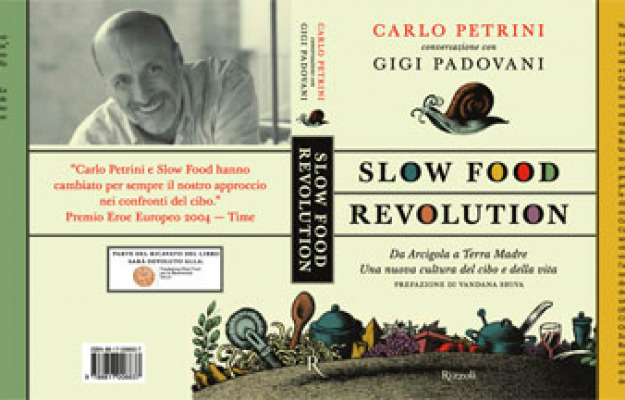E’ davvero un bel libro quello in uscita (Slow Food Revolution, Rizzoli, 17 euro, una parte dei proventi andranno alla Fondazione Slow Food per la biodiversità Onlus che sostiene i Presìdi italiani e stranieri; info: infopoint@rcs.it), da oggi, in tutte le librerie d’Italia, curato da Gigi Padovani (www.gigipadovani.it), giornalista de “La Stampa”. Dentro c’è un mucchio di lavoro - interviste, documenti, ricerche e d’archivio - che ci raccontano la vera, grande, importante rivoluzione attuata da Slow Food, raccolta da Padovani proprio dal suo principale attore-regista, Carlo Petrini.
Il libro - dedicato a Bartolo Mascarello, anche perché contiene l’ultima intervista che ha concesso, proprio qualche giorno prima della sua scomparsa, in cui racconta come aiutò all’inizio di ragazzi che venivano da Bra e volevano imparare la cultura del vino e fondare Arcigola negli Anni Ottanta - parte da una scampagnata andata male e poi contestata via lettera a Montalcino (dove, nei primi anni Ottanta, anche i protagonisti di questo sito, Alessandro Regoli e Irene Chiari, insieme ad altri giovani, stavano già lavorando nel settore del “wine & food”, ndr). Alla risposta piccata dei responsabili dell’Arci di Montalcino, seguirono dibattiti pubblici, incontri, riflessioni che, negli anni, hanno portato Slow Food da sostenitori del piacere conviviale (piacere del cibo e della lentezza) ad importante e fondamentale Movimento che sta conquistando il mondo e cambiando per sempre l’approccio nei confronti del cibo (opposizione all’omologazione del “fast food”, impegno a tutela dei prodotti tradizionali attraverso il progetto dei Presìdi, educazione del gusto con la realizzazione dell’Università di Scienze Gastronomiche, progetto di “Terra Madre”, incontro mondiale delle comunità del cibo).
Il libro ha la prefazione di Vandana Shiva, scienziata e filosofa indiana, che dirige la Research Foundation for Science, Technology and Ecology ed è famosa in tutto il mondo per la sua militanza in difesa dell’ambiente e, in particolare, delle colture tipiche e della biodiversità.
Il risvolto del libro “Slow Food Revolution”
“Nel Basso Piemonte, tra le Langhe e il Roero, nasceva vent’anni fa un movimento destinato a diventare in tutto il mondo sinonimo di un’autentica nuova filosofia del e dei valori della terra. La storia di Slow Food è legata a doppio filo a quella del suo carismatico leader, Carlo Petrini, che in questo libro ne ripercorre le tappe fondamentali, dalla militanza nei gruppi della sinistra radicale al sodalizio con Dario Fo e il Club Tenco, fino alla svolta enogastronomica dei primi anni Ottanta e alla nascita della Libera e Benemerita Associazione degli Amici del Barolo, cui aderiranno anche Roberto Benigni, Francesco Guccini e Roberto Vecchioni. È il primo nucleo di quella che diventerà, nel 1986, la lega Arcigola, che assumerà tre anni dopo il nome Slow Food con il Manifesto del movimento internazionale presentato a Parigi.
Dopo la fondazione di una fiorente casa editrice, negli anni Novanta l’associazione partecipa al Vinitaly di Verona e organizza una serie di fortunati eventi gastronomici, culminati nel Salone del Gusto di Torino. Oggi si batte per la tutela dei prodotti tradizionali “a rischio di estinzione” dando vita ai Presìdi Slow Food, in Italia e all’estero, e per diffondere una consapevole educazione al gusto, inaugurando le Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Colorno.
Carlo Petrini e Gigi Padovani illustrano i punti salienti della “filosofia slow”: la rivendicazione del diritto al piacere conviviale opposto all’omologazione del fast food; il recupero del valore della lentezza in contrapposizione ai ritmi frenetici della società contemporanea; l’assunzione di un nuovo senso di responsabilità nei confronti della produzione e del consumo del cibo, più attento alla salvaguardia dell’ambiente, e alla qualità dei prodotti e alla giustizia sociale.
Un impegno confermato dalla grande assemblea di Terra Madre nell’ottobre del 2004, quando 4.888 tra agricoltori, allevatori, pescatori e artigiani del cibo di 130 Paesi sono convenuti a Torino per discutere di biodiversità e di agricoltura sostenibile. E attraverso le testimonianze dirette dei protagonisti, gli autori ci accompagnano in un viaggio alla scoperta di prelibatezze etniche (dalla Polonia a Sao Tomè, dall’Afghanistan al Cile), ma anche italiane come la bottarga di Orbetello, il cappone di Morozzo, il fagiolo Zolfino e la manna delle Madonie.
Slow Food Revolution ricostruisce le tappe e le conquiste di un movimento culturale tra i più significativi degli ultimi anni, invitandoci a rinnovare il rapporto con il cibo e a restituire nuova dignità al piacere della tavola”.
La cronologia del libro “Slow Food Revolution”
La formazione: 1981-1986
Tutto nasce da un confronto-scontro a Montalcino tra Arci Langhe e Arci Toscana sulla qualità del cibo: è una gita del 31 ottobre 1982, quando i piemontesi viaggiano più per piacere che per cultura e i toscani danno da mangiare più per far soldi che per cultura. Nasce, nel riflusso generale, una associazione con scopi a metà tra il goliardico e il sociale: la Libera e benemerita associazione amici del Barolo che poi porterà alla nascita di Arcigola. Sono di quegli anni i primi viaggi nella Borgogna, le prime esperienze di laboratori del gusto a Verbania, Mira ecc. I contatti intellettuali a Milano con “La Gola”. E’ la fase enologica.
Le radici: 1949-1981
Con una sorta di Un “flash-back”, si va dalla nascita di Carlin, all’avvio dell’attività culturale a tempo pieno, attraverso gli spacci popolari, le canzoni del repertorio tradizionale, la ricerca di finanziamenti con il turismo sociale, con la parentesi di Radio Bra Onde Rosse, il giornale ... E’ la fase politica
L’idea: 1986- 1989
Sono gli anni in cui si accelera l’elaborazione del progetto di Arcigola, attraverso i primi contatti per la nascita dell’inserto del Gambero Rosso. Lo sbocco è il congresso di Parigi del dicembre, con il lancio di Slow Food in contrapposizione ai fast food e alla fast life.
La semina: 1989-1996 E’ il periodo del consolidamento internazionale, con tante esperienze, la nascita della casa editrice, il primo esperimento di Milano Golosa nel ‘94, i laboratori al Vinitaly, infine il Salone del Gusto a Torino. E’ la fase eno-gastronomica, di organizzazione.
Il raccolto: 1996.2004
In questo periodo, soprattutto con l’esplosione del Salone di Torino del 1998, a Bra si rendono conto della potenzialità del loro lavoro: si sviluppo il concetto prima di Arca, poi dei Presidi, il progetto di Pollenzo e infine si organizza Terra Madre. Arriva il successo internazionale. E’ la fase in cui viene inventata la eco-gastronomia.
Sintesi: la storia di Carlo Petrini e
di Slow Food, anno per anno
1949
Il 22 giugno a Bra, con l’aiuto della levatrice Maria Gola, da Maria e Giuseppe, nasce Carlo Petrini. Il padre aveva un’officina di elettrauto, la madre era dirigente di un asilo, ma in famiglia si sentiva come molto forte la personalista del nonno Carlo, un ferroviere che fu eletto consigliere comune per le liste socialiste e scelse l’adesione al Pci.
1966
A 17 anni Carlin diventa presidente della San Vincenzo di Bra: in quegli anni organizza la prima raccolta di bric-a-brac nelle cantine per il Terzo Mondo, raccogliendo 20 milioni di lire di allora. E incomincia in quel periodo il sodalizio con Azio Citi e Giovanni Ravinale, che costituisce un “terzetto” poi impegnato sia in attività culturali che ludico-goliardiche con le canzoni e cabaret.
1968
Petrini si diploma all’Itis di Fossano, ma ammette la sua predilezione per le materie umanistiche.
1969
Si iscrive all’Università di Trento a Sociologia. E’ il contatto con la politica. E’ comunque uno studente-lavoratore, perché fa il rappresentante di vari prodotti alimentari per mantenersi agli studi. Da una scissione con la Federazione dei marxisti leninisti d’Italia nasce Avanguardia Proletaria Maoista, che fa capo a Spazzali Thiella e Semeraro. E’ il primo gruppo al quale aderisce Carlo Petrini a Bra.
1970
Il primo maggio è fondato il quotidiano “il manifesto”, che è anche gruppo politico.
1971
Viene fondata da Carlo Petrini e altri (Giuseppe Bona, Azio Citi, Giovanni Ravinale, Piero Sardo) la cooperativa Circolo Leonardo Cocito: il circolo è intitolato ad un eroe della Resistenza locale. Ne è presidente Angelo Testa, un ottico con la passione del jazz che aveva già organizzato a Bra rassegne di musica. Aveva sede in via Umberto, nel centro di Bra, dove ora c’è la sede della Cgil e un B&B. Del gruppo iniziale fanno parte anche Azio Citi e Giovanni Ravinale. Confluisce nel gruppo anche Silvio Barbero, un po’ più giovane (è del 1952) che proveniva dall’Azione Cattolica.
1974
Viene fondato il settimanale “In campo rosso”. Ne diventerà direttore è Grazia Novellini, che era già giornalista pubblicista. Il mensile locale, poi quindicinale, esce fino al 1986.
1975
Nel 1975 apre lo spaccio di Unità Popolare, circolo Cica-Crass affiliato all’Arci. Durante le elezioni amministrative del 1975 il Circolo Cocito di Bra e il giornale “In Campo Rosso” si schiera a fianco del Pdup. Il 17 giugno 1975 i ragazzi di Carlin fanno partire una nuova iniziativa: una radio privata, la prima in Italia non commerciale. Erano passati due mesi dalla promulgazione della legge 103, approvata dal Parlamento per correre ai ripari dopo la famosa sentenza della Corte Costituzionale del luglio 1974 che aveva dichiarato illegittimo il monopolio della Rai. Quella legge vietava le iniziative locali di cittadini italiani ma permetteva l’installazione di ripetitori per programmi stranieri e liberalizzava la tv via cavo. In questo contesto molto controverso sul piano giuridica, il quell’estate partono i programmi di Radio Bra Onde Rosse, la prima trasmissione è a giugno. Viene usata come sigla “Pablo” di Francesco De Gregori. Il 14 luglio la radio viene sequestrata. Nasce una solidarietà molto ampia, compreso il collettivo teatrale “La Comune” di Dario Fo e Franca Rame. Il secondo tentativo avviene a settembre: ripartono i programmi, il 9 ottobre l’autorità giudiziaria ordina di nuovo il sequestro dell’emittente: nasce un processo, con rinvio alla Corte Costituzionale. Poi il 4 dicembre 1975 gli indomiti ragazzi di Carlin riprendono a trasmettere, e il ripetitore viene spostato a La Morra. Il palinsesto si arricchirà ancora dall’anno successivo, fino a 11 ore di trasmissione il giorno. La liberalizzazione della emittenza privata avvenne dopo la sentenza della Consulta il 28 luglio 1976. La chiusura avverrà nel 1978, e l’ultima notizia fu il rapimento di Aldo Moro. Contro i ripetuti sequestri degli impianti e i procedimenti penali a carico degli amministratori della cooperativa si mobilitò l’intelligentia che il gruppo di giovani braidesi ha saputo coinvolgere con le sue battaglie per i diritti civili.
1976
Carlo Petrini entra nel Consiglio comunale (a gennaio, con mesi di ritardo per un ricorso) come rappresentante del Pdup, mentre si sviluppa il progetto dello spaccio di Unità Popolare, circolo Cica-Crass affiliato all’Arci. A giugno nasce ad Alba la Cooperativa libraria La Torre.
1979
Nel 1979 Carlo Petrini organizza la prima edizione della rassegna di musica popolare Canté i’euv attraverso l’Arci Langhe, che avranno un grande successo e si tennero per tre anni consecutivi. Silvio Destefanis, segretario regionale Arci del Piemonte, fa entrare Petrini nel direttivo nazionale dell’organizzazione presieduta da Enrico Menduni.
1980
Alle elezioni comunali di Bra il gruppo ottiene un lusinghiero successo elettorale, con una lista che ottiene più voti del Pci e porta tre consiglieri a Palazzo Civico. Il primo maggio a San Giuseppe di Monforte, alla festa della frazione, il gruppo di Petrini incontra le gemelle Nete, che poi Renzo Arbore scoprirà nella rassegna del Club Tenco e porterà in tv. Si svolgono gli incontri a Pavana, da Guccini, a luglio. Il 23 novembre l’Irpinia è sconvolta da un gravissimo terremoto: con Giovanni Ravinale, Petrini organizza i primi aiuti per il Consiglio comunale di Bra.
1981
E’ un po’ l’“annus horribilis”, come ricorda Petrini: mancano i soldi per la rassegna musicale, mentre lui, come organizzatore degli aiuti, viene attaccato per un ritardato pagamento di materassi inviati in Irpinia. Mentre arriva la Guardia di Finanza, un pretore lo rinvia a giudizio. Petrini si dimette immediamente e così finisce la sua carriera politica. Sette anni dopo sarà assolto da quell’accusa. Il primo maggio a Treiso, sulle colline nasce l’Osteria dell’Unione con Pina Bongiovanni e Beppe Marcarino: “Vieni a Treiso/se non temi/ l’anatema/degli astemi”. Lo spirito è quello di rivendicare il diritto al piacere. A settembre alla Festa Nazionale dell’Unità (a Torino) incomincia il tesseramento dei soci. Per far nascere la Libera e Benemerita Associazione degli Amici del Barolo. Ne fanno parte Francesco Guccini, Roberto Benigni, Ornella Vanoni, Davide Riondino, l’animatore del Club Tenco Amilcare Rambaldi, il presidente dell’Arci nazionale Enrico Menduni e pochi altri: è l’eletta schiera di membri onorari, per iniziativa dell’Arci Langhe “trascinata” da Carlo Petrini. Il primo incontro si volge nel novembre 1981 nel castello di - ovviamente - Barolo (Cn). Slogan dell’associazione: “Il Barolo è democratico, o quanto meno può diventarlo”. Tenuta sapientemente in bilico fra toni goliardici e reale voglia di apprendere, l’associazione rappresenta un momento storicamente significativo perché per la prima volta l’associazionismo di sinistra si accosta a temi “eretici” come il vino e la convivialità, rivendicando quel “diritto al piacere” che diventerà il cavallo di battaglia della futura Arcigola.
1982
Nasce a Bra, il 16 aprile, la Cooperativa i Tarocchi. Scopo della cooperativa è fornire alla nascente associazione Arcigola strumenti economico-giuridici e “militanti a tempo pieno” che le assicurino un’efficiente e continuativa operatività. In particolare è assillante il problema dei fondi: e infatti il gruppo incomincia a vendere vino, mentre organizza i ragazzi romani in agruturismi della Langhe. L’ultima delle sedi si trova a Bra, nel centro storico, in Casa Casalis, via della Mendicità istruita. A ottobre iniziano le pubblicazioni de “La Gola”, mensile ideato a Milano da Gianni Sassi, Antonio Porta, Alberto Capatti, Folco Portinari, Antonio Piccinardi, Nanni Ballestrini e altri. Si prefigura un’aggregazione del campo intellettuale intorno ai temi dell’alimentazione e della gastronomia. Diretto da Antonio Attisani, quindi da Antonio Porta e da Alberto Capatti. Le pubblicazioni cessano nel 1988. Anche dai dialoghi milanese tra Carlo Petrini e Gianni Sassi nasce l’idea di Arcigola. Nascono i primi contatti a Roma alla enoteca Cavour 313 con il gruppo di ex sessantottini legati a Andrea Gabbrielli, e Sandro Sangiorgi, con l’incontro con Daniele Cernilli, allora professore in una scuola e tra i primi collaboratori di Luigi Veronelli. Fin da quell’anno la sede ArciLanghe opera come realtà autonoma ma senza un autonomo tesseramento. Il 31 ottobre gita del gruppo Arci Langhe a Montalcino per la Sagra del Tordo. Sono una quindicina, diretti alla Casa del Popolo nel centro. Ma il cibo non soddisfa il gruppo, e finisce male la gita, con insoddisfazione generale. Allora il 3 novembre Carlo Petrini manda una durissima lettera ai “compagni dell’Arci” di Montalcino per dire che non si tratta così la gente. Ne nasce un caso politico e l’anno dopo ci sarà un convegno nel centro toscano, che dà il via al tema del cibo nella sinistra.
1983
La prima iniziativa è la vendita del vino novello. Il 9 aprile si svolge a Montalcino il pubblico dibattito su “Le case del popolo nella loro tradizione di festa e gastronomia”, presso il circolo Arci della Casa del Popolo: vi partecipano Carlo Petrini (messo “sotto processo” dai montalcinesi), oltre ai dirigenti toscani Arci e la gita di Arci Langhe. Da allora Petrini, citando anche Rita da Cascia, riesce a conquistare i compagni toscani con le sue argomentazioni e li convince che il cibo non deve servire solo a guadagnare soldi. Dal mese di aprile Carlo Petrini entra nel colophon della rivista “La Gola”, che si era presentato in edicola e libreria qualche mese prima, nell’ottobre 1982. Si definisce “Mensile del cibo e delle tecniche di vita materiale” e Petrini figura tra i consulenti. Non a caso, nel mese di settembre 1983, dopo l’episodio di Montalcino, esce un servizio dedicato a “La mensa delle feste politiche”, firmato da Corrado Giannone, e un altro articolo intitolato “Il cibo del borgo rosso” di Piero Meldini. Ma ci vorranno altri quattro anni, fino al 1987, perché quella idea di fare concorsi enogastronimici a sinistra diventi realtà. Il 26 novembre 1983 nasce l’Arci Gola, lega enogastronomica dell’Arci, nella quale l’associazione Amici del Barolo è promotrice. Viene preparato un primo libretto “Andar per vini” sulla Langa e i suoi produttori.
1984
Nel dicembre a Bra, in via Mendicità 12 apre i battenti l’Osteria del Boccondivino. Maria Proglio è la cuoca che vi inserisce le ricette dell’antica sapienza popolare.
1985
Carlo Petrini riceve il premio Rosetta Lajolo
1986
Si svolge il viaggio in Borgogna con il seminario di una settimana sulla cultura del vino a Beaune, presso il Centro interprofessionale. E’ un altro momento di svolta molto importante. Vi partecipano Piero Sardo, Renzo Tablino, Gigi Piumatti, Massimo Martinelli, Carlo Petrini. E’, infatti, subito dopo nasce ufficialmente Arcigola per iniziativa di ArciLanghe, Libera e benemerita associazione amici del Barolo. Per due giorni, tra il 26 e il 27 luglio 1986, si svolge il congresso di fondazione (presso le Cantine Fontanafredda) tra Bra, Verduno, Serralunga d’Alba e Barolo con soci Arci provenienti da varie regioni. Presidente viene eletto all’unanimità Carlo Petrini, affiancato dal segretario Silvio Barbero, con un consiglio di governatori composto da Elio Archimede, Stefano Bonilli, Caro Gabrielli, Antonio Gasparro, Guido Pirazzoli, Graziano Pozzetto, Sandro Sangiorgi, Pier Lorenzo Tasselli, Galdino Zara, Carlo Zucchetti. Simbolo di Arcigola è l’omino accanto al pentolone, obiettivo la diffusione di una nuova filosofia del gusto che coniughi conoscenza e piacere. Nel luglio 1986 esce il primo “house organ” di Arcigola, “Il Rosmarino”, diretto da Elio Archimede, che continuerà le sue pubblicazioni fino al novembre 1987. Sulla rivista “Barolo & Co”, nata nel 1983 e diretta da Gigi Padovani, realizzata da Elio Archimede, incominciano a uscire le recensioni di ristoranti e osterie nella rubrica “Piemonte in tavola” firmate da Carlo Petrini. E in quell’anno, dopo lo scandalo metanolo, c’è anche l’incontro con il giornalista romano Stefano Bonilli, che viene a Narzole per capire la dinamica dello scandalo al metanolo, per il quale muoiono 19 persone: lavorava per la trasmissione “Di tasca vostra” (antenata di Lubrano e Marrazzo su RaiTre) e collaborava con “il manifesto”. Lui si era fermato al ristorante Gambero Rosso, in Versilia, e tra gli echi di Pinocchio e la voglia di fare qualcosa, nasce l’idea di fare un supplemento del “manifesto”. Martedì 16 dicembre 1986 esce il primo numero di “Gambero Rosso”, supplemento di otto pagine all’interno del quotidiano “il manifesto”: esce il primo martedì del mese. Si definiscono con autoironia i “neoforchettoni” e si dice che è “a cura di Arci Gola”. Per i ristoranti, ci scrive anche Edoardo Raspelli. Il direttore è Stefano Bonilli. Nella redazione dall’anno dopo entra anche Andrea Gabbrielli. Si trasformerà in rivista, sempre come supplemento del “quotidiano comunista”, nel 1989. Il doloroso “divorzio” con il giornale di via Tomacelli avviene nel 1992, quando il magazine esce da solo in edicola.
1987
Incomincia la collaborazione con l’inserto “Andata e ritorno” de l’”Unità”, che incomincia a uscire il 23 aprile 1987 e proseguirà fino al 1989. Viene curato dal giornalista Silvio Trevisani (scomparso a fine 2004): vi collaborano molte firme note, nell’ultima pagina c’è una sorta di “Enciclopedye” illuminista del cibo. Si rintracciano le firme di Natalia Ginzburg, Maurizio Maggiani, Folco Portinari, Antonio Porta, Marco Guarnaschelli Gotti, Enrico Menduni, Gian Paolo Fabris, Decio G.R. Carugati. Nel primo anno Carlo Petrini scrive una ventina di articoli: su cibo, vino e anche recensioni di locali. Sulle pagine dell’inserto viene anche lanciato il concorso per i migliori ristoranti nelle Feste dell’Unità: parte il 15 giugno e va avanti fino al 15 settembre, con le graduatorie pubblicate sulle pagine. In quegli anni era direttore Gerardo Chiaromonte (fu nominato il primo maggio dell’’86, succedendo a Emanuele Macaluso). Continua la collaborazione dei ragazzi di Bra con il quotidiano di via Tomacelli e in fatti Il manifesto Slow Food viene pubblicato il 3 novembre 1987 dal supplemento “Gambero Rosso”. E’ presentata come “una proposta rivolta a tutti coloro che vogliono vivere meglio”. E’ firmato da Folco Portinari (che l’ha stilato), Carlo Petrini, Stefano Bonilli, Valentino Parlato, Gerardo Chiaromonte, Dario Fo, Francesco Guccini, Gina Lagorio, Enrico Menduni, Antonio Porta, Ermete Realacci, Gianni Sanni, Sergio Staino. Il 29 novembre si tiene a Montalcino la prima premiazione per i migliori ristoranti dei Festival dell’Unità. A Firenze il 13 dicembre viene presentata la prima “Guida al bere bene per esperti e curiosi”, cioè la “Vini d’Italia 1988” che è curata da Carlo Petrini e Daniele Cernilli: ci sono i primi 32 produttori ai quali va il riconoscimento dei tre bicchieri.
1988
L’”house organ” il Rosmarino diventa il Prezzemolo e si trasferisce a Bra. Continua la collaborazione con A/R, Carlo Petrini scrive nell’anno una ventina di articoli firmati. Il 4 luglio Arcigola convoca ad Alba gli stati generali dell’enogastronomia a discutere sul tema: “Può la Langa stare al Piemonte come la Cote d’Or alla Borgogna”. Seconda premiazione Feste Unità, sempre a Montalcino, il 27 novembre.
1989
Nasce l’Arcigoloso come supplemento all’Unità fatto da Bra, esce una pagina il lunedì (originariamente in accoppiata con “Cuore” di Michele Serra) da luglio fino al dicembre 1990. Era diventato direttore del quotidiano Pci Massimo D’Alema (nel luglio del 1988). Cambia ancora l’informazione: “Il Prezzemolo” diventa la newsletter di Slow Food, diretta da Giovanni Ruffa. Si tiene il primo “Gioco del piacere” il 29 aprile 1989 con 852 persone ospitate in 38 ristoranti, sui rossi austeri: serve per giudicare in modo comune lo stesso vino in tante città. Terzo e ultimo concorso per ristoranti delle Feste Unità con premiazione a Montalcino. A Parigi, in dicembre, in un congresso di tre giorni, si costituisce il Movimento Internazionale Slow Food, e delegazioni di tutto il mondo sottoscrivono il Manifesto. In quella occasione viene anche presentato l’Almanacco dei golosi, edito da Gambero Rosso, che viene presentata come “La Guida italiana dal prosciutto al bignè, curato da Giuseppe Mantovano e Carlo Petrini. In quella prima pubblicazione dedicata al cibo, un inventario di indirizzi piuttosto indistinto con i caffè storici, nasce poi l’idea del “Buon paese” che porterà all’Arca e ai Presìdi.
1990
A primavera, ad Alba, Arcigola Slow Food propone i Comizi Agrari, che saranno poi presentati al Salone del Gusto del 2002. Importante fase di avvio dei contatti internazionali. In Germania nasce Slow Food Deutschland. Particolarmente importante la prima edizione di “Osterie d’Italia”, sussidiario del mangiar bene all’italiana. C’è la prefazione di Folco Portinari. Altrettanto importante, dal 15 al 18 novembre, la prima Convention Internazionale sui Vini piemontesi. Un grande concerto di Paolo Conte con cena chiude la kermesse, è il debutto sul piano internazionale della associazione, si consolida il rapporto con i produttori locali, che capiscono come la formula inventata da Petrini funziona davvero. Nello stesso anno a dicembre si tiene il congresso internazionale di Venezia, il vero avvio del movimento con le delegazioni da tutto il mondo e non soltanto singole personalità come a Parigi. Esce L’Atlante delle vigne di Langa, un’opera che nessuno prima aveva tentato di organizzare: si cerca di applicare alle colline piemontese il concetto della “piramide” francese, con i “premier cru” e le altre qualità inferiori che tutte concorrono al successo del “terroir”. Un libro che sarà poi ampliato e ristampato nel 2000. E’ fatto con un metodo che Petrini imparò da Nuto Revelli e le sue interviste sul “Mondo dei vinti”. Nasce Slow Food editore. Dal luglio 1990 era diventato direttore de “l’Unita” Renzo Foa, che a quanto pare non apprezzava molto l’Arcigoloso. Fatto sta che la pagina esce l’ultima volta l’11 dicembre, poi c’è una famosa litigata tra la redazione di Bra e quella romana centrale del quotidiano Pci. Da quel momento i ragazzi di Carlin incomincia a viaggiare da soli nel mondo dell’informazione, dopo essersi staccati dal giornale fondato da Antonio Gramsci lasceranno anche il Gambero Rosso di Bonilli. La carriera giornalistica di Petrini riprenderà otto nove anni dopo su “La Stampa” diretta da Marcello Sorgi nel 1998-1999.
1991
A Perugia si tiene il Congresso nazionale di Arcigola Slow Food.
1992
Esce la prima Guida ai vini del mondo curata da Carlo Petrini, con 1.900 cantine e 5 mila vini. E’ in cinque lingue, a giugno, presentato a Chateu Margaux. La seconda edizione esce nel 1995. Nasce anche la collana Ricette di Osterie. A maggio si svolge un importante viaggio in California della “sporca dozzina”. Fu organizzato dal produttore Angelo Gaja, per divulgare la cultura dei vini americani, che aveva incominciato a importare. Vi parteciparono quattro agenti della ditta: Giancarlo Codegoni, da Milano; Pietrucci, da Ancona; Paolo Barovier, da Venezia e Beppe Farinasso. Insieme a loro tre comunicatori enoici: Davide Paolini, Gigi Piumatti e Carlo Petrini. E poi quattro importanti ristoratori: il più famoso allora era Guido Alciati di Costigliole d’Asti, con il suo giovane “allievo” Gianfranco Vissani, con Coriolano Mastrantonio (del Ristorante Coriolano di Roma) e Mario Stoppani (del ristorante Peck di Milano). Probabilmente ha partecipato anche Andrei Celicef (enologo di Coppola). E’ un momento fondamentale per i fondatori di Arcigola, conoscono la realtà del cibo negli Stati Uniti, che sorprendentemente è più avanti di quanto non immaginano. Interessante esperienza giornalista del gruppo, guidata da Mavi Negro: al Vinitaly, su incarico di Umberto Benezzoli, allora a Verona e oggi Ad di Lingotto Fierre, nasce un quotidiano del gusto che si intitola “Vinitaly News” e che esce fino al 1998, per sei anni. C’è una vera e propria redazione alla Fiera. Nasce Slow Food Germania.
1993
A giugno si tiene la prima Settimana del Gusto, che viene ripetuta nei successivi quattro anni, rivolta ai giovani. Nascono anche gli Itinerari Slow, come strumenti di turismo enogastronomico.
1994
Al Vinitaly di Verona si svolge il primo “Gran Menu” con i laboratori del gusto, uno strumento chiave della didattica del gusto: compaiono i banchi sui quali si studia il cibo. Una vera rivoluzione per il mondo dell’enogastronomia. Quindi viene sperimentata, che si tiene dal 1 al 4 dicembre, “Milano Golosa”. Nasce il libro il Buon Paese, riproposto poi nel 2000. Nasce Slow Food Svizzera.
1995
Nasce il progetto di solidarietà Tavole Fraterne
1996
La newsletter si sdoppia per dare vita a “Slow Food” e “Slow Wine”, che esce fino al 2000. Nasce la rivista internazionale “Slow”, messaggero di gusto e di cultura, in tre edizioni: italiano, inglese e tedesco. Dall’11 settembre 1998 si aggiungono spagnolo e francese, con 10 numeri l’anno inviati a tutti i soci del mondo. Si svolge il primo Salone del Gusto sperimentale a Torino. Il 2 dicembre a Torino si tiene il convegno dal titolo “Un’Arca del Gusto per salvare il pianeta dei sapori”. E’ quello che Petrini definisce il principio di Noè.
1997
Nasce l’Agenzia di Pollenzo, che prevede di acquistare e ristrutturare la vecchia struttura dei Savoia e di inserirvi ristorante, albergo, banca del vino e Università. Il 29 giugno Slow Food pubblica il Manifesto dell’Arca. Congresso internazionale di Orvieto. Dal 19 al 22 settembre la prima edizione di Cheese a Bra, le forme del latte.
1998
Congresso nazionale di Slow Food Arcigola a Rovereto che approva la scelta dei presidi. Si tiene anche il congresso internazionale straordinario di Torino per un nuovo statuto. Secondo Salone del Gusto a Torino: un successo inaspettato. Esce il primo articolo firmato Carlo Petrini su “La Stampa”, il 30 ottobre, dedicato a presentare il Salone. Su iniziativa di Slow Food e dei sindaci di Bra, Greve in Chianti, Orvieto, e Positano nasce l’associazione Città Slow. Si pubblica “Dire fare gustare” realizzato da Rossano Nistri. Si costituisce l’Agenzia di Pollenzo presso lo studio torinese de notaio Marocco.
1999
Nasce la commissione scientifica dell’Arca e all’asemblea dei fiduciaria di Bologna, in novembre, si incomincia a parlare di Presìdi. Seconda edizione di Cheese. Incomincia la collaborazione con “La Stampa”: esce il primo numero della rubrica settimanale al sabato, nel rinnovato inserto “Ttl”, con il titolo “Sostiene Carlin”.
2000
A New York si tiene Superwhites, manifestazione promossa da Slow Food con I produttori di vino friulani. Seguono altre edizioni a Roma, Zurigo, Grand Cayman, Londra. Nasce il Premio Slow Food per la Biodiversità a Bologna, è l’antesignano di Terra Madre del 2004. Slow Food insieme all’Istituto di Zootecnia di Potenza lancia il manifesto in difesa del formaggio a latte crudo, che raccoglie 20 mila firme presentate all’Unione Europea. Il primo ottobre esce la prima rubrica settimanale su “La Stampa” “De gustibus disputandum est”, firmata da Carlo Petrini, la domenica nella pagina dell’agricoltura: è quotidiano torinese ed è il primo giornale che ha fatto uscire una pagina dedicata al settore primario. Si svolge a Torino il terzo Salone del Gusto, in cui vengono presentati per la prima volta i Presidi. Nasce Slow Food Usa.
2001
Nasce il sito Internet. Il 20 maggio, a Giulianova, nell’ambito dell’Assemblea nazionale dei fiduciari di Slow Food Arcigola viene varato il progetto Master of Food, con lo slogan “Il gusto di saperne di più”. Si tiene a Bra la terza edizione di Cheese. A novembre le condotte toscane organizzano Toscana Slow. Nasce la banca del vino. Seconda edizione del Premio Slow Food per la Biodiversità a Oporto. E’ un altro “anno orribile” per Petrini, con il dispiegarsi della malattia al fegato, per un virus: è costretto a seguire l’attività del movimento da casa, lontano da tutti. Grazie alle cure adatte, ne esce soltanto nel luglio 2002.
2002
A giugno l’Associazione italiana perde definitivamente il nome Arcigola e si chiama Slow Food Italia. Si riafferma la svolta “ecogastronomica”, con enfatizzazione dei temi a difesa della biodiversità e della promozione dell’educazione al gusto. Si tiene il quarto Salone del Gusto. Si tiene la terza edizione del premio per la Biodiversità a Torino. Si pubblica anche l’Atlante dei prodotti tipici dei parchi italiani, con 475 prodotti, 1585 indirizzi.
2003
Viene riconosciuta la Fondazione Slow Food per la Biodiversità. Si tiene a Bra la quarta edizione di Cheese. In novembre si svolge a Napoli il congresso mondiale di Slow Food. Nasce Slow Food France.
2004
A maggio si inaugura l’Agenzia di Pollenzo. Si tiene a giugno la prima edizione di Slow Fish a Genova. Quinto Salone del Gusto a Torino. Terra Madre. Iniziano i corsi ad ottobre dell’Università del gusto. A Londra Carlo Petrini riceve il premio Eroe dell’anno a Carlo Petrini da parte di “Time Magazine”. Nasce Slow Food Japan
2005
Il primo gennaio il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nomina Carlo Petrini Grande Ufficiale. Nasce Slow Food Uk.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025