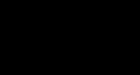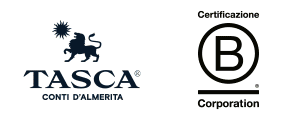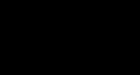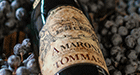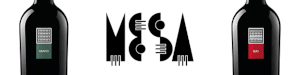Stefano Bianchi, primo classificato, con “Un bicchiere di parole”, Sebastiano Carron, secondo, con “La vigna stregata”, Serena Stringher, terza, con “Un sorso di magia”: ecco i tre vincitori del Premio letterario Santa Margherita, promosso in collaborazione con Librerie Feltrinelli, su oltre mille appassionati scrittori esordienti (e inediti), amanti delle buone letture e del buon vino, che hanno inviato da tutta Italia i loro racconti inediti di 4000 battute. Ai tre vincitori, non solo buoni per l’acquisto di libri e le etichette cult di Santa Margherita, ma l’opportunità di pubblicare i racconti sulle retro-etichette delle bottiglie di Pinot Grigio, Chardonnay Trentino, Müller Thurgau Frizzante Santa Margherita (con “tirature” di 700.000 bottiglie).
Il Premio, che ha avuto ieri sera il suo epilogo nell’Hotel Exedra Milano, è stato valorizzato dalla presenza di tre “autori Doc”, che hanno proposto altrettanti racconti, sempre con protagonista il vino. Si tratta di Eva Cantarella, con uno scritto dal titolo “Vino”: docente universitaria e antichista di fama internazionale, è autrice di importanti opere sui grandi temi della vita, giuridici e sociali, al tempo dei Greci e dei Romani, approfonditi anche con ironia e leggerezza; di Piersandro Pallavicini, che ha presentato un simpatico racconto dal titolo “Le notti folli del vino nero”, in linea con il suo stile eclettico e contemporaneo; di Martino Gozzi, un giovane romanziere emergente, classe 1981, che ha proposto il suo interessante “Messaggio in bottiglia”.
Un contributo prezioso, il loro, per la diffusione della cultura del vino, della sua convivialità, del suo stretto rapporto con la fantasia e la creatività. Una tradizione che continua, dope le passate adesioni di Simonetta Agnello Hornby, Michele Serra, Pino Cacucci, Vanni Santoni, Benedetta Cibrario, Ippolita Avalli e altri.
Gli oltre mille racconti sono stati valutati da una giuria, presieduta dalla signora Inge Feltrinelli, che ha ricordato come “il vino è la cultura di un popolo” e come “è bello leggere un libro, seduta in una comoda poltrona, sorseggiando un ottimo vino”, e composta dalla presidente Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano), Giulia Maria Crespi, che ieri sera ha rinnovato pubblicamente “l’importanza del paesaggio come risorsa economica e il ruolo della vite dei tanti e diversi territori del vino italiano”, Enzo Vizzari, direttore de Le Guide de L’Espresso, Maria Latella, direttore di A e conduttrice televisiva, Alessandro Regoli, direttore www.winenews.it, Franco Maria Ricci, presidente Ais Roma, direttore di Bibenda e Duemilavini, Giulia Pessani, direttore di Gentleman, Case & Country, Ladies & Gentleman, Slawka Scarso, consulente di marketing e comunicazione nel settore del vino, Paolo Soraci, capo ufficio stampa delle Librerie Feltrinelli, Lorenzo Biscontin, direttore marketing Santa Margherita.
Info: www.santamargherita.com, www.lafeltrinelli.it
Focus - Ecco i testi vincitori del Premio letterario Santa Margherita-Feltrinelli 2009
“Un bicchiere di parole” di Stefano Bianchi
“Sa, là di fronte ci abita un poeta... uno di quelli veri: gli hanno pubblicato diversi libri.” A queste parole il mio sguardo cadeva sulla loggia della casa di fronte, dove su un tavolo stavano una bottiglia vuota di vino e due bicchieri.
“Mi dispiace, non mi interessa la poesia.” Mentivo, ma non avevo intenzione di farmi vedere troppo entusiasta della casa che stavo comprando.
Da anni non mi addentravo così tanto in valle da incontrare questo paesino, indicato da un cartello arrugginito, fatto di case di pietra belle da toccare.
Ormai l’estate è scoppiata: da un paio di settimane mi sono ritirato in questo angolo ai margini del tempo. La vita scorre piano, leggo un libro, scrivo qualcosa, resto in terrazza ad aspettare che il fresco diventi un invito a una notte di riposo lontano dal lavoro, dalla città.
Il poeta ha ospiti, quasi tutte le sere. Non è un eremita triste come lo immaginavo. Spesso, dopo cena, qualcuno si presenta alla sua porta. Di solito è gente del paese: ieri c’era il macellaio, l’altra sera la giovane figlia della panettiera. Si siedono in loggia, il poeta sparisce qualche momento e torna con due bicchieri e una bottiglia di vino bianco, la apre con meticolosa calma, versa e si siede. Alle mie orecchie arriva un vociare confuso che mi riempie di curiosità. Gli ospiti parlano, molto più di lui, a volte si sente una risata. La figlia della panettiera invece ha pianto qualche minuto, ma quando poi se n’è andata, dopo averlo baciato come si bacia un nonno, sorrideva. Ho adorato i suoi versi, li ho letti, studiati. Ho scritto con passione la mia tesi di laurea su di lui e, quando dieci anni fa arrivai qui per incontrarlo, fui accolto con freddezza e allontanato con ostilità. Ne rimasi profondamente deluso. Lo odiai. Ci volle qualche anno perché i suoi versi si riappropriassero delle mie ore e rileggessi tutto ciò che di suo era stato pubblicato: la sua capacità di descrivere in modo semplice la complessità delle vite non riusciva a smettere di stupirmi. Ora aveva ottantadue anni. Pensai che negli ultimi anni si fosse ammorbidito, poi l’oste, che gli portava di tanto in tanto una cassa di pinot grigio di queste colline, mi disse che quando arrivò trent’anni fa divenne subito molto amato:
“Sapeva ascoltare e dispensare consigli saggi, alcuni l’hanno conosciuto per caso, poi la voce è girata... sa, la gente si fida di lui. È stato un aiuto importante per molti.” Domani dovrò tornare in città. Mi affaccio alla terrazza, vedo i bicchieri sul tavolino: il vecchio, stasera da solo, non appena mi scorge si alza e, con la bottiglia in mano, mi chiede se ho intenzione di lasciarlo bere da solo.
In pochi minuti sono al suo tavolo a osservarlo armeggiare con il cavatappi. Versando il vino mi chiede come fosse stata accolta la mia tesi di laurea. Resto muto dallo stupore: si ricorda di me. “Alla fine ho dovuto invitarla io - mi dice, dandomi del lei - in genere la gente si presenta senza avvertire invece lei se n’è stato lì a guardare per tutte queste sere.”
“L’avrei fatto con piacere, ma vede, nel nostro ultimo incontro ho avuto l’impressione di non esserle molto gradito.”
Sorride, quasi beffardo. “Deve sapere che io, in realtà, sono un vecchio egoista. Tutte le persone che ha visto non sono affatto venute a mani vuote, portavano un dono: un bicchiere di parole. Un bicchiere di parole per ogni bicchiere di vino. Lei è arrivato con un’armatura di domande: quando le chiedevo di lei, glissava. Come in questo bicchiere di vino lei scopre subito il profumo evidente della frutta bianca che però non le impedisce di coglierne, sullo sfondo, un sentore quasi speziato, così le parole che mi porta la gente mi svelano dapprima le loro storie e poi i colori delle loro anime. Con il suo silenzio lei mi voleva negare la vendemmia della sua vita. La mia poesia è il frutto di queste vendemmie serali, al fresco di questa loggia davanti ad una bottiglia che si svuota tra le chiacchiere.”
La Vigna Stregata” di Sebastiano Carron
To’, che ci fa quel grappolo, pensò. Interruppe le meditazioni a ruota libera che si stavano accavallando senza logica nella sua mente, concentrandosi su quella presenza, anomala in un vigneto già accuratamente vendemmiato: un bel grappolo di bacche bianche, solitario, intatto, non nascosto e all’apparenza perfetto. Lo lascio lì per scaramanzia, rispose una voce di uomo alla domanda muta che aveva posto a se stessa.
Sobbalzò emozionata, ma soprattutto ferita nella sicurezza di solitudine della quale si crogiolava in quel suo vagabondare agreste di un agosto fin troppo caldo. Si girò e, dal filare accanto, vide sbucare il suo interlocutore, un uomo né giovane né anziano, dall’aspetto cordiale e dagli occhi scuri e sorridenti. Buongiorno, rispose quasi intimorita, senza riuscire ad aggiungere altro. Non si preoccupi, rispose il suo interlocutore, sono solo il proprietario di questa vigna. Anziché rassicurarla, quella frase le suonò come una velata accusa di intrusione in uno spazio altrui. Me ne vado subito, sussurrò. No, resti pure, non c’è problema, ribatté l’uomo, anzi mi fa piacere trovare qualcuno che si interessa al mio lavoro. Fa il contadino?, chiese lei. Sì, si può dire così, ma preferisco essere definito produttore di vino. Questa è una vigna di pinot grigio, matura presto e la vendemmio per prima. Ma lascio sempre alla vigna uno dei grappoli migliori, per ingraziarmela per l’anno prossimo. Sono certo che capisce le mie intenzioni e le asseconda. Lei trovò assolutamente buffo quel discorso un po’ svitato e stava per interloquire, quando lui la invitò ad un assaggio. Vuole sentire come potrà essere il vino di quest’anno? Ne ho ancora della vendemmia passata; l’azienda è a due passi. Lei aveva sempre pensato alla campagna in termini di fattoria, mentre quella parola le ricordava invece una fabbrica, un laboratorio. La ritrosia ebbe il sopravvento sulla curiosità: Sarà per un’altra volta. Ora devo proprio andare, si è fatto tardi. Entrambi sapevano che era una scusa, ma tant’è. Quando vuole non si faccia scrupoli, replicò l’uomo, venga a trovarmi e tenga presente che il vino è amicizia, anzi amore, ha persino un suo fascino sensuale se lo si lascia parlare coi suoi profumi e il suo sapore.
Le parve una frase fatta e rifatta, quasi un segno di stizza per l’invito rifiutato e si innervosì. Con un insipido Buonasera, arrivederci, interruppe il discorso e si incamminò. Raggiunta la strada, non resistette alla tentazione di vedere che ne fosse stato del suo interlocutore. Si girò e lo vide mentre procedeva in direzione opposta alla sua. Fu invasa da un pensiero sgarbato e stupido e, quando l’uomo sparì per una stradina laterale, lei tornò sui suoi passi, raggiunse il grappolo e lo strappò dalla pianta. L’uva resistette un po’, ma alla fine cedette e cadde a terra. Compiuta quella sorta di vendetta postuma, anche se non sapeva bene rispetto a che cosa, la donna se ne tornò a casa. Quella notte non riuscì a dormire. Ogni volta che tentava di chiudere gli occhi, la prendeva una sorta di ebbrezza mista a nausea, come se fosse a bordo di una barchetta in un mare in burrasca anziché a letto. In più era tormentata da una parvenza di rimorso per l’inutile, irrimediabile e infantile violenza compiuta. La mattina si alzò a fatica, si trovò orrenda e, senza pensarci due volte, decise di tornare alla vigna anche se non ne sapeva il motivo. L’uomo era già sul posto e con il suo corpo copriva la pianta che lei aveva violato. Lo raggiunse, pronta ad autoaccusarsi e a scusarsi. Lui si girò e sorridendo le disse: Guardi, è proprio bello, sarà un’annata eccezionale. Il grappolo era ancora al suo posto, come se l’atto vandalico fosse stato un sogno anziché una realtà.
Stupita ma troppo stanca per pensare, lei rispose semplicemente: L’invito di ieri è ancora valido?
“Un sorso di magia” di Serena Stringher
Continuano a venire qui. Sera dopo sera, giorno dopo giorno.
Anno dopo anno.
Arrivano alla spicciolata, uno alla volta, come sorsi da un bicchiere che si vuole centellinare.
Siedono al mio banco, il lungo bancone rosso mogano che ho ereditato da mio padre trent’anni fa, e aspettano. I gomiti appoggiati sul legno scurito, i volti pensosi, tristi, distanti, i volti dolci, allegri, i volti rilassati con gli occhi che ridono : siedono e aspettano.
Me. Sono io, la vera ragione per cui si fermano, indugiano davanti alla vetrina fumosa accarezzata da un tralcio di vite, e varcano infine la mia soglia come acchiappati da un’antica malia. Stregati dalla melodia gorgogliante che guizza dentro alle bottiglie scure.
Entrano nella penombra del mio piccolo regno che profuma d’uva e di candele, di terra umida e di legna da ardere, inspirano a fondo e passeggiano intorno, sorpresi.
I loro sguardi si arrampicano sulle pareti ingombre di vini, sulle etichette dorate che riflettono le luci del tramonto, centinaia di formule magiche intrappolate dentro prigioni di vetro nero che fremono dalla voglia di essere liberate.
lo li osservo, a mia volta. Uomini e donne che non ho mai incontrato. Vecchie amicizie. Conoscenze che diventeranno presenze abituali: li scruto con i miei occhi verdi, in paziente silenzio. Vedo i loro volti distendersi, le rughe della fronte spianarsi, i sorrisi affiorare agli angoli della bocca come le bollicine sulla superficie di uno spumante. E’ questo il momento. L’attimo in cui ordinano un bicchiere.
lo faccio un cenno della testa, impercettibile. In piedi, nascosto dietro ad una patina di polvere, li ascolto chiedere un Cabernet, un Prosecco, uno spritz. Un Tocai, a volte, che anche se adesso si chiama Friulano per i miei coetanei resterà sempre Tocai. A volte qualcuno entra a festeggiare il figlio appena nato, la patente o il compleanno: sento allora la squillare la campanella e gridare “giro per tutti”, con la gioia che straripa frizzante dai loro polmoni.
Vedo i solitari sorseggiare i loro bicchieri in silenzio, persi nel folto dei loro pensieri. Mi piace spiare le coppie di innamorati, le loro dita che si intrecciano come le viti, sospese nell’aria, i palmi delle mani pieni di languide illusioni. Dalle loro bocche spillano baci dolci come gocce di passito.
lo aspetto. Paziente. Nella penombra in cui giaccio, dimenticato da trent’anni, attendo che qualcuno varchi questa soglia e chieda di me. Nel frattempo, guardo gli uomini e le donne che un sorso di vino rende più felici. Una magia spicciola, eppure accade sempre.
Sera dopo sera, giorno dopo giorno.
Anno dopo anno.
lo rimango qui, a chiamarli. E aspetto.
Qualcuno che ordini un Barolo del ‘67. Per un’occasione davvero speciale.
Focus - I testi degli “autori Doc”
“Le notti folli del vino nero” di Piersandro Pallavicini
Giorgio ed io siamo diventati amici negli anni del liceo e adesso che abbiamo superato i quaranta la nostra amicizia è più salda di prima. Andiamo d’accordo quasi su tutto, le nostre mogli dicono che più che amici sembriamo fidanzati. Eppure siamo capaci di discussioni accese e furibonde litigate. Per esempio su questioni semantiche. Oppure sui vini. Peggio ancora sulle due cose messe insieme. La nostra litigata più celebre? Quella su vino bianco e vino nero. È successo anni fa in una trattorietta, di fronte a un vino molto scuro. Finita la cena, sorseggiando l’ultimo bicchiere, io sostenevo che mentre l’aggettivo “bianco” potesse correttamente essere usato per i vini chiari - poiché certi sono così pallidi da sembrare incolori - l’aggettivo “nero” fosse invece inappropriato. Che fosse una distorta astrazione. Non esistono i vini neri, dicevo a Giorgio: anche questo, vedi - e mettevo il mio bicchiere controluce - benché spesso, benché scurissimo, è rosso di colore. E bisogna chiamarli rossi, allora. Giorgio rideva e diceva: no, nero invece è giusto, e si usa per affinità, per somiglianza. Diceva: ora stiamo bevendo solo un rosso molto scuro, è vero. Ma esistono vini proprio neri. Quella sera io gli avevo riso in faccia e lui, che si riteneva un filologo della scienza del vino, si era offeso mortalmente. La discussione era andata avanti per ore, con Giorgio che sosteneva questo: nel mondo si erano prodotti, e ancora si trovavano, vini non semplicemente rossi, ma autenticamente neri. Che sciocchezza, vero? Beh, si è trascinata per anni. Torna fuori regolarmente, una volta ogni paio di mesi: io che lo sfotto col sorrisino storto, lui che s’inalbera e cita romanzi, manuali antichi, poeti latini. Una discussione diventata classica, tra noi, specie di sera. Le notti folli del vino nero, le chiamano le nostre mogli. È per questo che stanotte sono qui da Giorgio e, lo ammetto, con una certa emozione. Il mio caro amico è appena tornato da un giro sul Caucaso: Georgia, Ossezia, quei posti sperduti e avventurosi. Lì, sostiene, per caso ne ha trovato. Ma sì, del vino proprio nero: come il carbone, la pece, le penne del corvo. Mi ha telefonato nel pomeriggio, non stava nella pelle. Vieni, ha detto, ce l’ho, è come la pece. Io l’ho sfottuto: sì, sarà la vicinanza col Mar Nero. E lui: vieni stasera e vedrai.
Così ora siamo giù nella sua cantina. Qui ha un paio di seggioline, poi solo scaffali pieni di bottiglie, scatoloni, e un vecchio baule che ci fa da tavolo.
Guarda, mi dice, e mi mostra questa vecchia bottiglia di vetro scurissimo, senza etichetta. È la vendemmia di tre anni fa, un vitigno autoctono. Non ne sò pronunciare il nome, ma significa questo: nero come la notte. Io rido. Lui sospira e stappa. Poi d’improvviso fa questo: spegne la luce. E cerca i bicchieri a tentoni e versa il vino. Lo posso sentire, dentro questo buio denso e assoluto. Rido: ah, spegni? Lo prendo in giro. Bella forza il tuo vino nero. Lui mi afferra la mano, la mette intorno al bicchiere. Assaggia, dice. Ma per piacere Giorgio! rido ancora. Assaggia e basta, insiste. E quando prendo il primo sorso sento sul palato le nuvole prima del tuono, la profondità di una fossa oceanica, l’opaco specchio della grafite. Allora, è nero oppure no? Questo mi chiede Giorgio, qui con me nel buio. Io scuoto la testa, anche se lo so che non può vedermi. Te lo posso giurare, mi dice, fidati: non è rosso scuro, non è violetto, è nero. E prendo un altro sorso, e sento la densità del petrolio, l’epilogo di un racconto di Poe, la formula di un incantesimo malvagio. E pare incredibile anche a me ma adesso annuisco nel buio. Giorgio ripete: fidati di me. È nero. E mi pare più incredibile di prima ma eppur gli dico: va bene, ti credo. Perché è così la nostra amicizia: emozioni vissute insieme, e un’inossidabile fiducia. Come qualsiasi amicizia vera, no? Scolo l’ultimo sorso, dico: ho finito. Dico: è proprio nero. E Giorgio può riaccendere la luce.
“Messaggio in bottiglia” di Martino Gozzi
Alla fine del prossimo mese, Paolo Gioachin - mio amico e sodale dai tempi delle superiori - convolerà a nozze. Una cerimonia sobria all’imbrunire, seguita da una cena con gli amici nel cortile di casa. Da quando gli inviti sono stati distribuiti, tutte le nostre vecchie conoscenze - compagni di scuola, ex fidanzate, amici persi di vista - hanno unito le forze per acquistare un regalo denso di significato, e organizzare lo spostamento fino a San Bartolomeo in Bosco con il minor numero di auto possibile.
Di tutto questo sono stato informato solo per telefono, purtroppo. Da qualche tempo mi trovo a Vilnius per lavoro, e so già che non riuscirò a essere presente al matrimonio: la Lituania è virtualmente al di fuori delle rotte internazionali. Questo significa che durante la cena non potrò alzarmi, tenere un breve discorso e proporre un brindisi, come sogno di fare da anni. Così, mi limiterò a raccontare questo aneddoto per iscritto, e chiedo a qualcuno - al nostro inseparabile compagno di avventure, Stefano - di darne lettura.
Dunque. Era la fine di maggio. Mancavano poche settimane alla maturità. All’epoca, Paolo mostrava già la calma e la saggezza di un insegnante di religione, Stefano aveva appena scoperto la passione per i motori, e io - be’, io guardavo decisamente troppi film. Sapevo che alla fine del liceo ciascuno di noi avrebbe preso strade diverse, e volevo che della nostra amicizia restasse qualcosa di memorabile. Così, da mesi insistevo perché seppellissimo una bottiglia di vino in qualche luogo remoto, simbolico. A distanza di anni, pensavo, saremmo tornati nello stesso luogo a riesumarla, per celebrare il passato. Esattamente come nel film Fandango, con Kevin Costner.
Ancora non sapevo, allora, che l’epopea hollywoodiana è difficilmente riproducibile nella vita di tutti i giorni. Nonostante la colletta, dovetti accontentarmi di una bottiglia di rosato, anziché il Dom Pérignon del film. In più, Stefano stabilì che il punto ideale dove interrarla sarebbe stata la golena del Po, che in quel periodo dell’anno era terreno di scontro tra bande rivali di motocrossisti. A nessuno dei tre balenò il sospetto che in caso di piena la bottiglia potesse essere sommersa dalle acque, o andare perduta. Un sabato sera ci mettemmo all’opera. Stefano prese il fuoristrada del padre, Paolo si dotò di una vanga e io mi studiai qualche battuta del film per dare maggiore solennità alla cosa. Parcheggiammo tra due salici, con i fari accesi. Poi, a turno, ci mettemmo a vangare, finché qualcosa di solido e compatto non ci impedì di proseguire. Fu allora che, con un brivido, ci accorgemmo del telo di plastica che affiorava dal terriccio smosso. “Ragazzi,” dissi, dimenticato Fandango, e con la mente già a Twin Peaks. “Qui c’è un cadavere.” “Sì,” confermò Stefano. “È molto probabile. Se gli hanno mozzato le dita, è una vittima della mafia russa.” Calò il silenzio, e restammo lì immobili per un pezzo.
“Ah,” disse Paolo, alla fine. “Lasciamo perdere, dai. Andiamo a casa mia a berci qualcosa.” Inspiegabilmente, nessuno obiettò. Gettammo la vanga nel bagagliaio e ripartimmo alla svelta, dimenticando il rosato. Arrivammo a San Bartolomeo dopo la mezzanotte, ma in cucina trovammo ancora un paiolo di trippa cucinata da sua madre per cena. Paolo scese in cantina e tornò con un vino imbottigliato dal padre - un vino casereccio, pungente, dolce e acidulo al tempo stesso. Il clinto. Non era la prima volta che lo assaggiavo, ma per la prima volta lo gustai.
La storia finisce qui, più o meno. Tornati al fiume, il giorno dopo, ci accorgemmo che il telo era solo uno dei tanti residui lasciati dall’acqua, ma ormai l’illusione cinematografica era svanita. E in fondo sono contento che sia andata così. Oggi, dopo tutti questi anni, non c’è nessuna bottiglia di champagne da riportare alla luce - non c’è nessun film da imitare - ma c’è qualcosa di nostro. Se fosse per me, adesso, saprei con quale vino brindare a questa nuova avventura.
“Vino” di Eva Cantarella
E’ bella la primavera a Mitilene, nell’isola di Lesbo. Il verde pallido degli ulivi si staglia contro il cielo blu, le coste dell’Asia, al di là del mare, sembrano così vicine che sembra di poterle toccate tendendo la mano. Alceo sente nell’aria il profumo delle viole: “vestita dei suoi fiori sentivo arrivare primavera: fate presto, di dolce vino riempite un cratere…”
E’ tornata la bella stagione, bisogna festeggiare. L’inverno è stato freddo, rigido. Può accadere, a Mitilene: ci sono anni in cui in gennaio, febbraio, le nubi si fanno minacciose, piene di acqua, il vento soffia forte, i fiumi si coprono di ghiaccio. Le giornate sono corte, durante i lunghi inverni, le serate sono lunghe e buie, Ma Alceo sa come affrontarle: “accendi il fuoco, versa senza risparmio vino di miele; fascia le tempie di morbida lana”. Il vino è un buon antidoto, non solo al freddo, anche al dolore: ”alle sventure non pieghiamo il cuore. A cosa serve mai, Bacchys, soffrire? Il farmaco migliore è il vino: su, beviamo…”. I momenti di marezza non mancano, nella vita di Alceo, e sono spesso legati alle alterne vicende della tumultuosa vita politica dell’isola. Alceo è un feroce avversario di Mirsilo, l’odioso tiranno, alleato dell’infame Dinomene e di Pittaco, il bastardo (“dai cattivi natali”, in un verso di Alceo). La lotta è pesante, gli avversari troppo potenti: per evitare la loro vendetta, Alceo è costretto a recarsi in esilio a Pyrra. Fino al giorno in cui, finalmente, “Mirsilo è morto, evviva, ubriachiamoci!”. Il vino è essenziale, nei festeggiamenti. Sono molte le occasioni in cui si beve vino, in Grecia. Il vino è socialità: si bene volentieri, in compagnia. A sera, nelle piccole città - poco più che villaggi - gli uomini si riuniscono, parlano, ascoltano la musica, guardano le ragazze ballare. Perché la festa cominci, è necessario il vino: “Perché aspettare le lampade? Di luce, ormai, resta soltanto un dito: prendi le grandi coppe decorate. Dioniso, il figlio di Semele e di Zeus, ha fatto dono agli uomini del vino, oblio dei mali. Mischia una parte d’ acqua e due divino, riempi le coppe, brinda…” Così Alceo. Circa una generazione più tardi (siamo nella seconda metà del VI secolo a.C) Anacreonte, di Teo, ricorda l’importanza del vino nelle battaglie d’amore: “Porta l’acqua, ragazzo, porta il vino, porta fiori in ghirlanda, porta tutto. Io voglio fare a pugni con Amore.” Ma è un uomo saggio, Anacreonte, sa che del vino si può fare buon uso e cattivo uso. Chi eccede, non si controlla e si ubriaca diventa fastidioso, irritante, volgare. Niente di male, a bere, anche in abbondanza. Ma senza esagerare: “Su ragazzo, fa presto, porta una coppa: unisci dieci mestoli d’acqua, cinque di vino. Voglio fare un baccanale, ma con misura. Non voglio né rumori né schiamazzi. Non facciamo una bevuta scitica!
Piccoli sorsi, in mezzi a canti belli.” C’è un galateo del vino, insomma, in terra greca: non bisogna mai sbronzarsi.
Teognide, nato a Megara attorno al 580 a.C., autore di in una sorta di manuale di buoni principi dedicato al giovane Cirno, insiste sull’importanza del controllo e della temperanza: “è così buono il vino, ma chi si ubriaca non mi piace.” Il che non significa, come è ovvio, che si debba rinunziare al piacere di bere. Ci mancherebbe altro. Ma “chi nel bere ha misura non è cattivo, è buono”. Teognide ne ricava una morale: “per gli uomini, sta tra due brutti estremi il bene: sete che spossa e sgradevole ubriachezza. Starò nel mezzo: non mi convincerai a bere troppo, ma neppure a non bere.” Come sempre, per i greci, il problema è la misura. Durante i celebri banchetti, il vino scorreva in abbondanza, si mangiava e ci di divertiva, per rallegrare i convitati venivano convocate flautiste e danzatrici…. ma non era il momento della baldoria.
Di lì a oltre un secolo, a ricordarlo è Platone. Durante un banchetto (raccontato nell’omonimo dialogo), mentre gli invitati discutono dell’Amore, ecco irrompere Alcibiade, come sempre eccentricamente abbigliato, che si regge a stento sorretto dalle gambe malferme. Ha bevuto, e subito chiede altro vino. Tra la riprovazione generale prende comunque posto tra i convitati, e quando inizia a parlare pronuncia un lungo, appassionato elogio di Socrate, ricordando tra che i tanti pregi del filosofo (di cui dichiarava di essere innamorato), sta la capacità di saper bere più di chiunque altro, senza mai ubriacasi. Alcibiade e Socrate, due esempi opposti: il cattivo e del buon uso del vino.
Copyright © 2000/2026
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026