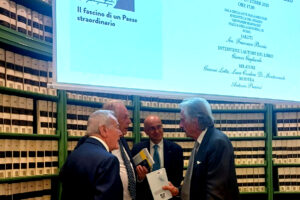L’unica certezza, quando si parla di qualità del vino, è che sembrano non esserci certezze. Perché se oggi, il dibattito della qualità, per molti, si divide in “bio e non bio”, “solforosa si, no, un po’”, in passato qualità ha voluto dire vino “genuino”, poi “tecnologico”, poi “barricato”, “internazionale”, “autoctono”, vino “dell’enologo”. C’è chi sostiene che la qualità del vino si giudichi ancora solo dal bicchiere, chi da quanto esprime il terroir, chi da quanto si identifica con la storia di chi lo produce, chi dice che non basta più e che la qualità è quella della cantina, dei metodi con cui lavora e interagisce con l’ambiente, con i lavoratori, con l’ecologia; chi aggiunge che la qualità è nella percezione del consumatore, nel mercato, che decide quali vini si vendono e quali no. Insomma, una varietà di punti di vista e metri di giudizio impossibile da sintetizzare, dove l’unica costante è quella del cambiamento. Perché la vita è mutevole, il vino fa parte della vita, e col tempo sono cambiati, cambiano e cambieranno i criteri per stabilirne la qualità. Emerge dal convegno “Il futuro del vino di qualità”, di scena oggi a Ca’ del Bosco, che nelle intenzioni è stato un “numero zero” di confronto tra diverse anime del mondo del vino, dai critici come Marco Sabellico (Gambero Rosso), Enzo Vizzari (“L’Espresso”), Franco Maria Ricci (Associazione Italiana Sommelier), Fabio Giavedoni (“Slow Wine”) e Ian D’Agata (International Wine Cellar), a produttori come Marco Pallanti (Castello di Ama), Maurizio Zanella (Cà del Bosco), Angiolino Maule (La Biancara) e Alexandre Chartogne (Chartogne Taillet), dai giornalisti ai blogger, per lanciare la volata ai tanto invocati, ma mai realizzati, “stati generali del vino italiano”. Al centro di tutto resta, comunque, il consumatore, che oggi, ha spiegato il professor Enrico Finzi, direttore di Astra Ricerche, è quasi “irritato dalla grandissima varietà dell’offerta e dall’insistenza del marketing. Vuole meno fumo e più arrosto, ovvero il prodotto”. A sintetizzare il concetto di qualità ci ha provato anche Serena Sutcliffe, Master of Wine e responsabile del vino per Sotheby’s, per la quale “tanti sono gli aspetti da prendere in considerazione, anche se il più importante è l’identità del vino”. Ma l’errore vero è cadere in dogmi, perché, come ha ricordato Michelle Bettane, tra le voci più autorevoli del vino nel mondo, “il diavolo è furbo, e cerca di convincere gli uomini che gli uni sono, in assoluto, migliori degli altri”.
Il tranello in cui si cerca di non cadere, per molti, è quello di rischiare di “nascondere” l’impegno sulla qualità dietro certe bandiere. Come quella del “bio” (gli ettari coltivati a vigneto in Europa e in Italia, per altro, nel 2011 sono diminuiti sul 2010, ndr), come ha spiegato Angiolino Maule, della cantina veneta “La Biancara”, che del vino naturale ha fatto la sua filosofia (tra i fondatori di Vinnatur), ma che non crede all’empirismo: “con i nostri eventi in parte finanziamo anche la ricerca, e per esempio abbiamo scoperto, anche grazie a collaborazioni con le Università, ch, nonostante 10 anni di coltivazione biologica, il terreno, che è fondamentale, è comunque messo male, e che sostanze come rame e zolfo, che lo inquinano, vanno eliminati o ridotti i più possibile”.
Per Marco Pallanti, alla guida insieme alla moglie Lorenza Sebasti di Castello di Ama, nel cuore del Chianti Classico, parlare di qualità vuol dire “iniziare a guardare il vino in maniera diversa, cosa che per altro fa i consumatore, che cerca anche altro, oltre che la bontà del vino. Interrogarsi sulla qualità del vino, oggi, vuol dire interessarsi dell’etica del vino, a come uno conduce il vigneto, a come si rapporta con l’ambiente e con il territorio, cosa fa dal punto di vista del miglioramento energetico e così via. Cose che il vino di qualità di domani deve essere capace di raccontate nel bicchiere. E questo si realizza con un approccio che non è di fede cieca nella scienza e nella tecnologia, ma neanche in un empirismo che si pseudo-scienza, in un “primitivismo” che, invece fa fare passi indietro su quello che è qualità. I produttori devono vedere il vino non solo come attività agricola, ma come “evento culturale”. Non esistono marchi o fascette che possano certificare la qualità, non è la Docg, questi marchi certificano l’appartenenza ad una famiglia “territoriale”, dentro la quale, però, c’è il buono ed il cattivo. Non dobbiamo nasconderci o arroccarci dietro a bandiere di fazioni contrapposte. Certi fini devono essere condivisi: avere terra fertile, avere un prodotto sano, usare meno chimica possibile sono obiettivi comuni a tutti quelli che fanno qualità. Ci si fanno domande cercando risposte anche nella scienza, così abbiamo ridotto o abbandonato pratiche invasive. Bisogna conoscere bene l’enologia, per poterne fare a meno”.
Per Maurizio Zanella, presidente di Ca’ del Bosco, “tra fazioni contrapposte di chi cerca di ridurre i trattamenti chimici il più possibili, e tra chi usa tutta la tecnologia possibile a disposizione, bisogna tenere presente che è sempre l’uomo che fa il vino. Perché il vino “naturale” non esiste, il mosto non curato diventa aceto”.
Nondimeno, “la discriminante della qualità non può essere solo prezzo - ha aggiunto Antonello Maietta, presidente Associazione Italiana Sommelier - anche se è un problema definirla, perché è nella percezione del consumatore, a cui arrivano tanti messaggi e input mutevoli da ogni dove.
Anche chi fa formazione, tratteggia la qualità secondo linee che però sono mutevoli nel tempo”.
Per Ian D’Agata (International Wine Cellar), “ci sono mode che via via hanno definito e orientato il concetto di qualità: la critica deve essere aperta ai cambiamenti, ma non cavalcare in maniere cieca una moda. Guardare al futuro, ma senza dimenticare lezioni del passato”.
Tra i critici c’è anche chi è più netto, come Franco Ricci (curatore di Bibenda): “La qualità è il marchio del produttore, e basta, non ci sono altri strumenti. Va spiegato che la Docg è marchio di origine, non di qualità. Il vino di qualità lo fa il produttore di qualità”.
Per Fabio Giavedoni, curatore di Slow Wine, “il gusto viene modificato, anche la percezione e il concetto di qualità cambia con il tempo. Noi, valutando le cantine anche per come lavorano abbiamo, intercettato una esigenza del pubblico, ma tra “pulito” e “giusto” la cosa più importante resta il “buono”. Ogni produttore deve fare il vino che vuole, ma va ridefinita la “grammatica della qualità”, che se da un lato non è in grado di esprimere in modo inequivocabile il positivo di un vino, può almeno definirne i difetti, che dobbiamo comunicare all’esterno. C’è chi ci chiede anche di cambiare i paradigmi degustativi, ma alcuni punti fermi servono”.
Per Marco Sabellico, curatore della guida del Gambero Rosso, “parlare di qualità vuol dire parlare anche di sostenibilità. I consumatori del mondo, oggi voglio salubrità, autenticità, fedeltà ad un territorio. Sono questi gli argomenti su cui riflettere”.
Per Enzo Vizzari, direttore della guide de “L’Espresso”, il vino di qualità è quello che”bevendolo ti da un’emozione. Ci sono elementi negativi oggettivi, come troppa volatilità, ma anche soggettivi. Ma anche essere totalmente laici nell’approccio: a parlare deve essere il bicchiere”.
Per Michel Bettan, una della voci più ascoltate della critica enologica mondiale “potremmo parlarne per giorni e giorni di cosa è qualità. Non tutti apprezziamo i sapori allo stesso modo, non tutti abbiamo stessi gusti, ma questo non impedisce di trovare, però, una grammatica comune per parlarne. Non dimentichiamo che il vino non esiste come vino di qualità, esiste se è apprezzato, se è nel commercio, se la gente lo compra e può berlo. Oggi molti bevono del buon vino, mentre in passato vino il buono era poco e bevuto dalle elite, oggi il buono è democratico. La guida migliore si dice che sia quella che non guida, ma la cosa importante è confrontare le opinioni, essere aperti al dialogo”. A tirare le conclusioni ha provato Serena Sutcliffe, Master of Wine e responsabile settore vino per la casa d’aste Sotheby’s: ci sono tantissimi elementi da considerare per parlare di qualità di un vino, che poi è diversa anche a seconda dei luoghi. Se qui è più associata al gusto, in Oriente per esempio è più legata all’immagine. Forse il vero elemento che distingue il vino di qualità è l’identità del vino stesso: un vino tecnicamente corretto è buono ma banale, un vino identitario esprime la grandezza del produttore che lo produce. Ciò detto, serve un dibattito franco, aperto ma senza animosità. Anche perché la posta in gioco è alta: vino vuol dire cura del territorio, dell’ambiente, del clima, dell’economia, di posti di lavoro”.
Focus - Gli orientamenti del consumatore italiano per Enrico Finzi (Asta Ricerche)
“Il 58% degli italiani, dati giugno-luglio, pensa che la crisi sia destinata a durare ancora 2-3 anni almeno, e molti pensano che comunque non si tornerà mai ai tenori di vita di prima. E in questo contesto cambia anche l’approccio al vino, secondo alcuni macro-trend. Molti cittadini italiani di fascia medio bassa e bassa di reddito, hanno tagliato il vino perché non se lo possono permettere più (18%), ed era già un consumo di “vini da battaglia”, di prezzo medio basso o basso;
c’è insofferenza per l’esorbitante vastità dell’offerta. Per il consumatore ci sono troppe marche, è il caos, non un’opportunità di scelta. Dal lato della domanda avremo selezione darviniana, non ci sarà posto per tutti;
c’è un grande ritorno alla “sostanza” del prodotto: c’è insofferenza nel troppo marketing, più arrosto e meno fumo, c’è insofferenza su pubblicità, sulla retorica delle retro etichette, del modo di presentare il vino in certi ristoranti ed enoteca;
torna ad essere molto importante anche l’olfatto, il profumo come criterio di apprezzamento;
sul “bio”: non c’è dubbio che il termine bio abbia avuto una crescita forte, in relazione non a scelte di carattere ideologico, ma ad una sensibilità “banalizzata di massa”, a favore del recupero di naturalità. Ma tendenze è una tendenza che inizia a dare segni di stanchezza per questi motivi:
- “todos caballeros”: lo fanno in tanti, non c’è più distintività;
- il consumatore non da credibilità agli enti di certificazione;
- problema di prezzo: il rapporto tra qualità percepita e prezzo non è più bilanciato, anche nella fascia medio alta e alta;
Non illudiamoci che con la comunicazione si possa invertire questa tendenza. Ai diversi livelli di prezzo, ci saranno meno operatori di successo, e molti “drogati” dalla crescita dei consumi del boom economico e del prestigio del consumo di vino (da alimento a bevanda di prestigio) spariranno. Molti prodotti sono stati venduti a prezzi esorbitanti per il consumatore, che oggi ritiene e vuole poter acquisire qualità a prezzi più bassi. E anche nella fascia alta, alzare il prezzo non garantisce più vendere meglio come è successo in passato”.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025