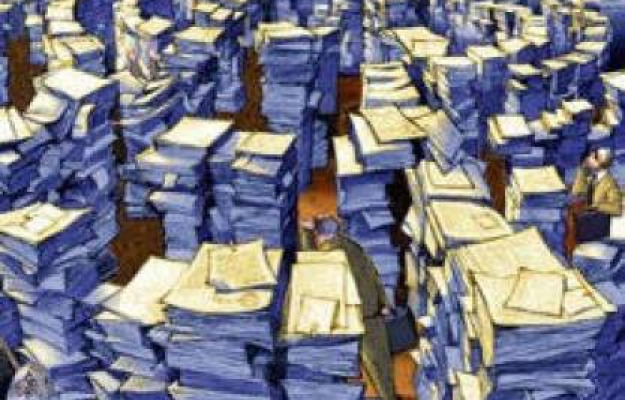Quasi la metà dei vigneti del mondo sono nell’Unione Europea dove si produce e consuma il 60% del vino del mondo. Ma il Vecchio Continente non è solo la più grande regione enoica e il principale importatore ed esportatore, ma anche un mercato altamente regolamentato.
Perché? Se lo sono chiesto gli autori della ricerca “La politica economica dei regolamenti europei sul vino”, dell’American Association of Wine Economists (Aawe), che assume come tesi centrale la diretta influenza dell’economia sul meccanismo che ha generato, fin dall’inizio, l’assetto delle norme che regolano il vino nella Ue. In Europa, l’intervento normativo comunitario assume molte forme: determina dove alcuni vini possono essere prodotti e dove no, la distanza minima tra viti, il tipo di viti che possono essere piantate in alcune regioni, e così via.
Ma i regolamenti determinano anche le sovvenzioni a disposizione dei produttori comunitari, gli aiuti economici per l’estirpazione dei vigneti esistenti e impone un limite alla messa a dimora di quelli nuovi, fino a finanziare la distillazione del vino in eccesso. Una gran mole di regole che non è sempre stata efficace nella risoluzione dei problemi, e potrebbe aver contribuito anche a creare alcune distorsioni nel comparto. Solo per esemplificare, negli ultimi tre decenni, ogni anno sono stati avviati alla distillazione dai 20 ai 40 milioni di ettolitri (pari ad una quota del 13-22% del vino prodotto nella Ue), l’equivalente di 3-6 miliardi di bottiglie (dati Eurostat 2013). Molti studi della stessa Commissione Europea sul comparto vino individuano, nella distillazione, una misura che non è né efficace né efficiente per eliminare le eccedenze strutturali, comportando invece per la Ue una spesa troppo elevata rispetto al risultato. Il supporto al reddito a breve termine crea infatti una stabilizzazione del surplus a lungo termine, con l’aggravante che il perdurare della misura per la distillazione potrebbe incentivare la produzione di alcol industriale a scapito di quella di vino.
Più di 2.000 fra regolamenti, direttive e decisioni sul vino sono stati pubblicati nella Ue a partire dal 1962, e buona parte di questo articolato sistema legislativo è direttamente riconducibile alle logiche contenute nelle normative francesi introdotte tra la fine del XIX secolo e i primi anni del XX secolo: regolamenti di qualità, come il sistema delle Aoc, introdotti per proteggere i produttori storici, come i ricchi proprietari terrieri di Bordeaux , da imitazioni e sofisticazioni; regolamenti di quantità, come le restrizioni di impianto, introdotti per proteggere i produttori dalle importazioni di vino a basso costo. Un paio di esempi chiariscono questa impronta decisiva, impressa dalla Francia al resto dell’Europa: nel 1970, la forte crisi di sovrapproduzione scatenò le pressioni dei produttori francesi perché venissero introdotte norme di controllo produttivo per la Ue nel suo complesso, così come, nel 1931, i produttori di vino del sud della Francia (minacciati dall’afflusso dei vini algerini) fecero pressione sul governo francese per la promulgazione dello “Statut Viticole”, sulla regolamentazione della produzione. Nel 1976 i produttori francesi (minacciati questa volta dall’afflusso in patria dei vini italiani) misero sotto pressione il loro Governo perché imponesse alla Ue una maggiore regolamentazione sulle produzioni di vino comunitario.
Le politiche legislative europee, quindi, hanno cercato di regolamentare quantità, prezzi e qualità del vino, ma i regolamenti di quantità e di prezzo possono essere compresi solo da un punto di vista politico, cioè analizzando l’intensità delle pressioni politiche sul processo decisionale Ue. Il loro scopo primario, infatti, è quello di ridistribuire risorse dai (potenziali) nuovi produttori di vino e dai consumatori ai produttori esistenti.
In un ambiente caratterizzato da un’informazione asimmetrica tra produttori e consumatori, cioè dove i consumatori hanno informazioni imperfette sul prodotto, come nel caso del vino, i regolamenti comunitari garantendo una certa qualità e/o una certa informazione di base sul prodotto, possono migliorare il benessere complessivo. Allo stesso modo, le norme che vietano l’uso di sostanze malsane possono aumentare il benessere dei consumatori , riducendo e/o eliminando i problemi di informazione asimmetrica. I regolamenti di qualità riguardano anche la distribuzione del reddito: a seconda della loro attuazione, infatti, possono creare rendite per determinati gruppi di produttori che devono affrontare minori costi di attuazione di determinate norme di qualità e per coloro che hanno accesso a risorse o competenze chiave richieste dalla normativa. Ad esempio, le normative che limitano la produzione di alcuni tipi di vini (costosi) di una determinata regione, potranno portare benefici ai proprietari di quelle aziende e danneggeranno i proprietari di terreni e vigneti delle zone limitrofe. Altre norme di qualità sui vini europei hanno forti effetti distributivi sul reddito in quanto richiedono l’accesso a beni molto specifici, come appezzamenti di terreno in regioni specifiche. Altri esempi di norme di qualità con chiari effetti distributivi sono quelle in cui non vengono consentite determinate tecniche, come l’uso di vitigni ibridi, la miscelazione di vini diversi, e così via.
Quando i regolamenti sono stati introdotti principalmente per ragioni di efficienza hanno sempre creato guadagni per circoscritte categorie e indotto lobbying per mantenere questi regolamenti in vigore anche dopo che i loro effetti di efficienza si erano attenuati. Insomma, per capire la dinamica interna dei regolamenti comunitari di quantità e di qualità, è fondamentale guardare le interazioni tra aspetti politici ed economici dei regolamenti stessi: quasi sempre queste norme sono state introdotte per proteggere rendite economiche esistenti, quando queste realtà sono state minacciate dall’innovazione o dall’aumento delle importazioni di vino in Europa.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025