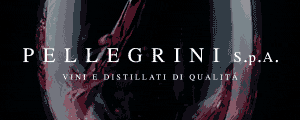Il vino italiano domina incontrastato sui mercati internazionali dove resta il più venduto. Ma arrivano anche dei dati dei primi mesi del 2012, che fanno registrare un decremento dell’export del 7% sul 2011. A fare da sfondo al Congresso Assoenologi n. 67 (in tutto mille partecipanti), dal 3 al 7 giugno, a bordo della “Costa Atlantica”, in navigazione da Savona verso Ibiza, ci saranno anche questi numeri ad accompagnare la discussione dell’organizzazione di categoria che rappresenta i tecnici vitivinicoli italiani.
Gli “hot spot” Assoenologi sono gli effetti dei cambiamenti climatici sulla produzione vinicola, la crisi economica, i successi dell’export, le difficoltà di fare impresa in Italia e la necessità di razionalizzare i costi senza ledere la qualità.
Tre sessioni di lavoro: la prima riguarderà “I cambiamenti climatici: ripercussioni e rimedi in vigneto e in cantina” di cui parleranno, Luigi Mariani, docente di meteorologia all’Università degli studi di Milano, Giuliano d’Ignazi, direttore tecnico di Terre Cortesi Moncaro, Riccardo Cotarella, docente di viticoltura e enologia all’Università di Viterbo. Negli ultimi anni le brusche mutazioni del clima hanno costretto gli enologi a correre ai ripari e cercare nuovi rimedi sia in vigneto che in cantina. Il surriscaldamento globale, però, non costituisce unicamente una minaccia, ma potrebbe rappresentare anche una opportunità.
Nella sessione dal titolo “Le aspettative e le difficoltà di chi produce e chi vende”, invece, il direttore di Assoenologi, Giuseppe Martelli, presenterà la fotografia del settore vitivinicolo italiano con gli ultimi dati disponibili. Malgrado il crollo dei consumi interni, passati dai 45 litri pro-capite del 2007 ai 42 litri dello scorso anno, segnando un calo del 7,3%, l’export continua a tenere. Il vino italiano rimane quello più venduto sui mercati internazionali consentendo alle vendite all'estero di registrare nel 2011 un incremento del 12% in valore e del 9% in volume rispetto al 2010. Nel 2012 tuttavia le cose si annunciano più difficili.
Delle difficoltà di chi esporta oltre il 50% della propria produzione e di quali potrebbero essere le prospettive future, parleranno Ettore Nicoletto, amministratore delegato del gruppo Santa Margherita e Sergio Dagnino, direttore generale Caviro. A minare questo momento positivo per l’export italiano possono infatti essere i nostri tradizionali punti di debolezza, fra questi, la frammentazione della produzione, l’eccesso di denominazioni e l’assenza di una “unica cabina di regia” che massimizzi gli sforzi di tante realtà imprenditoriali.
La terza sessione del Congresso Assoenologi sarà dedicata al tema della razionalizzazione dei costi: in un momento di grave crisi economica che tocca tutti i comparti e di aggravio dell’imposizioni fiscali per le aziende, con l’introduzione dell’Imu - la nuova imposta municipale propria - sui fabbricati rurali e i terreni agricoli, il lievitare dei prezzi energetici e lo spettro dell’aumento dell’Iva, il ruolo dell’enologo e la sua capacità di tagliare lì dove è possibile, senza ledere la qualità del vino, appare strategico. A parlarne, proponendo alcune soluzioni in vigneto e cantina saranno Luigi Bonato, Paolo Peira e Enrico Zanoni, rispettivamente direttori di Evoluzione Ambiente, Antesi e Cavit, una delle più grandi aziende cooperative italiane.
Info: www.assoenologi.it
Focus - Autori e abstract delle relazioni che saranno discusse da Assoenologi
“Clima tecnologia e mercati che cambiano: comprenderne le dinamiche per essere sempre più competitivi” è il titolo generale del Congresso nazionale di Assoenologi, che sarà sviluppato in tre sessioni per complessive nove relazioni.
Luigi Mariani, docente di agrometeorologia all’Università degli studi di Milano: “Caratteri macroclimatici e mesoclimatici: come e perché”
Sarà innanzitutto analizzato il concetto di macroclima, inteso come clima di grandi aree, soffermandosi in particolare sui grandi macroclimi europei di interesse viticolo (oceanico, mediterraneo, montano). Mentre le viticolture francese e tedesca si svolgono in climi oceanici quella italiana si svolge in climi mediterranei ovvero in climi di transizione fra quello oceanoco e mediterraneo caratterizzati da regimi pluviometrici equinoziali e cioè con massimi di piovosità primaverili e autunnali. Regimi equinoziali sono ad esempio caratteristici delle viticolture del bacino padano. In tale quadro sarà svolto un approfondimento sulle relazioni esistenti fra macroclimi ed areale viticolo globale ed europeo evidenziando storia, attualità e tendenze di tali areali in relazione al clima ed alla sua evoluzione. Verrà poi analizzato il concetto di mesoclima inteso come clima di areali più ridotti rispetto a quelli indagati a livello macroclimatico. In tal senso è ad esempio da considerare come mesoclima il clima di medi e grandi bacini fluviali o lacustri (come ad esempio il clima padano e insubrico) oppure il clima di una ambito viticolo relativamente omogeneo (come quello del versante vitato della Valtellina o del Vallese). Gli esempi riportati metteranno anche in luce la relativa refrattarietà del mesoclima a un inquadramento sistematico e il dibattito che su tale concetto è oggi in atto.
Riccardo Cotarella, docente di viticoltura ed enologia all’Università degli Studi di Viterbo: “Considerazioni e proposte tecniche in vigneto”
Il riscaldamento climatico globale ha e avrà certamente un impatto crescente sul vigneto italiano. Infatti, gli effetti diretti (temperature, precipitazioni, concentrazione di CO2, radiazioni solari) e gli effetti indiretti (gestione delle risorse, efficacia energetica, accettabilità da parte del consumatore) modificheranno l’intera industria del vino. L’enologo deve confrontarsi con le bizzarrie climatiche degli ultimi anni e spesso accade che nelle ultime settimane che precedono la raccolta, talvolta tra colleghi ci si trovi a discutere su che tipo di uve ci troveremo di fronte, proprio in virtù delle condizioni climatiche. L’enologo deve prima di tutto comprendere gli effetti che il fenomeno può avere sull’uva ed essere pronto a prendere le contromisure del caso. Inevitabilmente egli deve rivisitare e rivedere i protocolli di lavoro, in funzione di un cambiamento radicale di uno degli elementi più importanti e allo stesso tempo non gestibile né tantomeno prevedibile in tempo utile: il clima. L’effetto di tutto questo potrebbe condurci a riconsiderare ciò che fino a ieri sembrava scontato, e spingerci a un capovolgimento delle valutazioni degli elementi che determinano la qualità; non più zone calde e aride ma anche fresche e ventilate; non più terreni eccessivamente sciolti e permeabili bensì ricchi di buone percentuali di argilla, che costituisce una riserva idrica per le estati siccitose. Per non parlare delle esposizioni, privilegiando quelle di tipo nord o nord-est quando solo qualche decennio fa erano destinate alla produzione di uve di media-bassa qualità. Ma è soprattutto nelle pratiche di gestione della vegetazione e del frutto della vite che l’enologo deve e può trovare le giuste soluzioni.
Giuliano d’Ignazi, direttore tecnico Terre Cortesi Moncaro; “Considerazioni e proposte tecniche in cantina”
L’enologo in questi ultimi anni si è trovato sempre più spesso di fronte a scelte molto impegnative per il raggiungimento degli obiettivi di cantina in conseguenza di una materia prima fortemente influenzata da cambiamenti climatici molto pronunciati dovuti fondamentalmente ad un riscaldamento climatico globale. Quanto detto oltre ad un aumento delle temperature ha modificato il regime delle precipitazioni con una minore distribuzione delle piogge durante l’anno e aumento della loro intensità, maggiore frequenza delle grandinate nonché aumento della ventosità. Questi cambiamenti climatici interferiscono sia sulla composizione delle uve che sulla loro integrità da malattie e parassiti. I problemi più ricorrenti del cambiamento climatico sono dovuti a: un’eccessiva concentrazione zuccherina delle uve, riduzione degli acidi organici delle uve e innalzamento del ph, modificazione del potenziale aromatico, modificazione del tenore e tipologia di sostanze azotate nei mosti. Il tecnico dopo avere applicato le contromisure in vigneto deve impostare la strategia delle pratiche di cantina per fronteggiare composizioni delle uve inconsuete e le sue scelte iniziano con la raccolta delle uve in funzione della varietà e del vino che deve ottenere. L’enologo ha la possibilità di adottare varie soluzioni tecniche per affrontare le problematiche sopra menzionate tramite interventi di tipo fisico, microbiologico nonché l’impiego di coadiuvanti e additivi. Questi interventi possono essere appli-cati nelle varie fasi del processo produttivo dalla lavorazione delle uve, fermentazione, affinamento dopo la fermentazione e maturazione. I risultati ottenuti saranno diversi a seconda della fase di lavorazione in cui vengono applicati.
Giuseppe Martelli, direttore generale Assoenologi e presidente del Comitato Nazionale Vini del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali: “La fotografia del settore vitivinicolo italiano”
Non si può parlare della realtà vitivinicola italiana senza prima avere un quadro di quella mondiale. La superficie viticola del pianeta si sta contraendo tanto che, solo dal 2010 al 2011, ha perso l’1,2%, con incidenza negativa in tutti i tradizionali paesi europei produttori e con una situazione altalenante nei diversi continenti in generale e nelle cosiddette realtà emergenti in particolare. La situazione italiana della superficie vitata, negli ultimi trenta anni, ha fatto registrare un decremento del 44%. Giocoforza che anche la produzione di vino nel nostro Paese si sia contratta passando da 52,1 milioni di ettolitri (media 1992/2011) a 44,4 milioni di ettolitri (media 2007/2011). Per alcuni questo è un dramma per altri un bene visto che è inutile produrre quello che il mercato non vuole e oggi assai pericoloso produrre male, nella convinzione che la qualità deve essere garantita in tutte le fasce di prezzo e di consumo. Ma i consumi ed i mercati, in particolar modo quelli internazionali, stanno bene e il vino italiano rimane il più venduto anche se non ancora con i valori aggiunti sperati. Sta di fatto però che il 2011 si è chiuso con un incremento del 12% in valore e del 9% in volume rispetto al 2010 anche se con un prezzo medio al litro aumentato di solo il 3%, passato da 1,77 a 1,83 euro. Purtroppo, i dati dei primi mesi 2012, come del resto era previsto, fanno registrare un decremento di vendite del vino italiano all’estero di circa il 7%, ma con un aumento dei valori di oltre il 3% rispetto allo stesso periodo del 2011. In questo contesto non saranno sottovalutati i consumi interni che l’Assoenologi stima che nel 2012 scenderanno a 40 litri pro capite contro i 45 del 2005. In Francia il consumo a persona, in base ai dati Oiv, è di 47,4 litri pro capite, in Portogallo a 42,6, in Germania a 24, in Argentina a 23,9 e in Spagna a 21,8.
Ettore Nicoletto, amministratore delegato del gruppo Santa Margherita: “Le criticità e le prospettive di chi esporta oltre il 50% della propria produzione”
Pur con tutte le sue contraddizioni, pur con l’eccesso di denominazioni e di offerta, pur con l’eccesso di frammentazione che lo contraddistingue, il sistema del vino italiano ha saputo raggiungere negli ultimi due anni tra-guardi di assoluta rilevanza. Guardiamo al Nord America che assorbe un quarto delle nostre esportazioni, poco più di un miliardo di euro, crescendo persino a due cifre nella componente statunitense, sebbene vi operino tutti i produttori mondiali, vi sia una forte quota di produzione interna e permanga la debolezza del dollaro. Certo, il sistema vino gode oggi anche delle chance offerte dalla nuova Ocm che sta riversando molti milioni di euro per la promozione nei mercati extra-Unione Europea. Il fatto che stia riuscendo a sfruttarli appieno in tutte le diversi componenti - comprese quelle tecniche dell’espianto e delle vendemmie verdi - è un altro tassello di quelle best practices che il mondo del vino oggi riesce a garantire. Cosa può minare, però, questo momento così positivo? Il perpetuarsi dei nostri tradizionali punti di debolezza quali la frammentazione della produ-zione che può impedire una complessiva crescita imprenditoriale di molte cantine. E ancora: una certa apatia nel presentarsi al pubblico non soltanto come costruttori di suggestioni, ma anche e soprattutto come imprese e imprenditori, un gap questo che impedisce una efficace difesa di questo strategi-co settore nei luoghi decisori dell’economia e della vita pubblica italiana.
Sergio Dagnino, direttore generale Caviro: “Le criticità e le prospettive di chi esporta oltre il 50% della propria produzione”
L’incrocio del numero di etichette presenti in ogni fascia prezzo e la tipologia dei punti vendita (iper, super, superette) evidenzia rotazioni in termini di acquisti settimanali che poco hanno a che fare con il settore dei “fast consumer goods”. L’approccio della Grande Distribuzione responsabile e, nel contempo, vittima della suddetta degenerazione, porta a privilegiare in moltissimi casi il guadagno da “listing” di inserimento piuttosto che da sane rotazioni a scaffale. Ma trattandosi spesso di etichette di fantasia (un-branded) le rotazioni a scaffale devono essere sostenute con promozioni che deprimono il margine di produttore e distributore e, alla fine, non possono che disorientare il consumatore (probabilmente in maniera voluta). E che dire della ristorazione dove sono molte le bottiglie che arrivano ai ta-voli con caratteristiche organolettiche a dir poco imbarazzanti? Essendo questa l’arena competitiva, per molti il margine diventa, non più il risultato di una sana strategia di marketing e di approccio al consumatore, ma il fine ultimo a cui sacrificare etichette, disciplinari e aspetti qualitativi. Ne discende quindi che se veramente si vogliono attrarre i giovani al piacere di pasteggiare con un buon vino (e il “wine bar” non è proprio ciò di cui si parla), la garanzia di qualità e il giusto “valore” devono essere un prerequisito. Il vigneto Italia non potrà sopravvivere se non vi sarà un adeguato ricambio generazionale e se, contemporaneamente, i mercati esteri di sbocco non saranno “tutelati”.
Luigi Bonato, direttore Evoluzione Ambiente: “Come ottimizzare i costi in vigneto”
La scelta della meccanizzazione dei vigneti non deve essere concepita come un male necessario, a scapito della qualità; al contrario, se opportunamente ragionata ed effettuata con attrezzature idonee e rispettose della pianta può costituire un aiuto effettivo al viticoltore in quanto consente di intervenire tempestivamente, più velocemente e con risparmi economici non indifferenti. In questo caso, il vigneto, va progettato in questa direzione, in particolare per la scelta dei materiali e per lo studio di tutti i parametri connessi all’impianto. La maggior parte della razionalizzazione dei costi nel vigneto passa quindi attraverso il processo della meccanizzazione delle diverse operazioni colturali dei vigneti in produzione, tra queste possiamo ricordare: potatura, defogliazione, cimatura, diserbi, trattamenti fito-sanitari e vendemmia. Il resto del percorso organizzativo riguarda la corretta gestione dei lavori manuali dei primi 3-4 anni di allevamento della vite. Oggi la meccanizzazione spesso è ancora vista come una imposizione economica e non un’alternativa di gestione: attualmente si possono gestire tutte le operazioni colturali del vigneto ricorrendo alla meccanizzazione delle stesse, senza l’ausilio di operazioni manuali. Per avere la massima efficienza dell’impiego delle macchine in viticoltura e la quantità/qualità di prodotto desiderate, è necessario progettare l’impianto del vigneto in funzione di tali obiettivi. Nei vigneti meccanizzati si possono raggiungere livelli di sanità e qualità delle uve non ottenibili con una gestione manuale dei lavori, ma questo si ottiene con una meccanizzazione integrale e non a “spot” della viticoltura.
Paolo Peira, direttore di Antesi: “Come gestire le operazioni di cantina abbattendo i tempi”
Il vino continua a rappresentare, per il Made in Italy, uno dei prodotti più significativi. Un’importanza che supera i confini della contabilità economica per divenire immagine, stile di vita, modello da imitare su scala globale. La redditività economica per un’impresa vitivinicola è diventata negli ultimi anni la sfida per molti produttori. É chiaro che questa si vince da un lato incrementando il fatturato e dall’altro razionalizzando i costi di produzione, senza però stabilire alcun compromesso con la qualità dei vini prodotti. In questa fase, sotto il profilo tecnico, l’enologo in primis deve porsi la seguente domanda: fino a che punto si possono comprimere i costi di produzione senza per questo pregiudicare la qualità? e ancora, conosciamo fino in fondo tutti gli strumenti che ci possono consentire di contenere i tempi e i costi di produzione, in vigneto come in cantina? L’enologo, fino a ieri responsabile soltanto degli aspetti legati alla produzione del vino, può quindi rappresentare un punto di forza per la propria azienda, risultare indispensabile, contribuire alle scelte strategiche, gestionali e produttive, a condizione di essere aggiornato sulle numerose possibilità che oggi il mercato mette a disposizione.
Enrico Zanoni, direttore generale Cavit: “Principali aspetti della gestione di un’azienda produttrice di vini di qualità e di larga commercializzazione in Italia e all’estero”
In qualità di direttore generale di una delle più grandi cooperative italiane operanti sia sul mercato nazionale che su quello estero, egli farà una serie di riflessioni, con particolare riferimento alla razionalizzazione negli acquisti dei materiali di consumo, nei costi commerciali e nelle sinergie tra i vari comparti ed uffici, sempre con l’obiettivo di definire e comprimere i costi generali di produzione. In questo caso l’intervento è particolarmente prezioso in quanto scaturito da chi possiede una visione globale dell’intero processo produttivo. Occorre infatti avere particolare conoscenza del mercato e soprattutto coscienza dei propri marchi, in termini di potenzialità e limiti. Un particolare riferimento verrà riservato alla pianificazione, intesa come l’unico valido strumento per raggiungere gli obiettivi preposti ed evitare spese inutili e gravose. La pianificazione, a medio-lungo termine, rappresenta lo strumento gestionale con cui si integrano le esigenze di mercato alle possibilità produttive dell’azienda, in termini di quantità e qualità. La pianificazione a breve termine consente invece di armonizzare la piani-ficazione di lungo periodo alla domanda attuale e contingente del mercato. Lavorando in maniera concreta e fattiva su entrambe le pianificazioni si possono soddisfare e raggiungere gli obiettivi della riduzione del fabbisogno finanziario, dell’ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro, nell’ottica comunque del mantenimento della qualità del prodotto.
Focus - Il presidente Assoenologi, Giancarlo Prevarin: “i sì e i no sul comparto viticolo del Bel Paese”
Positivo il fatto che le istituzioni abbiano accolto l’invito di Assoenologi lanciato a Venezia nel Congresso del 2008, quando denunciò che ben 21 enti sono deputati ai controlli e che spesso capitano in cantina squadre di entità diverse per controllare le stesse cose. Oggi questo problema è stato quasi completamente risolto. Parere positivo anche sul lavoro svolto dal Ministero delle politiche agricole, per arrivare ad avere dati certi sulla produzione di Dop e Igp. Senza conoscere la consistenza del vigneto e della cantina Italia, come può il settore studiare strategie, ipotizzare controlli, impostare piani di vendita? Sarebbe come costruire un palazzo senza planimetria. Un particolare plauso al Ministro Mario Catania e al Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo Paolo De Castro per la battaglia che stanno conducendo per mantenere i diritti d’impianto, la cui riconferma è da sempre auspicata da Assoenologi. Sul piano della formazione sì di Assoenologi al Direttore Generale dell’Istruzione tecnica Raimondo Murano per il riordino della struttura formativa degli Istituti di viticoltura ed enologia e per il fatto che le Università che possono formare l’enologo siano state ridimensionate nel numero e accresciute in operatività e finalità, nella convinzione che il settore vitivinicolo italiano ha bisogno di diversi livelli di professionisti che però devono essere formati in modo adeguato e all’altezza delle richieste delle imprese.
No di Assoenologi alla piega che ha preso la concertazione tra Ministero e Conferenza Stato-Regioni, in cui spesso si scaricano tensioni che nulla hanno a che vedere con i provvedimenti in discussione e che comportano tempi lunghissimi di decisione anche per questioni semplici. Preoccupazioni sul fatto che vengano assunti localmente provvedimenti e decisioni operative diverse, creando difficoltà e tensioni. Forte critica alle norme nel settore vitivinicolo che, molto spesso, hanno interpretazioni disomogenee sul territorio nazionale auspicando un maggiore coordinamento, in modo che enti di controllo e non agiscano univocamente dal Piemonte alla Sicilia. Grave che le semplificazioni amministrative stentino a decollare. Ad esempio, l’innovativo sistema dello schedario vitivinicolo/denuncia delle uve unificate è ancora applicato a macchia di leopardo, con dilatazione dei tempi di riscontro delle produzioni e di difficoltà di certificazione delle medesime. No di Assoenologi all’eccesivo ricarico che certi esercizi applicano al vino, moltiplicando anche 5 volte il prezzo di partenza. In questo modo i produttori fanno la fame, i consumatori sono scontenti e l’immagine del vino perde terreno.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025