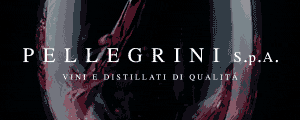Quasi metà del prodotto interno lordo (46,9%) deriva dalle produzioni di qualità. La creatività, la sostenibilità ambientale, la bellezza e il lavoro dignitoso valgono infatti 441.869 milioni di euro. È il valore della nuova misura dell’economia, il “Piq” (Prodotto Interno Qualità), sviluppata dalla Fondazione Symbola (il cui presidente è Ermete Realacci, nella foto) e Unioncamere.
Il nuovo misuratore supera il 50% della produzione solo in agricoltura (53,8%, 9.481 milioni di euro) e nelle utility energia elettrica acqua e gas (50,5%, 15.433,6 milioni). È alta anche la produzione di qualità nel manifatturiero (48,2%, 105.040,8 milioni) mentre è più bassa nelle costruzioni (43,8%, 26.143,3 milioni). I servizi sono a un livello intermedio (46,4%, 283.765,8 milione) ma per la loro dimensione contribuiscono da soli al 64% del Piq nazionale.
Lo sviluppo di nuovi indicatori da affiancare al Pil “non è un divertissement - ha detto il presidente dell’Istat, Enrico Giovannini - perché la qualità è ancora più importante della riduzioni del deficit o del debito per la crescita del Paese”. Il coordinatore scientifico del Piq, Luigi Campiglio dell’Università Cattolica di Milano, ha aggiunto che si può attribuire la perdita dell’ultimo decennio di crescita del Paese al “logoramento del premio di qualità di cui abbiamo goduto in passato, che significa meno vantaggi competitivi, meno buon lavoro e meno investimenti”. È anche per questo, secondo il segretario generale Unioncamere, Claudio Gagliardi che “la qualità è la dimensione decisiva su cui si gioca il futuro del Paese”. Un concetto, quello di qualità, che è diventato l’asset privilegiato su cui si muove, in generale, il settore dell’agricoltura del Bel Paese, come il Piq dimostra, e di cui, l’imprenditoria viticola tricolore in particolare ha fatto il suo principale vantaggio competitivo, come dimostrano i risultati eccellenti del suo export che, anche in un momento critico come quello attuale, procede con sicurezza, ponendo il comparto vitivinicolo probabilmente fra i più solidi e virtuosi dell’intero panorama imprenditoriale italiano.
Focus - Il contributo di WineNews al testo “Il Piq 2010” a cura di Unioncamere e Symbola
Focus settore vitivinicolo
Il comparto vitivinicolo, a livello nazionale può essere preso come esempio di sviluppo virtuoso della qualità. Negli ultimi 25-30 anni, infatti, non solo abbiamo assistito ad un graduale e costante miglioramento qualitativo (1) del prodotto vino, ma anche ad una altrettanto evidente crescita del contesto culturale in cui il comparto vitivinicolo italiano si è mosso. Un processo, quest’ultimo, capace di generarne uno nuovo, ulteriore e decisivo, tutto all’interno di un vero e proprio fenomeno di rimodellazione della domanda stessa (2).
E’ possibile ricostruire con precisione cronologica i passaggi fondamentali di questa sorta di piccola rivoluzione, a partire, purtroppo dalla tragedia del metanolo del 1986 (3). Un “annus horribilis” che per molti versi ha segnato un vero e proprio spartiacque fra il prima e il dopo. Il dopo metanolo è stata una delle più straordinarie riscosse dell’economia italiana, portata avanti da una classe imprenditoriale decisa non solo a cancellare gli effetti di quella tragedia, ma a portare il vino italiano nel gotha dell’eccellenza qualitativa mondiale. Una riscossa che ha avuto tra i suoi protagonisti anche chi produttore di vino non era. Iniziano, infatti, proprio in quegli anni, altre straordinarie storie, nell’ambito del contesto culturale in cui il vino italiano si stava muovendo e si sarebbe mosso nel futuro (4). In poco meno di trent’anni il mondo del vino italiano compie una “traversata nel deserto” senza precedenti, un balzo clamoroso sia dal punto di vista dell’immagine sia da quello qualitativo, competitivo e culturale raggiungendo e, talvolta, superando gli standard del modello per eccellenza: quello francese.
Ma, a ben guardare quel processo sinergico di fattori descritto nel capitolo precedente era già in parte effettivo. Non dobbiamo dimenticarci che, anche se in modo contraddittorio e in qualche misura nascosto, una pattuglia, benché sparuta, di produttori (5) già aveva intrapreso un percorso virtuoso. Insomma, il cosiddetto “rinascimento” del vino italiano, era già in atto, in modo forse sotterraneo, ma comunque effettivo, muovendosi in parallelo alla nascita e al successo di quei prodotti che comprendiamo normalmente nella categoria di “Made in Italy”. Negli anni ‘60 del Novecento, le superfici vitate dell’Italia crebbero in modo significativo, grazie ai piani Feoga (6), pensati per un aumento quantitativo della produzione viticola ma, ancora, non qualitativo. In pochi al tempo erano i produttori che utilizzavano parcelle ridotte di vigneti per produrre i vini migliori (7). Se molto si stava muovendo dal lato produttivo, molto si mosse anche dal lato legislativo, a conferma di un fermento capace di estendersi anche fuori dalla mera produzione. Nel 1963 venne introdotta la prima legge (n. 930) sulle Denominazioni di origine (8) che rimise in moto un processo e un settore che ormai sembrava ben poco competitivo. Si innescava in questo modo un ripensamento complessivo del ruolo del vino a partire dai modi di produzione (nel vigneto e in cantina), del riferimento ad un nuovo target di consumatori e di un primo, seppur limitato, utilizzo della pubblicità e della promozione. Si trattava di compiere una vera e propria “scelta di campo” di grande portata strategica tra due modelli decisamente lontani. Da una parte il Vecchio Continente, impegnato a valorizzare il suo vastissimo patrimonio enogastronomico d’eccellenza, cercando di definire un apposito quadro di regole più restrittive. Dall’altra gli Stati Uniti, l’Argentina, l’Australia, ma anche Giappone e Nuova Zelanda decisamente orientati verso un sistema meno rigido che permettesse loro di mantenere lo status quo, senza dover concedere ulteriori protezioni particolari ai prodotti tipici. L’Italia, anche da questo punto di vista, cominciò a guardare al modello francese, che forniva anche lo spunto per importare, questa volta sul versante squisitamente produttivo, tecniche per la vinificazione e l’innovazione in vigna, ma anche modelli turistici costruiti attorno ai luoghi del vino (9). Produrre vino diventò più facile grazie ad avanzamenti tecnologici e conoscenze enologiche in continuo divenire (10). I modelli prevalenti diventarono quello “bordolese” (per la Toscana) e quello “borgognone” (per il Piemonte). Al contempo, si cominciò a porre attenzione anche alle sollecitazioni provenienti dal cosiddetto Nuovo Mondo enologico a partire dagli Stati Uniti. L’Italia enoica prendeva coscienza anche dell’enorme patrimonio rappresentato dai suoi vitigni di antica coltivazione e a contrapporre al modello francese, dove si puntava ad un numero limitato di vitigni, rischiando però di massificare i gusti, un processo di diversificazione varietale, capace di innescare una nuova domanda e che avrebbe, successivamente, dato l’avvio ad una territorializzazione del prodotto, capace di produrre da un lato una domanda più complessa, caratterizzata da una ricerca continua della novità, e, dall’altro, a nuovi significati per il vino stesso. Si sviluppano vini di territorio e di vitigno, in diversi territori italiani, vengono avviate indagini volte al recupero di vitigni di antica coltivazione (11). Si approfondiscono e si consolidano conoscenze e competenze estremamente specifiche, relative ai nuovi processi di vinificazione calibrati ad hoc per i “nuovi” vitigni. Si riconoscono, finalmente, le eccellenze e le particolarità dei territori, dalle Langhe a Montalcino, solo per fare gli esempi più celebri. Il Marketing entra a pieno titolo nel mondo della produzione vitivinicola e le sue tecniche vengono applicate al prodotto, al packaging, ai punti vendita, fino ad arrivare ai luoghi della produzione del vino, le cantine (12).
Un fenomeno rilevante, dunque, soprattutto dal punto di vista sociale e culturale, che ha determinato una vera e propria rivoluzione silenziosa nel mondo di consumare e nella stessa percezione del consumo in tutti i paesi industrializzati. La nascita cioè dei consumi cosiddetti “postmoderni”, stimolati da modelli culturali nuovi, direttamente collegati all’estetica e ad una rinnovata attenzione sensoriale, nonché ad un recupero di quella “cultura materiale” che il boom economico degli anni ‘60 aveva in parte cancellato. Si tratta di quella spinta propulsiva che portò alla ribalta mondiale l’Italia della moda, del design, dell’agroalimentare e, appunto, del vino. Con scelte segmentate e differenziate dei consumi non più solo operate in funzione dei bisogni ma anche sollecitate da nuovi desideri, da ragioni estetiche, dal gusto, dalla curiosità, dall’esperienza sensoriale e così via. Ed è così che il bello e il buono diventano i fattori fondamentali di una scelta, del consumo e il made in Italy, diventava anche un nuovo modello di life-style. Un complesso e inedito paradigma esistenziale cominciava a farsi strada e il comparto vitivinicolo del Bel Paese lo seppe, proprio a metà anni ‘80, tradurre in un aspetto non secondario del proprio successo, grazie anche al suo contesto culturale, in grado, a sua volta, di trasmetterlo ai consumatori finali, chiamati anch’essi a compiere un salto di qualità, creando così una sorta di circolo virtuoso tra domanda e offerta. Quest’ultima, “obbligata” a compiere un altrettanto importante salto qualitativo, evidentemente, in prima battuta a livello di prodotto e, successivamente, anche su tutta una serie di altri ambiti (13).
Se guardiamo a ritroso le vicende che hanno portato allo scenario attuale, probabilmente ci troviamo come spiazzati (14) nel senso che il processo di sviluppo del comparto vitivinicolo italiano si è sviluppato in modo non lineare e, talvolta, addirittura con discontinuità notevoli. Il vino non svolge più la funzione di un tempo, cioè di essere un alimento indispensabile, o quasi, sulle tavole. Oggi, occupa una dimensione molto più raffinata, rarefatta e culturale, un nuovo ed importante ruolo che ricopre nell’economia e nell’immagine del nostro Paese.
Note
1) Il concetto di qualità, per sua natura, sfugge ad una definizione precisa e oggettiva, essendo legato a una serie di variabili che mutano nel tempo e acquistano nuovi significati. La definizione di qualità non è statica, ma dinamica, continuamente aggiornata: da un lato, dal progresso tecnologico, dall’altro, dal maturare di esigenze sempre diverse da parte degli attori coinvolti nel processo di produzione/acquisto/fruizione.
2) Le conseguenze dell’evoluzione socio economica e culturale, non solo del nostro Paese, da sempre influenzano profondamente la produzione vinicola. Basti pensare all’effetto che ebbe negli anni Sessanta dello scorso secolo, il fenomeno del “boom” economico legato all’industrializzazione e al crescente benessere della popolazione, al fine della creazione di un nuovo tipo di domanda. Non serviva più un vino-alimento e, per giunta povero, ma un prodotto decisamente altro sia per caratteristiche organolettiche che per prezzo. Ci voleva un “nuovo” vino, di qualità più elevata e in grado di rispondere alle mutate esigenze dei consumatori, italiani e stranieri.
3) Atti del Convegno Coldiretti, Symbola, Città del Vino “1986 - 2006 Il Rinascimento del Vino italiano dalla crisi del metanolo alla crisi del metanolo, una metafora per l’economia del futuro”, Roma, 15 febbraio 2006.
4) Si veda, solo per fare un esempio, Carlo Petrini - Gigi Padovani, Slow Food Revolution, Rizzoli Ed. 2004, la storia che ha portato Slow Food da semplice associazione per la valorizzazione del piacere conviviale a vero e proprio Movimento capace di conquistare il mondo, cambiando per sempre l’approccio nei confronti del cibo (impegno a tutela dei prodotti tradizionali con i Presìdi, educazione del gusto con l’Università di Scienze Gastronomiche, incontro mondiale delle comunità del cibo con “Terra Madre”). E se, proprio nel 1986, il primo nucleo di questa associazione prendeva forma come lega Arcigola (quella che poi tre anni più tardi sarebbe diventata, appunto, Slow Food con il Manifesto presentato a Parigi), nello stesso anno (16 dicembre 1986) usciva il primo numero di “Gambero Rosso”, supplemento di otto pagine all’interno del quotidiano “il manifesto”, che poi si sarebbe reso indipendente come giornale agli inizi degli anni ‘90, mantenendo proprio con l’organizzazione di Bra un rapporto privilegiato, testimoniato dalla guida “Vini d’Italia” (prima uscita nel 1988), poi conclusosi con l’edizione 2009 della guida, ormai saldamente fra i testi fondamentali per l’educazione al buon bere dei consumatori italiani e non solo.
5) Negli anni ‘70 del Novecento comincia un processo di graduale e generalizzata diminuzione dei vini di basso livello qualitativo e di modifica delle principali caratteristiche organolettiche, per adeguare i prodotti del Belpaese alla evoluzione delle esigenze dei mercati nazionali ed esteri, non ancora accompagnato, però, da un adeguato cambio di passo nelle tecniche viticolturali e di cantina. Nel 1971, intanto, nasce Vinitaly Salone delle Attività Vitivinicole, che, nel ‘78, diventa salone Internazionale. Ma è soltanto con gli anni ‘80 del Novecento, che le cose cambiarono radicalmente fino al tragico stop del 1986. Un percorso accompagnato da personaggi, come Mario Soldati e, soprattutto, Luigi Veronelli, che già avevano accettato la scommessa che al di là della bottiglia c’era un mondo culturale tutto da scoprire e diffondere.
6) Fondo Europeo di Orientamento e di Garanzia Agricola.
7) È il caso, per esempio, dei vini di Angelo Gaja, del Tignanello di Antinori (prima annata 1971), oppure del Sassicaia della Tenuta San Guido (prima annata 1968), quest’ultimi due, protagonisti del fenomeno dei “Supertuscan”, che si affermerà definitivamente nella seconda metà degli anni Novanta.
8) L’introduzione delle Docg arrivò agli inizi degli anni Ottanta, ma un impulso decisivco a livello legislativo si ebbe nel 1992 con la legge n. 164, una sorta di legge quadro del mondo del vino che regolamentò in modo articolato e moderno l’intera materia ed oggi sostituita dal Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010.
9) Il modello enoturistico californiano, rappresentato dal nascente fenomeno della Napa Valley, in questo senso, fu fondamentale.
10) In Italia ha rappresentato un vero e proprio fenomeno anche l’ascesa di una figura professionale come quella dell’enologo, che, nel bene o nel male, ha segnato in modo indelebile non solo la crescita qualitativa dei vini italiani, ma anche la loro stessa immagine nel mondo.
11) E’ il caso del Sagrantino di Montefalco.
12) Un fenomeno decisamente sviluppato nel Bel Paese, specie di recente, e rubricabile con il termine “Cantine d’autore”.
13) Sostenibilità ambientale, ma anche sociale e qualitativa, in una sola parola “green economy”. E il vino ne è una lucida metafora, prima protagonista di una trasformazione qualitativa, oggi pioniere di una ricerca in vigna, in cantina e anche nel packaging per ridurre il suo impatto ambientale e la sua “carbon foot print” che il consumatore, ovvero il cittadino, recepisce con maggiore facilità rispetto ad altri settori, e apprezza. Tutto il percorso del vino italiano è profondamente legato alla green economy, dalla ricerca della qualità al sempre minor impiego di fitofarmaci, dal risparmio idrico all’integrazione con la produzione di energia da fonti alternative, alla ricerca di metodi di produzione e di packaging sempre più eco-friendly.
14) La fotografia del panorama enologico italiano a partire dall’Unità d’Italia racconta di un territorio favorevole alla coltivazione della vite, ma che al tempo esportava solo l’1% della sua produzione, mentre il resto della produzione era costituito da vini da taglio, contro i 6 milioni di ettolitri di vini di qualità esportati dalla Francia. La produzione vinicola italiana divenne qualcosa di importante negli ultimi tre decenni del secolo XIX grazie agli effetti della fillossera in Francia. Quando, successivamente, la fillossera colpì l’Italia, impose una conduzione dei vigneti più rigorosa e meno improvvisata, anche se la storica arretratezza dell’Italia non venne sconfitta, neppure dal Fascismo, che, anzi, non favorì la viticoltura specializzata, perché avrebbe rotto gli equilibri generali del sistema agricolo. La produzione vinicola negli anni ‘40 restava basata ancora, da un lato, su vini eterogenei, poco tipicizzati e destinati al consumo diretto e, dall’altro su vini tradizionalmente apprezzati nei mercati interni ed esteri, prodotti in zone più o meno precisamente definite, con tecniche più accurate e ottenuti da uvaggi determinati. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, arrivarono cambiamenti radicali che interessarono sia le superfici coltivate e la loro utilizzazione, sia le strutture aziendali, mentre nel Paese si verificava il passaggio epocale, fra anni Cinquanta e Sessanta, da una società prevalentemente agricola ad una industriale. Il settore vitivinicolo entrò in crisi e solo una progressiva modernizzazione, se pur non omogenea, dette una spinta alla viticoltura specializzata, mentre le tecniche enologiche si raffinarono insieme alla comparsa di nuove realtà produttive come le cooperative.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025