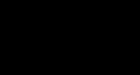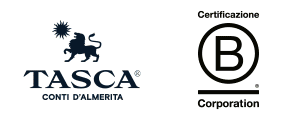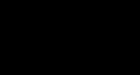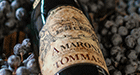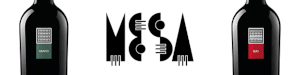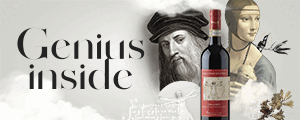Si avvicina l’arrivo nelle librerie di “Roma caput Vini”, l’ultima fatica letteraria di Giovanni Negri. Un libro che non è soltanto una puntuale ricostruzione storica sull’origine e la diffusione della vite in Europa, ma anche il luogo di una clamorosa scoperta genetica, grazie al lavoro più che trentennale del professor Attilio Scienza, cattedra di viticoltura dell’Università di Milano, sull’origine della vite che ha “partorito” tutte le viti europee, quel “heunisch (unno)”, individuato grazie all’analisi del Dna. Ma non finisce qui, a Winenews, in esclusiva, i capitoli salienti del libro e quelli, in particolare, che raccontano di questa scoperta.
Ma “Roma Caput Vini” non offre soltanto questa sorpresa. Se guardate un film ben fatto sulle battaglie nell’antica Roma e osservate bene i centurioni, scoprirete che immancabilmente nella mano destra stringono un bastone, chiamato “vitis”, un ramo di vite. Seguendo alla lettera il monito di Orazio, “Nessun albero prima della sacra vite tu pianterai, o Varo”, Roma imponeva infatti ai suoi militari di piantare la vite e stabilì che la figura chiave dell’esercito avrebbe impugnato un bastone del comando caratterizzato dall’icona della vite.
Giovanni Negri ci racconta la straordinaria storia del vino a Roma, che ha il suo momento cruciale nel secondo secolo a.C, quando il vino, prima una bevanda di lusso per patrizi, diventa “vinum”, nutrimento e piacere di massa. Dalle osterie di Roma alle feste sfrenate a Pompei, dalla personalissima guida enologica di Plinio il Giovane alla combinazione vino-cibo-sesso, dalla scelta di esportare le coltivazioni in tutte le regioni dell’Impero all’epoca del proibizionismo, un tour sorprendente all’insegna del vino nell’antica Roma, per scoprire che il vino sta all’Urbe e al suo Impero come la Coca-Cola sta agli Stati Uniti e per appurare con certezza che tanti celebrati vini di oggi, italiani e francesi, sono nati per mano degli antichi romani.
Il volume sarà presentato in un “road show” in alcuni dei più importanti “luoghi” del vino italiano: si parte il 18 novembre, a Feudi di San Gregorio (Avellino), poi a Bellavista (in Franciacorta), quindi all’Ais-Bibenda (a Roma), da Planeta (a Messina), a Castello Banfi (a Montalcino) e all’Enoteca del Roero (Cuneo).
L’autore, Giovanni Negri, giornalista e scrittore, produce Barolo, Chardonnay e Pinot Nero nelle Langhe piemontesi. E’ stato segretario del Partito Radicale. Ha pubblicato numerosi libri tra cui “Il sangue di Montalcino” (Einaudi 2010). Roma Caput Vini è scritto in collaborazione con Elisabetta Petrini, che lavora nel settore dell’energia e ha condotto delle ricerche sull’origine dei nomi dei vini europei.
Focus - Ecco il vero “cuore” di “Roma Caput Vini”. Una clamorosa scoperta genetica grazie all’analisi del dna
Ben 78 vitigni europei sono i pronipoti genetici del vitigno affidato dall’imperatore Marco Aurelio probo alle sue legioni, affinché fosse impiantato in ogni terra dell’impero, dalla Britannia alla Pannonia. Questo vitigno - l’heunisch (unno) - è anche il vitigno che sino all’alto medio evo ha prodotto i due terzi di tutto il vino europeo. I vini d’Europa hanno da oggi il loro padre putativo in Marco Aurelio probo, in Roma la potenza militare ma anche agricola che insedia la vite sul continente, nelle legioni romane un imponente strumento che probo volle trasformare - in tempo di pace - nel più formidabile strumento di diffusione e coltivazione della vite. Grazie alle analisi del dna e all’equipe del professor Attilio Scienza, oggi - nel 2011 - è finalmente noto ciò che accadde dal 280 dopo Cristo in poi, quando Marco Aurelio probo cancella l’editto di Domiziano, seleziona un vitigno e impone ai legionari di piantarlo in tutto l’Impero.
Focus - L’anticipazione dei capitoli salienti di “Roma Caput Vini”
Capitolo 13. Marco Aurelio Probo e Ronald Reagan. Realpolitik, Espansione, Imperialismo vitivinicolo e Guerre Stellari
La storia del vino attraversa i secoli come un fiume carsico, lontana dai re e dalle battaglie ma vicina, vicinissima agli uomini. E’ impressionante scoprire ancora oggi come questo fiume carsico - in tutta Europa - abbia riservato al proprio imperatore l’ affetto che si nutre per il padre e la considerazione che si riserva al genio. Probo, dopo duemila anni, è ovunque nel mondo del vino. Probo è nell’etichetta della Cuvèe Prince Probus dedicatagli dai francesi del Cahors in segno di gratitudine per l’Editto che nel 280 cancella il divieto di Domiziano e incoraggia l’impianto delle viti in tutte le terre occupate da Roma. Probo spicca nell’Historia Augusta come “colui che garantì ai Galli, agli Ispanici e ai Britanni di coltivare vigneti e fare vini, ed egli stesso scelse e piantò le viti con le proprie mani sul Monte Alma vicino a Sirmio in Illiria”. Probo è nel busto in marmo innalzato dai vignaioli locali, posto a sorvegliare lungo la Mosella i vigneti che egli incoraggiò, facendo di Augusta Treverorum la capitale della viticoltura tedesca. Il suo nome battezza una miriade di cantine, alberghi, ristoranti lungo il corso del Danubio, che per Probo fu il confine lungo il quale erigere mura difensive e vigneti. Si chiama Probus un’eccellente etichetta del Reno, perché senza di lui non vi sarebbero stati i vigneti nella valle oggi celebre, così come Probo sbuca da cento trattati storici e antiche pergamene. Per la britannica An Enciclopaedia of Gardening “i più vasti impianti furono realizzati in Inghilterra verso la fine del III secolo, durante il regno dell’imperatore Probo”, e le pagine dello storico Edward Gibbon lo immortalano come colui che “esercitò le sue legioni a coprire di ricche vigne le colline della Gallia e della Pannonia, così come Annibale per preservare le sue truppe dalle pericolose tentazioni dell’ozio le aveva obbligate a fare vaste piantazioni di ulivi lungo la costa dell’Africa. Un esercito così impiegato componeva forse la più utile e la più coraggiosa porzione dei sudditi Romani.”. Quanto ai biografi della sua era “Probo celebrò a Roma i suoi trionfi sui nemici e si impegnò a garantire un’era di pace e di benessere. In tempo di pace egli impiegò i suoi soldati nella realizzazione di pubbliche opere, costruendo templi e ponti, regolando i fiumi e scavando canali e piantando vigneti specialmente in Gallia, Pannonia e Mesia”.
Insomma un profilo - quello che emerge dalla memoria bimillenaria dei produttori di vino così come dalle centinaia di citazioni degli storici - che fa dell’era di Probo la stagione nella quale la forza di Roma impianta la vite dal Vallo di Adriano che protegge la Britannia alle acque iberiche di Cadice, dall’intera Gallia sino alle fredde lande germaniche, dalla Dalmazia e l’Illirico (odierna Serbia e Macedonia) sino alla Pannonia e alla Mesia (Ungheria, Romania, Bulgaria) seguendo il Danubio e senza naturalmente dimenticare l’Italia, nel frattempo divenuta la parte meridionale dell’impero insieme alle regioni africane che costeggiano il Mediterraneo sino all’Egitto. Un profilo, dunque, che fa di Probo l’assoluto e unico protagonista di una scelta che ha cambiato la storia del vino. Un uomo che forse merita l’iscrizione impressa nella lapide funeraria - Qui giace l’imperatore Probo,uomo veramente degno di questo nome, altrettanto prode che virtuoso, fu vincitore e di tutte le barbare nazioni e di tutti gli usurpatori - ma che per quanto riguarda la nostra storia assume un peso del tutto irripetibile. A maggior ragione se ci soffermiamo su alcuni, cruciali dettagli biografici. Marcus Aurelius Probus nasce e muore a Sirmio, l’odierna Sremska Mitrovica, non lontano da Belgrado. Viene al mondo il 9 agosto 232 ed è ucciso da soldati congiurati, insofferenti per i ritmi di lavoro loro imposti, fra il settembre e l’ottobre 282: muore dunque cinquantenne. A vent’anni è tribuno militare e nella sua vita altro non farà che il militare. Ebbe una madre pannona e una moglie aquitana. Ma ciò che più impressiona è che diventa imperatore nel 276, a quarantaquattro anni. Tutto ciò che Probo realizzò, in pratica, fu il frutto di soli sei anni di regno.
Ronald Reagan governò per due mandati e ispirò un’epoca. Insediandosi alla presidenza degli Stati Uniti pronunciò la frase memorabile: “Nella crisi presente il governo non è la soluzione al nostro problema; il governo è il problema”. Parole che calzano a pennello per descrivere la condizione di Probo appena proclamato imperatore. Il drammatico problema di Roma è infatti assai chiaro: il suo sistema di governo. Siccome siamo italiani, non ci è facile comprendere subito la complessa dell’entità Impero Romano, in quegli anni. Istintivamente pensiamo a una Roma al centro di tutto, con il suo bel palazzo imperiale vicino al Foro e tanti legionari romani in marcia dal Colosseo verso i lontani confini delle terre occupate con le campagne militari. Ma le cose all’epoca di Probo non stanno affatto così. L’imperatore a Roma ci sta molto poco perché ha ben altro da fare: deve controllare le legioni. Sono queste, sono le gerarchie militari e uno sterminato esercito la fonte del suo scettro e insieme lo strumento per difendere dai barbari gli ormai remoti confini. Perciò un candidato imperatore dovrà prima farsi proclamare dai legionari, poi condurre una guerra civile spietata contro gli imperatori abusivi - i concorrenti sovente nominati da altre legioni in altre parti dell’Impero - quindi dare unicità di comando e strategia a tutte le legioni per rintuzzare i barbari. Attenzione però: la stessa figura del legionario è molto cambiata. Il legionario di questa epoca sta al legionario originario - per capirci - come l’italiano di Broccolino-Brooklyn sta al suo bisnonno siculo. E’ insomma un emigrante, un uomo che non parla più la lingua degli avi perché la parlata si è imbastardita con i dialetti delle mille terre dell’impero e delle loro donne, che nel frattempo sono divenute le mogli dei legionari e le madri dei loro figli. Usi e costumi, accenti e abitudini, schiavi e patrizi lentamente subiscono vere e proprie trasformazioni antropologiche. I francesi, che se non mettono un po’ di pepe gallico in ogni discorso non sono contenti, vantano come Gallo-Romana una civiltà che in realtà altro non fu che l’imbastardimento della iniziale romanitas, ed in tal senso potremmo parlare di civiltà Germanico-Romana, Pannonico-Romana, Illirico-Romana o Britannico-Romana. Tutto ciò per dire che dal II secolo in poi il baricentro geopolitico dell’impero si è drasticamente spostato a nord. Città come Lione o Ravenna hanno un peso strategico, militare e commerciale, ben superiore all’Urbe. E lentamente la latitudine del fulcro dell’impero salirà ancora, perché il cuore del potere imperiale coincide con quello che oggi definiremmo l’Hub meglio collocato per rifornire e controllare il Network, il crocevia strategicamente meglio posizionato per gestire le legioni. Probo non a caso è uno dei cosiddetti “imperatori illirici”, e basta dare uno sguardo alla dislocazione delle legioni per comprendere come l’Illiria fosse un hub quasi perfetto per gestire l’esercito di un impero il cui potere si difende ad una latitudine ben lontana dalla città che fu la culla di tutto, una Roma essenzialmente relegata al ruolo di luogo dei trionfi e sede di un Senato assai occupato a tramare contro l’imperatore di turno. Sicché Probo dovrà prima liquidare tale Giulio Saturnino proclamato imperatore dalle legioni in Siria, poi far fuori il pretendente Proculo, infine sconfiggere Bonoso, autoproclamatosi imperatore nella germanica Colonia. Nel frattempo, ed in soli sei anni, l’imperatore illirico riesce tuttavia a compiere una tournèe - con relative, severissime lezioni impartite ai barbari - che lascia sbigottiti.
La sua visione dell’impero e del mondo è diametralmente opposta a quella dell’introverso, sospettoso e protezionista Domiziano. Probo si difende attaccando, ha una fede incrollabile nell’espansione militare dell’impero, ma anche le opere pubbliche nelle quali impegna le legioni (impianti di vigneti inclusi) altro non sono che il tentativo di consolidare e stabilizzare il potere imperiale, presidiando con i soldati e l’agricoltura gli sconfinati territori imperiali e i loro fragili confini. In breve, se il vino ebbe in Domiziano il suo Monroe sospettoso e ripiegato su sé stesso, Probo dà alla vite una prospettiva di espansione illimitata, una capacità di visione che lo fa apparire una sorta di Reagan in perenne movimento. Le monete, la numismatica e le iscrizioni monumentali ci raccontano che dapprima l’imperatore pacifica la Tracia, la Mesia e la Pannonia, poi sconfigge i Goti lungo il Reno, infine scende a Roma a ricevere l’investitura dal Senato ma deve immediatamente ripartire alla volta della Gallia. Qui presidia una settantina di città e fortezze dagli attacchi di Franchi, Alamanni e Burgundi, ripristina la supremazia assoluta dell’aquila romana, spedisce tutti i prigionieri a rafforzare le legioni in Britannia dove respinge un bel po’ di insurrezioni locali, infine decide di fortificare tutto il confine del Reno e si concentra sul Danubio, mentre in Rezia e Illiria pensa bene di battere i Vandali ricacciandoli oltre la frontiera. Basta? Macché: i suoi generali ristabiliscono l’ordine minacciato in Egitto e lui vara un vasto piano di costruzioni di dighe, canali e ponti sul Nilo, nonché l’insediamento di grandi fattorie agricole. A ben studiare le sue mosse appare chiaro: forse per la vite e l’agricoltura il nostro aveva anche una passione, ma certo il lavoro dei campi è uno strumento politico impiegato con sorprendente metodicità. Se per Clausewitz la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi, per Probo le strade, le dighe, i ponti, le fattorie e la viticoltura sono la prosecuzione naturale di ogni guerra e lo strumento di stabilizzazione del confine imperiale. In soli sei anni di regno, Probo pare quasi onnipresente. E’ sul punto di impegnarsi in una campagna di Persia quando è costretto a sedare dei moti nella penisola Iberica, a Roma completa le mura Aureliane e costruisce il ponte di Probo fra l’Aventino e Trastevere, poi va a terminare le fortificazioni del Reno e del Danubio. Infaticabile si sposta ai quattro angoli dell’impero lasciando dietro di sé una scia di opere pubbliche e di vigneti, pretendendo dalle truppe una condotta altrettanto infaticabile. Così infaticabile, secondo la leggenda, da provocare infine la rivolta durante la quale trova la morte.
Poche idee ma chiare e una testa particolarmente dura rendono affini il Probo di due millenni fa e il Reagan migliore. Entrambi dividono il mondo in buoni e cattivi, amici e nemici, lavori utili e inutili. Entrambi prendono decisioni rapide. Reagan in crescendo stronca in poche settimane lo sciopero dei controllori di volo riscrivendo le regole sindacali di una nazione, obbliga il Congresso a diminuire le tasse del 25% già nel 1981, subito dopo lancia le reaganomics per poi scagliarsi contro “l’Urss impero del male”. Il tutto con una disinvoltura rara anche nei più pragmatici dei suoi predecessori, e con una fede incrollabile nei destini imperiali della sua America. Per Reagan, come per Probo, l’espansione è l’attività permanente di un impero. Un impero non può difendersi, non può rinchiudersi in sé stesso: se di impero si tratta deve crescere. Entrambi subiscono attentati, quello al presidente americano non sarà letale e quello all’imperatore romano sì, ed entrambi giocano una carta strategica. A differenza della viticoltura diffusa da Probo su ogni lembo di terra imperiale, però, l’asso nella manica reaganiano è passato alla storia più come un bluff che come una realtà. La Strategic Defense Initiative con la quale Reagan annuncia al mondo la nascita di uno Scudo Spaziale tale da consentire la difesa preventiva del suolo americano da qualsiasi missile grazie a un complesso sistema laser al suolo e nello spazio, è subito sbeffeggiato dagli oppositori come un progetto da Guerre Stellari, irrealistico come la saga cinematografica dell’epoca. Incurante delle critiche e pronto a replicare che “la fantascienza di ieri è l’ingegneria di domani”, Reagan impressionò i sovietici e secondo alcuni suoi biografi - forse in vena di apologia - li trascinò in una sfida militare-industriale così dispendiosa da piazzare il primo vero colpo alle già malridotte casse del Cremlino. A naso, a dire il vero, le strade e le vigne di Probo appaiono più solide e tangibili dei laser e dei satelliti di Reagan. Ma tant’è: un impero, a volte, è fatto anche di bluff. Oggi ci è finalmente chiaro, comunque, perché Probo trasforma l’impero romano in un impero anche vitivinicolo. Lo fa perché riafferma l’antica politica romana dell’hic manebimus optime, contraddetta solo dal velleitario Domiziano: è la vite il simbolo della stabilità romana, della volontà imperiale di durare in eterno. Probo ripristina l’antico ordine perché solo con la vite può ripopolare territori spopolati dalle incursioni barbariche. Lo fa perché attraverso la vite sposa in tempo di pace l’attività di una legione con la realtà civile ed agricola della terra occupata. Lo fa perché le viti, così come i muraglioni, le fortificazioni, le strade tracciano quelli che per Probo debbono essere gli intoccabili confini dell’impero, in primo luogo lungo i fiumi: accadrà lungo Reno, Mosella e Danubio così come lungo altri mille corsi d’acqua in Gallia e Britannia, in Iberia e in Dalmazia. Lo fa, infine, perché oltre a dare una missione alle legioni deve gestire il sostentamento dei legionari, che consumano vino e che come abbiamo visto sono comandati da centurioni il cui bastone del comando fu il Vitis. Già, ma quanti sono i legionari? Scopriamolo, l’esercito di Probo.
E’ una massa d’urto militare impressionante, quella agli ordini dell’imperatore. Una testuggine armata che presidia l’Europa con una logica interna schiacciante. Lo zoccolo duro dell’esercito è il Comitatus: una legione che sta nel cuore di ogni provincia, pronta a intervenire se la frontiera è minacciata. Sul confine sono invece stanziate le legioni del Limitanei: il loro scopo è rallentare l’avanzata dei barbari in caso di sfondamento del confine, in attesa dell’arrivo del Comitatus. La sede reale dell’impero, ovviamente, è il luogo dal quale si è meglio collegati ai diversi Comitatus di stanza nelle provincie. Gallieno - intorno al 260, ossia poco prima dell’ascesa al trono di Probo - farà di Milano il baricentro imperiale, equidistante da Roma e dalle frontiere nordiche dell’impero. Diocleziano, che diventa imperatore nel 284, due anni dopo la morte di Probo, giostrerà le sue legioni dalla Dalmazia e dall’Illiria. E’ il segno che il cuore dell’impero è stato ulteriormente spostato verso nord, verosimilmente da Probo. Il gioco strategico dell’ imperatore consiste in una vigilanza continua dei confini e nella velocità di invio - ogni volta che il barbaro sfonda il limes - delle forze di riserva meglio armate ed addestrate. L’impero subisce quasi sempre, inizialmente, la potenza d’urto dell’attaccante che sfonda il confine, ma con il rapido arrivo dei rinforzi può schiacciare il nemico grazie alla superiorità numerica e al migliore addestramento militare. Quanto ai numeri, se già in età augustea i legionari sono 150.000 divisi in 28 legioni, durante il regno di Traiano le legioni sono 30 e i legionari 300.000. L’espansione dell’impero tuttavia moltiplica, di decennio in decennio, il numero dei legionari e il peso politico dell’esercito. All’epoca di Settimio Severo avremo 350.000 legionari, e con Diocleziano - passato alla storia anche per la riforma dell’esercito - i legionari saranno circa 500.000 . Tutto lascia ritenere che l’imperatore Probo abbia disposto di una massa di manovra militare di almeno 38 legioni, divise in manipoli comandati dai centurioni e composte da almeno 450.000 uomini . E’ su questo numero imponente di soldati, o almeno su una sua buona parte, che Probo fa leva per occupare con grandiose opere di pace le terre precedentemente conquistate con le campagne militari. E’ certamente nel numero così vasto di militari da approvvigionare, e al quale affidare il compito di piantare la “sacra vite”, la ragione ultima della scelta compiuta da Probo. Una scelta che trasformerà l’impero in Roma Caput Vini. Se nei secoli prima di Cristo il vino della Magna Grecia era bastato a soddisfare la sete di Roma, già nei primi secoli dell’era cristiana i romani avevano riservato i vini campani al consumo interno, per identificare invece nell’attuale Veneto e in Aquileia la regione di produzione e il centro di smistamento dei vini destinati a rifornire le legioni. Un sistema che diventerà ingestibile col passare del tempo. Da un lato neppure il fertile nord Italia è in grado di produrre da solo il vino indispensabile a una massa di uomini così consistente, per altro verso i costi di trasporto per raggiungere le legioni di stanza nei territori più estremi diventano insostenibili. Una riforma si impone ed è Probo a compierla nel 280. Se il vino del Veneto non basta più e non può più essere trasportato da Aquileia alle legioni, saranno proprio le legioni a piantare le viti per produrre il proprio vino, per avviare alla produzione le popolazioni locali e per trasformare i vigneti in confini anche fisici dell’impero. Perciò Probo abolisce l’Editto di Domiziano, perciò è riconosciuto ancora oggi dal mondo del vino come uno dei suoi più nobili padri. Eccoci arrivati all’ultimo tassello della nostra storia. Per affidare la vite ai legionari, Probo compie una scelta semplice, razionale. Seleziona un vitigno e lo affida a tutte le legioni alle quali chiede di piantare la vite. Secondo alcuni suoi biografi come Eutropio (Breviarium ab Urbe Condita, IX,17), Flavius Vopiscus (Probus, XVIII, 8) e Aurelius Victor (Liber de Caesaribus, XXVII , 1-3) Probo fece piantare numerose vigne in Pannonia e in Mesia, ma più precisamente fece dissodare dai soldati il suolo del Monte Alma in Illirico, vicino alla sua Sirmio, e ci piantò dei vitigni robusti, adatti a temperature non mediterranee. Anche, probabilmente, il vitigno che ritroveremo in tutta Europa, proprio perché portato dalle legioni. Il vitigno di Probo. Il vitigno nel cui Dna sono iscritte le parole Roma Caput Vini.
Capitolo 14. Il vitigno delle Legioni. Attilio Scienza, la scoperta
La rivoluzione della ricerca nell’ambito della viticoltura si compie alla fine degli anni ‘90, quando sulla tradizionale ampelografia si spalanca un mondo nuovo. Fatto il debito paragone, il salto è quello dalla torcia alla pila elettrica. Fino all’ultima decade del secolo scorso la classificazione delle diverse varietà dei vitigni era affidata allo studio accurato della foglia e del grappolo. Ampelografia, appunto: gli scienziati si chinano sulle forme vegetali, sulle ramificazioni e sui punti distanziati all’interno di una foglia, sulle tipologie di acino e grappolo, cercando di mettere ordine nel caos prodotto dalle umane cose. Il compito arduo dell’ampelografo è insomma quello di rimediare ai danni di un’umanità pasticciona che col trascorrere dei secoli ha dato magari allo stesso vitigno cento nomi diversi, e poi ne ha scambiato uno per un altro, confondendo con i nomi di luoghi, persone, animali ed eventi le varietà che la botanica vorrebbe semplicemente classificare. Dal 1990, tuttavia, irrompe sull’antica ampelografia l’analisi del Dna, e diventa realtà ciò che prima era un miraggio. L’albero genealogico di vitigni e vini, la facoltà di svelarne l’identità, la provenienza, il passato. Gli album delle foglie collezionate con cura dagli ampelografi sono sostituiti dai marcatori molecolari sino ad allora sconosciuti. Sono questi i pilastri della nuova ricerca: i microsatelliti sono sequenze di basi molecolari che consentono l’identificazione del vitigno, che permettono di raccontarne la storia genetica e il patrimonio identitario. Con 7 microsatelliti è possibile riconoscere la varietà di un vitigno con un margine di errore inferiore all’1% . Utilizzando una base più ampia di 30 microsatelliti è invece possibile svelare anche la “parentela” del vitigno, capirne gli avi e risalirne all’origine. La prima ricerca di questo tipo è effettuata dagli americani sul vitigno Cabernet Sauvignon. I risultati sono pubblicati nel 1997 e confermano ciò che gli ampelografi hanno già rivelato: questo vitigno nasce dal matrimonio fra Cabernet Franc e Sauvignon Blanc. Lo studio successivo è del 1999 ed è fondamentale non solo per dimostrare che la gran parte dei vitigni oggi coltivati sono il frutto di incroci spontanei - dove la cultura del viticoltore ha scelto quello che meglio rappresentava nel suo immaginario la qualità del vino ed il suo uso rituale - ma perché è la prima testimonianza dell’incrocio di una vite paradomestica europea (il Pinot) con un vitigno portato da regioni orientali (il Gouais o Heunisch) da cui nascono moltissimi vitigni, ma soprattutto rappresenta il modello evolutivo di tutta la piattaforma varietale europea a partire dal Medioevo. Per intenderci, uno degli effetti sorprendenti di queste ricerche è quello di svelare come lo Chardonnay non abbia affatto la sua culla in Francia - come sin qui unanimemente ritenuto - bensì in un’area identificabile nell’antica Pannonia (Ungheria). Mentre un’altra clamorosa sorpresa, con pesante delusione per il mondo del vino americano, è quella che proclama lo Zinfandel - vitigno quasi autoctono secondo i raccontati dei californiani – come un frutto Made in Italy, visto che le sue caratteristiche genetiche sono del tutto identiche al pugliese Primitivo di Manduria nonché al Crljenak Kastelanskj, vitigno di origine dalmata e dall’odierno, impronunciabile nome croato.
Ricerca dopo ricerca approdiamo così alla nostra storia, che ha per protagonista un’equipe americana guidata dalla ricercatrice Carole Meredith, un italiano e un nutrito gruppo di collaboratori francesi e tedeschi.
Il mondo del vino italiano non è solo poesia, aulico caleidoscopio di retrogusti dai rosei sentori al geranio o ai frutti di bosco. Le cose non stanno sempre come le raccontano i romantici, talvolta interessati poeti del vino. Il business del vino nel Belpaese è giovane. Geniale come ogni impresa artigianale - forse è bene sottolinearlo: il tricolore è grande quando è artigianale - ma gravido di diffidenze ancestrali, di errori. Fra questi ne spiccano un paio: la subalternità verso i cugini d’oltralpe “detentori della vera storia”, la concorrenza limacciosa e l’invidia irriducibile soprattutto verso il vicino più vicino di tutti (“Il suo vino fa schifo”). Sono i prevedibili difetti che accompagnano ogni ricchezza troppo giovane. Sfatiamo il mito: non è vero che signori si nasce, signori si diventa. Certo: se fate vino da trecento anni vostro figlio nascerà signore del vino, ma se avete fatto i soldi con il vino negli ultimi trent’anni, la partita è ancora aperta. La signorilità del vino ha insomma alle spalle una storia di crescita pacata, graduale come il tintinnio dell’argenteria. Il boom economico del nuovo ricco ha la sgradevole scompostezza degli importatori che non accettano l’ultima presa in giro, lo sbalzo triennale della speculazione improvvisata, il depliant patinato del furbo che si pavoneggia Chateau. Perciò il mondo del vino italiano è doppio come un Giano bifronte. Brillante di personaggi geniali che esportano, si affermano e vincono sui mercati del mondo ma anche percorso da risse di campanile, da sordidi conflitti che gli impediscono di fare sistema, benché all’appuntamento annuale del Vinitaly troverete tutti i produttori sempre profumati, infiocchettati e sorridenti. Il punto è che la nostra ricchezza in fatto di vino è una ricchezza nuova, spesso inconsapevole di un passato che è invece la nostra grande forza. Una ricchezza talvolta attenta solo all’ultimo fatturato, convinta che sia l’unica cosa che conta. Eppure qualcuno che conta, anche nel mondo del vino italiano e soltanto per i suoi saperi, c’è. Eccome se c’è.
L’università di Milano ha alle spalle una storia strana. Più di un secolo fa la gelosia degli accademici di Pavia fece sì che gli amministratori meneghini si rivolgessero a un paio di architetti britannici per svolgere uno strano compito: costruire gli edifici di una facoltà che gli ingombranti vicini non amavano e ancor meno desideravano. L’accademica e blasonata Pavia, centro universitario da 650 anni, osteggiava a tal punto il progetto che in gran segreto i milanesi dovettero importare architetti, stili e modelli dell’Inghilterra imperiale per costruire una città degli studi. Percorrere oggi viali, piazzette e palazzi della facoltà di Agraria - a due passi dallo stimato Politecnico - fa perciò l’effetto di una full immersion nella Chelsea di fine Ottocento. Lasciatevi alle spalle diverse villotte basse, salite qualche scalinata in ombra e scoprirete una grande giovialità. Immerso fra carte e computer, ben nascosto nel suo laboratorio, vive e insegna colui che insieme a pochi altri - possiamo contarli sulle dita di una sola mano - è unanimemente riconosciuto come un’ autorità italiana del vino.
Burbero e sempre affaccendato, a prima vista il professore Attilio Scienza non appare per quello che è: un uomo dalla curiosità implacabile. Poco importa che da anni gli sia affidata la cattedra di Viticoltura dell’Università di Milano, o che sia uno dei rari italiani accolti con onore nel Comitato scientifico del Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin a Bordeaux o nel Journal of Wine Research di Londra. Il punto è che la sua erudizione è in larga parte frutto di una ricerca sul campo in tre continenti, attraverso un seducente viaggio nell’archeologia della vite. Forse solo un ricercatore, un genetista poteva tenere uniti il passato - a caccia delle origini della vite - e il futuro, con una generazione di enologi italiani oggi famosi nel mondo che riconoscono in lui il maestro che li formava all’istituto di San Michele all’Adige.
Perciò dobbiamo tenere d’occhio la sua passione e i suoi strumenti di ricerca, per stringere il filo della nostra storia: passando dall’antropologia all’enologia, dalla chimica alla paleobotanica, dall’archeologia alla genetica molecolare. Sarà proprio questo approccio interdisciplinare a comporre il mosaico di Roma Caput Vini.
Sono gli abiti di Indiana Jones, quelli che il bonario professore indossa appena termina una lezione a Milano. Seguiamolo a ritroso nel tempo e con in mano una bussola. Lui e i suoi collaboratori si sono prima di ogni altra cosa dedicati a cercare l’origine del tutto, il principio del mondo del vino. Solo svelando il mistero originale il ricercatore potrà infatti ricostruire, tassello dopo tassello e attraverso i secoli, il percorso insieme agricolo e mitologico della pianta, della bevanda che le civiltà del Mediterraneo hanno trasformato in simbolo. Un itinerario per certi versi ancora oscuro che ha una culla eurasiatica, un difficile cammino fino alle sponde del Mar Nero, poi il mare infinito e una miriade di terre.
Provate anche voi a immergervi nell’archeo-enologia di Scienza, dal primo grappolo ai vini odierni. Il viaggio è appena iniziato e subito scoprite che a differenza di mille altre parole dalle precise radici, Vino è un termine classificato dai linguisti come “itinerante e fluttuante”, diffuso attraverso millenni tra popoli, razze e lingue diverse, in un’area sconfinata dall’India alle Colonne d’Ercole. L’ittita wiyan della famiglia indo-europea ha lo stesso etimo del proto-semitico wyn, dell’antico arabo wayn, del georgiano gwino. Sarà l’antropologo a spiegare come “queste affinità linguistiche sono collegamenti orizzontali, parole prestate da una lingua all’altra, apparentamenti che avvengono quando un gruppo sociale trasmette ad un altro delle innovazioni, ad esempio nuove tecnologie, o beni novità. Situazioni nelle quali il popolo che acquisisce la novità prende in prestito anche il nome che il bene aveva presso la comunità esportatrice”. L’origine del Vino, facciamocene una ragione, non può dunque essere ricercata nelle radici linguistiche. Proviamo allora con tutti gli altri mezzi a disposizione: sono i satelliti e il carbonio 14, i reperti archeologici e i raggi infrarossi, la mappatura genetica di incroci naturali e artificiali, gli studi del Dna e le analisi molecolari gli strumenti con i quali Scienza vi porta a caccia della Prima Uva. Perché è questa la posta in gioco, l’obiettivo del ricercatore. L’identificazione dell’Uva originale, della madre di quelle che saranno tutte le uve, della culla della vite e del vino. Il vostro sarà perciò un viaggio scomodo fra misteri primordiali, liquidi giurassici ricavati da bacche spremute forse dai cavernicoli, strane piante di viti selvatiche che sbucano dalle nebbie cercando un raggio di sole. Seppure fra molti dubbi, scoprirete insieme a Scienza che forse la Prima Vite e il Primo Uomo ebbero una culla comune, che l’archeologia della vite è assai prossima all’archeologia della vita, che i tanti Noè presenti in diverse religioni sono non casualmente anche viticultori, scampati alle devastanti acque dei diluvi universali e desiderosi di piantare la vite. Dove? Tre sono le terre che lo scienziato indica sull’atlante: Ingucezia, Mesopotamia, Monti Zagros. Lì è nata la Prima Uva. Forse Ingucezia non vi dice molto perché è parola dallo strano sapore di piccola repubblica post Sovietica. Ma Georgia e Mar Nero dicono già di più, e Colchide vi fa tornare al liceo. Stiamo parlando della terra del Vello d’Oro di Giasone. E’ alla fine dell’era terziaria che la pianta genericamente definita Vitis è sparsa su una precisa fascia del pianeta: gli sbalzi di temperatura del quaternario le consentono di sopravvivere solo fra i 50° e i 30° di latitudine nord. La ricerca documenta come a partire dall’8.000 a.C. si sviluppi una selezione graduale delle viti in Asia Minore, soprattutto in un suolo ricco di valli e paludi sia lacustri sia marine. Antiche fonti elleniche fissano i confini della Colchide a Trebisonda, nell’odierna Turchia, spingendoli poi verso nord sino a Suckhumi, in Abcasia. Oggi la Colchide fa parte della Georgia e presenta due indizi sconcertanti. Gli archeologi vi hanno trovato giare e recipienti di terracotta che testimoniano di una viticoltura praticata dal terzo millennio avanti Cristo. Gli antropologi spiegano invece come in Colchide si parlasse una lingua kartvelica, e come il georgiano antico sia la lingua del pianeta con il più ricco vocabolario enologico. Secondo Scienza le 1.200 parole relative alla viticoltura, i ben 32 termini impiegati soltanto per descrivere i diversi stadi di maturazione dell’uva, insieme alle oltre 500 varietà autoctone di vitigni ereditati dai tempi antichi e ancora oggi coltivati sulle colline georgiane, fanno di questa terra la più probabile culla della Prima Uva. O almeno la culla dell’era moderna, perché le condizioni climatiche ottimali per la diffusione della vite primordiale si crearono intorno al Mar Nero solo in un’epoca successiva, quando un calore insopportabile espiantò viti ancora più antiche da altri territori.
E’ probabile che la coltura della vite fosse praticata fra il Tigri e l’Eufrate attorno al 5.000 avanti Cristo, di certo il Codice di Hammurabi conferma le puntigliose regole enologiche degli Assiri. Uno dei più antichi recipienti che contenne vino è stato però ritrovato sui Monti Zagros, intorno alla città iraniana di Shiraz. E’ una sorta di otre risalente circa al 7.000 avanti Cristo. Sicuramente lì ci furono uve e vini - giura l’accademico - finché la grande calura e i mutamenti climatici ricordati da tanta parte dell’umanità come i cataclismi dei diluvi universali, fecero incagliare l’arca della vite e della vita alle latitudini del Caucaso, in Georgia. Lì i Greci cantarono Giasone e vollero a ogni costo espugnare Troia per il controllo del Bosforo, lì forse scoprirono il frutto che intitolarono a Dioniso. In Ellade gli strani grappoli giunsero dalle coste del Mar Nero, ma anche su imbarcazioni fenicie approdate prima a Creta e poi nel Peloponneso. Sta di fatto che è in Grecia che la vite si afferma e si fa mito. O meglio, per dirla con Tucidide, “i popoli del Mediterraneo cominciarono ad uscire dalla barbarie quando impararono a coltivare l’olivo e la vite”. Manca ancora un elemento, a questo binomio, per creare quel trittico di olio, vino e pane che superata la barbarie ci porta diritti nella civiltà, alle basi della nostra odierna alimentazione. Eccoci, fermi un attimo. Ora sappiamo dove nacque la Prima Uva. Sappiamo che i Greci ne fecero abitudine e mito. Sappiamo però che con loro il vino sarebbe rimasto confinato alla sola Grecia, e che invece i romani - comperando dai greci una mitologia e una religione - trasformarono Dioniso in Bacco. Sappiamo che nel 171 a.C. nasce a Roma il primo forno commerciale, culla del primo pane. Sappiamo che nell’Urbe il nutrimento ormai solido e non più sotto forma di poltiglia di cereali fa esplodere il consumo del vino, inseparabile compagno del pane. Sappiamo che per ragioni di mercato e per motivi politici Roma sceglie di diffondere il vino e di piantare la vite. Sappiamo che Domiziano con un editto si illude di garantire all’impero l’autosufficienza del grano insidiato dalle carestie che affliggono la Sicilia e il Nord Africa, e che perciò decreta l’espianto dei vigneti al di fuori d’Italia e ovunque l’impianto di fecondi campi di frumento. Sappiamo come questa politica protezionista abbia avuto scarsa efficacia e come un altro imperatore, Probo, decida di promuovere nuovamente e con forza la vite, radicandola in Europa. Non ci resta che capire come questa bevanda effettivamente si sia affermata sull’intero continente. Se ciò sia avvenuto perché i popoli europei hanno emulato i romani costruendosi le proprie uve e i propri vini, oppure se sia stata Roma a creare uve e vini e se di ciò vi sia traccia. Se esista o meno la prova provata, fisica, concreta e materiale del ruolo di Roma Caput Vini. E qui, di nuovo, ci viene in soccorso la rivoluzione scientifica dell’analisi del Dna. Non perché i ricercatori abbiano voluto sciogliere a tutti i costi l’enigma di Roma Caput Vini, ma perché studiando e classificando le caratteristiche genetiche di ben 78 (settantotto) vitigni europei - fra i quali troviamo lo Chardonnay come il Riesling, il Gamay come la Malvasia - l’equipe americana della Meredith e italiana di Scienza hanno scoperto che questi 78 vitigni e le centinaia di vini europei che oggi essi producono, hanno una caratteristica genetica comune. Anzi in comune hanno proprio un Padre genetico. Sotto il profilo scientifico è stata questa la ricerca che più ha appassionato il gruppo dei nostri accademici, impegnandoli in approfondimenti durati anni. Potete quasi immaginarli intorno a grandi tavoli fra centinaia di analisi satellitari, corpose ricerche archeologiche, studi del Dna di decine di vitigni. Alle prese con due dati scientifici incontrovertibili. Il primo: uno e uno soltanto fu il vitigno-padre della grande maggioranza degli attuali vitigni europei. Il secondo: con questo unico vitigno nel Medio Evo si producevano addirittura i tre quarti del vino europeo. Ma appena furono confermate queste due verità scientifiche, ecco affacciarsi il mistero. Quale l’origine di quel vitigno? E chi, come e perché lo diffuse su un intero continente?
Capitolo 15. Heunisch - L’Unno. Il Padre dei vitigni europei: Roma Caput Vini
Siamo nei primi anni del 2.000. Grazie ai marcatori molecolari e all’analisi del Dna un’equipe internazionale di scienziati è impegnata a ricostruire l’albero genealogico della vite in Europa: dal Pinot al Sauvignon, dal Silvaner al Riesling, dal Lagrein all’Aligotè, dallo Chardonnay al Gamay. Uno studio che abbraccia tutti i vitigni del continente. Più passano i mesi, più diversi ricercatori constatano stupiti la presenza genetica di un padre comune in una quantità imponente di odierni vitigni. Gli scienziati comprendono che c’è stato un avo collettivo. Un Adamo innestato in una pluralità di giardini terrestri, che ha figliato in modo così diffuso da lasciare una traccia inconfutabile e sorprendente nella sua progenie, presente a tutte le latitudini europee.
Non che questo vitigno fosse sconosciuto. Il suo nome medievale, risalente al primo periodo post-romano, è Heunisch. In italiano: Unno. Una parola che nella nostra lingua evoca l’invasione e il barbaro, ma la cui radice etimologica ha tutt’altro significato, perché Heunisch corrisponde in ceppo tedesco a “nostro”. Una vite “nostra”, ben conosciuta. Tanto infatti Heunisch sta a “nostro” quanto Frankisch vuol dire “altro”, nel senso di estraneo, diverso. Questo primo indizio sulla parola Heunisch conferma intanto come le popolazioni dell’Europa orientale e settentrionale da lungo tempo avessero convissuto con quel vitigno, al punto di battezzarlo abitudinariamente come il “nostro”, un elemento consueto nella vita e nell’agricoltura attraverso i secoli. Peraltro il vitigno con quel Dna assumerà con il passare del tempo nomi diversi: sarà Swaess in Svizzera, Gouais nella Francia centrale, Neiret o Nebbiolo di Dronero nell’Italia nord occidentale per diventare Sclavus e poi Schiava in Lombardia e nel Nord est italiano. Nomi diversi per una mappatura genetica del tutto identica, e per un vitigno che nel Medio Evo rappresenta da solo ben i tre quarti della viticoltura continentale, genitrice della massa liquida che disseta i popoli europei dall’Ungheria alla Gran Bretagna, dalla Germania alla Francia, dall’Italia alla Spagna. La ragione del successo produttivo di questo vitigno - ciò appare subito evidente ai ricercatori - è legato a caratteristiche enologiche non particolarmente nobili. Chi selezionò questo vitigno e lo volle promuovere ne era ben consapevole. L’Heunisch-Unno è molto produttivo ma poco zuccherino. Fa grandi quantità ma non eccelsa qualità. Certo è la varietà più precoce della viticoltura nell’Europa centrale e settentrionale: è quella la vite che si vendemmia per prima, anche nella fredda Germania. Insomma un vitigno adatto a climi assai più rigidi rispetto al tepore mediterraneo, il campione capace di dare frutti nelle steppe della Pannonia o lungo il Danubio. Soprattutto un vitigno che darà tanta massa di vino, forse non buono ma abbondante, e che non avrà mai bisogno di essere diluito con acqua. La pianta ideale, date le sue caratteristiche, per essere piantata ovunque. Caratteristiche così poco qualitative da assegnare ai successivi nomi dell’Heunisch un significato dispregiativo - è il caso del Gouais francese il cui nome compare la prima volta nel 1283 - e da indurre i viticoltori europei, man mano che affinano le proprie tecniche, a usare sì questo vitigno-genitore ma ad incrociarlo con altri, in modo da abbandonare un’uva di scarsa qualità a favore di frutti più significativi ed enologicamente appaganti. Non è certo casuale che dopo un Medio Evo nel quale il “Nostro” Heunisch rappresenta il 75% della viticoltura, nei secoli successivi sia sostituito da alcuni suoi figli come il Traminer, il Riesling e il Rulaender, nati dall’incrocio del “Nostro” Heunisch con l’ “Altro” Frankisch, ossia con vitigni meno diffusi, meno conosciuti ma con l’andare del tempo rivelatisi qualitativamente interessanti. E’ comunque questa massa imponente di produzione vinicola medievale con un solo vitigno, nonché la clamorosa presenza genetica dell’ Heunisch in 78 vitigni europei contemporanei (è quasi più facile elencare i vini del tutto privi di questo avo piuttosto che stilare l’elenco di quelli attribuibili ai suoi lombi) a spingere tanto l’equipe americana di Carole Meredith quanto Attilio Scienza e i suoi ricercatori verso una nuova pagina della loro indagine. Antropologi, archeologi, botanici, linguisti sono mobilitati per rispondere a tre precise domande. Da dove viene l’Heunisch? Chi lo ha diffuso? Perché lo ha diffuso?
La risposta alla prima domanda non tarda ad arrivare. La moderna genetica individua il territorio di nascita dell’Heunisch in un areale compreso tra la Stiria (odierno cuore verde dell’Austria), la Slovenia, la Croazia e l’Ungheria. E’ lì, in quell’area, che qualcuno selezionò il vitigno, affidandolo poi a mani misteriose, che lo diffusero in ogni parte d’Europa.
Quanto agli archeologi, inizialmente il loro contributo è marginale, finché non appaiono due mappe. La prima ricostruisce le tracce archeologiche della fabbricazione di botti nel continente europeo, stabilendo l’epoca storica di questi insediamenti. La seconda è ancora più maliziosa, perché evidenzia tutti i luoghi dove si trovano lapidi funerarie, cippi o monumenti dedicati ai bottai in epoca romana. Sono queste due mappe a fornire all’equipe una nozione storico-enologica tanto importante quanto precisa: vi è stato un momento nel quale i romani si resero conto che il vino prodotto nell’Italia centrale e meridionale non sarebbe stato sufficiente a rifornire l’ esercito. Di qui la scelta di spostare il baricentro della viticoltura più a nord e di modificare le tipologie di trasporto del vino, passando dalla delicata anfora alla più capace e solida botte. Quando tramonta il sogno di Domiziano, che per editto aveva provato a concentrare tutta la produzione vinicola nell’amata Italia, appare chiaro che l’antico Falerno e gli altri prelibati vini campani continueranno sì ad essere conservati e trasportati in fresche anfore per arrivare alle mense dei ricchi nelle ville dell’Urbe, ma che per rifornire le legioni occorre altro. Torniamo ai numeri del più potente esercito del mondo: con Augusto le legioni sono 28 - in tutto circa 150.000 uomini oltre agli ausiliari - e ancora aumentano con Settimio Severo, quando le legioni diventano 33 e i legionari 350.000. La nascita e la morte del capostipite dei Severi sembrano ricalcare il percorso che l’impero sta compiendo. Nato nella libica Leptis Magna nel 146, Settimio Severo muore nell’odierna, britannica York il 4 febbraio 211. Il cuore di Roma pulsa sempre nell’Urbe ma ormai il nocciolo duro politico-militare dell’impero si è spostato a nord: è da Ravenna, da Lione, da Treviri, da decine di altre città e nuove fortezze che si possono reggere i fili, potenti e armati, di un’entità statuale che si stende dall’Atlantico alla Mesopotamia. Un impero così vasto può essere governato anche senza il consenso popolare, ma è indispensabile il consenso militare. Nei circa sessanta anni che separano la morte di Settimio Severo dalla proclamazione di Probo, il ruolo delle legioni cresce ulteriormente: sono i legionari, spesso in conflitto fra loro, a designare come imperatori i propri generali. Come abbiamo visto Marco Aurelio Probo, di madre pannona e moglie aquitana, nasce a Sirmio in Illiria (odierna Sremska Mitrovica, in Serbia) nel 232, per morire a 50 anni dopo aver capovolto l’editto di Domiziano e avere dedicato a questa missione gli ultimi anni della propria vita di imperatore-soldato.
Ma come vive, si muove, si approvvigiona in quegli anni un esercito sterminato, di circa 450.000 uomini, bisognoso di essere rifornito in terre sempre più estreme, fredde, nel lontano nord? Il solo pensare alla logistica, alle strade, alle modalità di trasporto di un paio di millenni or sono può dare un’idea delle difficoltà imponenti con le quali l’impero si dovette misurare.
Dapprima i romani individuano nell’area di Aquileia e nell’odierno Veneto il luogo ideale per coltivare uva, fare vino e trasportarlo. Le tracce delle botti dimostrano agli archeologi in modo inequivoco come da Adria e Aquileia i nuovi contenitori partano alla volta del Danubio e del Reno, i due fiumi-frontiera che le legioni sono chiamate a presidiare con forza, autentici avamposti dell’impero. Poi, all’improvviso, questo flusso di botti si interrompe. Spariscono le botti e con loro i benemeriti bottai, non più lodati da sontuosi e precedenti cippi funebri. Gli archeologi spiegano che è accaduto qualcosa. La distanza tra il luogo di produzione del vino e quello del suo consumo è diventata troppo ampia. Il costo e i tempi di rifornimento si sono fatti insostenibili. La stessa quantità di uva e vino prodotti sono inadeguati rispetto alle esigenze delle Legioni e dei rispettivi seguiti. E in ogni caso, questo il dato di fatto, nell’arco di pochissimi anni non solo le tracce delle botti ma anche quelle del loro trasporto svaniscono nel nulla. Un terzo indizio archeologico avrebbe forse consentito di risolvere il mistero anzitempo, ma distratti da una ricerca così ampia e documentata gli studiosi non lo mettono subito a fuoco. Eppure è proprio così, e saranno loro stessi a rivelarlo qualche tempo dopo: i più antichi falcetti agricoli, indispensabili all’impianto della vite, fanno la loro apparizione lungo il Reno e il Danubio negli anni immediatamente successivi alla scomparsa dei grandi traffici di botti da Aquileia verso il nord.
Nonostante questa traccia, dunque, i genetisti che si applicano alle origine dell’Heunisch non risolvono subito il secondo quesito. Chi ha fisicamente piantato il vitigno selezionato fra la Stiria e la Pannonia, e geneticamente rintracciato ai giorni nostri in quasi tutti i vitigni europei? Inizialmente i ricercatori si concentrano sull’arrivo degli Unni di Attila nel 451, quando occuparono la francese Troyes. Ma possono i soli Unni avere imposto un uso così diffuso di un vitigno? Improbabile. Si ragiona allora sulla migrazione degli Ungari del 905 in Francia, e da lì sulla possibile diffusione del vitigno nell’Europa medievale, e ancora si scava sul materiale genetico che potrebbe essere arrivato dall’ Ungheria e dalla Romania con i coloni tedeschi. Si tratta però di piste tutto sommato limitate rispetto alla possanza del fenomeno Heunisch, sulle quali i ricercatori sono scivolati a metà della loro ricerca. Gli scienziati brancolano nel buio. Quelli italiani sono anche tratti in inganno da quel nome “Unno”, che suona assai poco romano e molto barbarico. Gli altri, americani e tedeschi in testa, cercano un’origine del vitigno più vicina all’apice della sua diffusione, più prossima al medioevo: difficile immaginare che la genesi e la diffusione dell’Heunisch potessero affondare in un’epoca antecedente di secoli. Quando tuttavia si moltiplicano i ritrovamenti archeologici relativi all’uso di botti lungo il Danubio ed il Reno, i sospetti cominciano a farsi largo. Sono gli storici a dare in questa fase un contributo prezioso. I testi di Cesare (55 a.C.) e Tacito (100 d.C.) confermano che in Germania non esisteva allora nessuna forma di viticoltura - l’unica bevanda alcolica consumata diffusamente era ottenuta dalla fermentazione di cereali – ma un grande passo avanti nella ricostruzione del puzzle è dato dalla testimonianza dello storico romano Dione Cassio, che certifica come intorno al 299 furono realizzati diversi impianti di vigneti lungo il Reno e il Danubio, per rifornire di vino le legioni e per rinsaldare la presenza di Roma. A questo punto il mosaico comincia a comporsi e a essere suffragato da prove incontrovertibili. E’ la storia a confermare il percorso di Marco Aurelio Probo, l’uomo che ha abolito l’editto di Domiziano e imposto l’impianto di viti in Europa. La ragione economica, oltre che politica ed enologica della sua scelta, non è difficile da indovinare. Con una sola mossa politica l’imperatore risolve il problema di un vino veneto la cui produzione è inadeguata per l’esercito; economizza tagliando il dispendioso trasporto da Aquileia sino ai confini più estremi, rendendo superflua la stessa produzione delle botti destinate alle regioni più a nord dell’attuale Germania e agli avamposti più a est dell’odierna Ungheria; consegna alle legioni la vite che è insieme uno strumento di autosufficienza alimentare, un insediamento fisico indispensabile per definire i confini lungo i quali i legionari si devono attestare, un’attività agricola capace di integrare i soldati con le popolazioni soggiogate. Una mossa davvero lungimirante, e tutta racchiusa in una minuscola pianta. Dopo un altro anno di ricerche saranno allora gli archeologi a confermare di nuovo la svolta di Probo. Gli scavi, che sino alla sua epoca mostrano grande ricchezza di ritrovamenti di doghe con citazioni riferite al vino e che attestano il trasporto fluviale di vino prodotto in altri luoghi, lasciano a un tratto spazio al ritrovamento di ben altri oggetti, risalenti ad epoca di poco successiva. Questa volta dalla terra non emergono più tracce di botti e di legni bensì solide Falces putatoriae. E’ lì, soprattutto sulla riva sinistra del Reno e sulla destra del Danubio, dove le legioni di Probo avevano i loro accampamenti e fortilizi, che gli scavi restituiscono le falci romane della coltivazione della vite, usate con grande lena dalle comunità dei legionari-coloni. Così aveva voluto Marco Aurelio Probo, ribaltando i voleri di Domiziano e facendo dell’esercito di Roma anche il più formidabile strumento di impianto e coltivazione della vite in tutta Europa. Il luogo preciso della selezione del vitigno delle legioni resta avvolto nel mistero: il crinale lungo il quale ciò accadde non è tuttavia più lungo di 300 km, muovendo nel territorio che abbraccia parte dell’Austria e l’attuale Ungheria, passando proprio attraverso - forse questo è un indizio - le terre natali di Probo. Sconcerta, per contro, la contemporaneità degli impianti fiorenti lungo il Danubio e il Reno e l’interruzione dei movimenti di botti dalla laguna veneta attraverso le Alpi. Ancor più stupisce il radicamento in tutta Europa di un vitigno capace di dare grande quantità di vino e di maturazione precoce, adatto anche ai climi nordici, e la longevità di un vitigno che arriverà a produrre un’impressionante massa di liquido lungo tutto l’alto medio evo. A ben vedere, tuttavia, nessun altro potere politico-militare avrebbe potuto gestire una simile operazione, radicando un proprio prodotto in modo così capillare e alle più disparate latitudini. Nessuna migrazione di Unni, invasione barbarica, colonizzazione agricola di tedeschi avrebbe mai potuto conseguire un risultato che era soltanto alla portata della Roma imperiale, e della sua scelta di eleggere la vite a proprio simbolo militare, agricolo, politico. Gli ultimi dettagli che sanciscono la clamorosa teoria, arrivano gli scienziati da ricerche parallele e interdisciplinari. Gli storici delle lingue forniscono le ulteriori conferme. Si scopre che già nel 278 d.C., nei primi vigneti piantati dalle legioni di Probo attorno a Vindobona (la Vienna che all’epoca già contava 20.000 abitanti) le varietà più importanti sono chiamate Heinischen . Dalla Francia giunge l’esito di una ricerca che segnala come due anni dopo, nel 280 d.C., è piantato nel lionese un vigneto denominato Monte d’Oro: il nome è del tutto identico a quello assegnato da Probo alle colline di vigneti che egli stesso volle impiantati nella sua città natale, la Sirmio illirica. Emerge poi che anche un vigneto dalmata ha identico nome, e analoghe sono le varietà piantate. Identici nel nome e del tutto affini in termini genetici risultano infine essere i più antichi vigneti attorno alla città tedesca di Heidelberg.
Francia e Dalmazia, Germania e Britannia, Illirico e Iberia. Ovunque le Legioni piantano viti. Le stesse viti con lo stesso vitigno. A volte dando lo stesso nome alle colline coperte di filari, sebbene lontane fra loro migliaia di chilometri. La possente macchina da guerra di Roma pianta più intensamente in Pannonia e lungo il Reno, dove prevale una visione più politico-militare del vino. Con minore furia legionaria ma analoga intensità i romani piantano nella Gallia ormai soggiogata, dove invece si affermerà una pacifica e assai fruttuosa visione agricolo-commerciale del vino. E lo stesso accade in Britannia, nell’Iberia più calda e nei Balcani, nell’Italia del Nord e nelle odierne Svizzera e Austria. Ma ovunque, sempre e comunque le legioni di Probo ricoprono l’Europa di viti dell’Heunisch, l’Unno, il “Nostro”. Il cui nome romano fu forse, banalmente, il Nostrum. Nostrum come il Mediterraneo, Nostrum come il Vinum. Ora il mistero dell’ Heunisch è svelato. Sappiamo da dove viene, chi lo piantò, perché lo fece.
Poi, dopo l’ Editto di Marco Aurelio Probo, arriverà nel 313 l’imperatore Costantino con il suo Editto di Milano. L’impero spalancherà le porte al cristianesimo. Nell’arco di qualche decennio il gioco sarà fatto: il dio pagano che si beve con Bacco sarà il sangue del Signore sull’altare cristiano. Il Vinum diventa per sempre un’icona d’Europa, il continente indissolubilmente legato al suo mito. Probo ha voluto ovunque le viti di Roma. Costantino aggiunge all’impero la nuova religione. Ma questa del vino e del cristianesimo è un’altra storia. A noi, per ora, interessa solo la storia seducente, commovente, finalmente provata persino nel suo Dna, di quella che fu Roma Caput Vini.
Capitolo 16. Legere - Il potere dei nomi
Il nome è un grande specchio, chinatevi a osservarlo. Trovate riflessi la vita, l’uomo, le verità, gli inganni. Saper leggere un nome, qualsiasi nome, vi farà stare comunque un gradino più in alto nella contemplazione di una storia. L’origine del termine Legione, per esempio, spiega come il Legere latino abbia un significato diverso dal Leggere italiano. Raccogliere, adunare, arruolare: è questo il Legere della superpotenza che crea, arruola la Legione, strumento principe dell’espansione imperiale. Ed è proprio nelle legioni romane il filo della nostra storia, che ci aiuta a scoprire come la civilizzazione di Roma Caput Vini non sia solo geneticamente scolpita nel Dna di un vitigno: da migliaia di anni questa epopea è immortalata anche nei nomi dei vini. Ripartiamo da qui. Nel 280 d.C. l’imperatore Probo cancella l’editto di Domiziano, sancisce la fine dei rifornimenti di vino con l’ingestibile trasporto di botti da Aquileia ai territori dove sono stanziate le legioni, fa selezionare un vitigno - presumibilmente nel natìo Illiricum ma certo in un areale compreso fra la Stiria e la Pannonia (fra Austria, Dalmazia, Croazia, Serbia, Ungheria) - affida questo vitigno alle legioni e impone il suo impianto negli sterminati territori sottoposti. Bandita da Domiziano, la coltivazione della vite è trasformata da Probo nello strumento per fissare i confini dell’impero e nell’attività operosa delle campagne in tempo di pace. In quale contesto l’imperatore determini tutto ciò è presto detto. Quando sale al trono Probo dispone di una massa d’urto di circa 450.000 uomini, divisi in 38 legioni. La Valeria Victrix presidia la Britannia dall’odierna Chester, la Minervia difende Bonna oggi Bonn, l’ Italica è di stanza in Rezia a Castra Regina oggi Ratisbona, mentre la Gemina veglia su Vindobona ossia Vienna, la celebre Flavia Felix occupa Singidunum che sarà Belgrado e così via sino alle legioni più estreme, la Traiana Fortis ad Alessandria d’Egitto, la Fulminata lungo i confini della Cappadocia e la Cyrenaica nella provincia dell’Arabia Petraea. Sappiamo per certo, inoltre, che il nuovo imperatore di legioni ne creò almeno altre due. Il nome dell’Isaura Sagittaria rivela che la prima fu una legione di arcieri - caso piuttosto raro nell’esercito romano - stanziata nell’attuale Anatolia, vicino alla moderna e marina Antalya. La Noricorum, altra legione voluta da Probo e poi potenziata da Diocleziano , conferma invece come la difesa del Danubio fosse l’autentica ossessione del vertice imperiale. E’ quel corso d’acqua la barriera più esposta alle ondate barbariche, ed è lungo il letto danubiano che i legionari piantano la vite con maggiore intensità, indizio certo del loro carattere stanziale. Sono dunque almeno 40 le legioni di Probo potenzialmente incaricate non solo di difendere l’impero e guerreggiare, ma anche di piantare e coltivare la vite. Un’opera immensa, della quale possiamo ricostruire le tracce precise anche attraverso i nomi di vini e vitigni. Non sono pochi i nomi capaci di evocare Roma Caput Vini.
Capitolo 17. Romanae - Vosne Romanèe, Romanée Conti, Romanée Saint Vivant
Un villaggio nel cuore della Cote d’Or, due Cru di fama mondiale, la bottiglia forse più prestigiosa del mondo che associa il nome del principe Louis François de Bourbon Conti alle minuscole ma blasonate porzioni di terreno oggi celebrate come La Romanée.
L’origine del nome è spiegata così in “Grands Crus de Bourgogne, Histoires et traditions vineuses” (Beaune, Jean Dupin, 1955), dallo scrittore e Grand Officier du Tastevin Etienne de Moucheron: “Recenti e precise ricerche ci obbligano a concludere che con l’eccezione del Narbonese controllato da Roma, non c’erano vigne nel resto della Gallia prima della conquista di Cesare. La coltura della vite data dunque dal primo secolo della nostra era. Sta forse questo a significare che i Galli non bevessero vino? Sicuramente no, ma lo importavano, ed in grande quantità visto che erano i primi clienti di Roma. Quanto alla Romanée va ricordato che l’editto di Domiziano nel 92 a.C. ordinò l’espianto di viti da tutta la Gallia. Questo protezionismo durò duecento anni e solo nel 281 l’imperatore Probo abolì l’editto. Non fu raro, allora, scorgere i legionari che sotto lo sguardo placido di un decurione scavavano vigorosamente il roccioso suolo delle nostre colline. Così si ricreò quel vitigno di Borgogna che sarà il più antico ed apprezzato di Francia per lunghi secoli. La provincia Cisalpina, felice della prosperità ritrovata, volle esprimere all’imperatore Probo la propria riconoscenza e gli fece dono di una vigna nel cuore della Côte. Di qui il nome di Romanée, da allora attribuitole. Dal canto suo, il lusingato cesare, facendo coniare una nuova moneta con la propria effigie, volle che il retro fosse ornato con un grappolo d’uva”.
In quella terra Roma Caput Vini non si è tuttavia limitata a lasciare la propria traccia nella bottiglia più famosa del mondo. Tutti i vini rossi di Borgogna a denominazione Bourgogne-Irancy impiegano ancora oggi il frutto di due vitigni dai nomi eloquenti: Romain e César. All’analisi del Dna la comparazione dei due vitigni offre un risultato che non ci stupisce più. Sotto il profilo genetico, le due varietà sono identiche.
Copyright © 2000/2026
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026