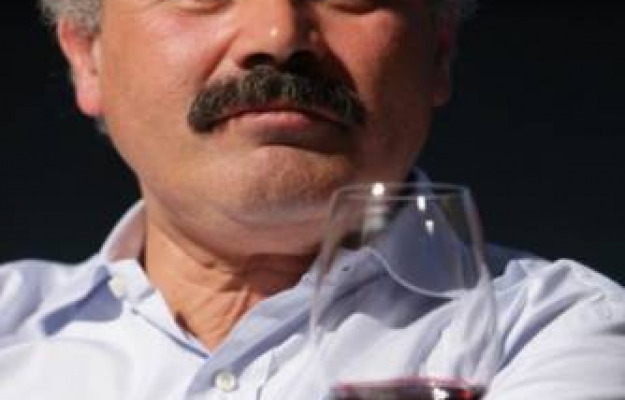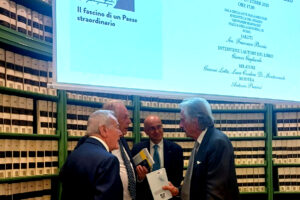Semplificazione delle regole, alleanza tra “controllori e controllati”, rapporto nuovo, virtuoso e fiduciario tra imprese ed istituzioni. Ecco gli atout del percorso, semplice a dirsi, più complesso a farsi, per semplificare e cambiare, in meglio, il vino italiano. O meglio, dell’Italia nel suo complesso, partendo dal vino, che è una delle sue eccellenze più apprezzate e rappresentative nel mondo. A proporre questo nuovo inizio il patron di Eataly (e produttore di vino con Fontafredda-Mirafiore), Oscar Farinetti, che nel nuovo store di Roma, ha chiamato a raccolta produttori e istituzioni. E se tutti sono concordi che ci siano cose da cambiare, da Farinetti ad Angelo Gaja, tra i produttori più ascoltati del Belpaese enoico, dal direttore dell’Ispettorato Controllo Qualità e Repressione Frodi (Icqrf) del Ministero delle Politiche Agricole, Emilio Gatto, a Giuseppe Vadalà, dirigente del Corpo Forestale dello Stato, fino alla senatrice Leana Pignedoli, responsabile per il Pd della Commissione Agricoltura del Senato, le ricette per farlo sono diverse.
“Sono nuovo nel vino - ha detto Farinetti - e forse per questo vedo meglio cosa non funziona. Anche se, va detto, non stiamo di una situazione non negativa per il vino e per il cibo italiano, ma fantastica, per certi aspetti. Tutto il mondo vorrebbe mangiare vivere all’italiana, il nostro life style è desiderati, ammirato, stimato. L’agroalimentare va bene sui mercati internazionali, il vino va benissimo. Ma possiamo fare di più, molto di più. In un annetto di sana politica, credo che si possano raddoppiare si le esportazioni che l’incoming di turisti, due asset fondamentali per mettere a posto il Paese in fretta. Pensiamo che cosa sarebbe esportare 30 miliardi di cibo in più. Siamo a Roma, una città che fa 10 milioni di turisti all’anno. Londra ne fa 33 milioni, a Manhattan 47. Perché noi, con la Cappella Sistina, il Colosseo e tutto il resto, che gli altri non hanno, non riusciamo a fare numeri questi numeri? Ma quando parlo di “sana politica” - continua Farinetti -
intendo anche ruolo proattivo dei produttori, l’unione di forze tra chi produce e chi controlla, che lo devo fare, perché non c’è niente di peggio del falso, per la nostra immagine. Una sana collaborazione tra chi amministra e chi è amministrato per una “rivoluzione dolce” di mentalità, che deve essere di tutti, deve essere culturale, dobbiamo tutti smettere di lamentarci di cosa non va, e fare di più. Ma per farlo dobbiamo semplificare. La mia esperienza di vita e di imprenditore, mi dice che tutto ciò che è progettato in maniera semplice funziona, tutto resto no. E non è vero che il mondo è complicato il mondo è facile. E gli imprenditori del vino hanno bisogno di andare nel mondo. La loro preoccupazione deve essere quella di fare un grande vino in campagna e in cantina, e venderne il massimo possibile ed al prezzo più alto possibile nel mondo, e per farlo abbiamo bisogno di non essere “distratti” troppo da altre attività. Abbiamo 11 o più enti controllori, che spesso fanno le stesse cose, mentre in Francia ce n’è 3. Mi chiedo perché. A fare controlli vari ci sono l’Icqrf, la Forestale, i Nac, i Nas, la guardia di Finanza, Valoritalia, i Consorzi, le Camere di Commercio, l’Autorità delle Dogane, le Asl, l’Arpa, gli assessorati all’Agricoltura delle Regioni, e delle Province. I controlli devono esserci, anzi, è una tutela per gli onesti. Ma così sono troppi, si potrebbero raggruppare, per guadagnare tempo, e impiegarlo per produrre e vendere con più qualità”.
Ragionamento semplice, ed ineccepibile dal punto di vista teorico.
“Difficile non essere d’accordo. Ma quando si scende nella pratica le cose sono più complicate - aggiunge Gatto, a capo dell’Icqrf - e bisogna essere certosini e delicati nel semplificare. Perché il rischio, nel semplificare, è che non si tenga conto del movimento storico che ha portato, oggi, alla complessità. Nel vino, quando si guarda agli enormi adempimenti burocratici che effettivamente ci sono, si ignorano i fatti che hanno portato a questa situazione. Ci scordiamo che la normativa discende da fonti comunitarie, e che è dovuta all’impostazione delle politiche di intervento dello stato nell’economia, che ci hanno portato da un settore asfittico, ad un settore dove abbiamo dovuto introdurre limitazioni alla produzione, incentivi di vario genere, e dove l’intervento pubblico ha contribuito a produrre uno sviluppo clamoroso. Ma è anche vero che oggi siamo in situazione in cui tutti i soggetti che fanno i controlli, praticamente, lavorano in vigneto, in cantina, nella distribuzione. Semplificare è doveroso, e anche possibile. E forse nemmeno difficile. Ma va fatto in modo accurato e cercando di tener conto dei vari interessi del settore. E in verità stiamo cercando di farlo da tempo. Sia coordinando i controlli con gli altri soggetti, scambiandoci dati, cercando di non sovrapporci se non dove situazioni particolari lo rendono necessario. Sia cercando di cambiare la normativa, e stiamo spingendo per due cose fondamentali: l’informatizzazione dei documenti di accompagnamento, e lo schedario vitivinicolo con tutte le informazioni precise sulle aziende. Ma è difficile pensare di farlo dall’oggi al domani. E purtroppo, i controlli - chiude Gatto - servono: solo in questi mesi di vendemmia abbiamo sequestrato 120.000 ettolitri di vino, più altri di mosti e succhi illegali, per un valore di 9 milioni di euro”.
Ma sul fatto che i controlli servano, nessuno ha dubbi.
“Questo Paese ha una possibilità di invertire la rotta di questa fase difficile, con 2000 miliardi di debito pubblico, e la crescita ferma da 10 anni - dice la senatrice Pinedoli - se crede su quello che è il suo patrimonio, e l’agroalimentare ed il vino, in particolare, lo sono. Lo dicono i numeri, una domanda che sta crescendo sui mercati internazionali, con il prodotto agricolo che è unico nella sua tipicità, è garante di una unicità che altri settori non hanno: non può essere de localizzato. Ma serve una Politica che deve credere in questo. La domanda made in Italy c’è, nei mercati esteri soprattutto. Dobbiamo raggiungerla. Ma il Paese deve esserne convinto per dare via, e velocemente, alla sburocratizzazione. L’inefficienza sistema pubblico è un grande freno, ha ritmi pachidermici rispetto ai ritmi dell’impresa e del mercato. E non è vero che non sappiamo dove stanno i problemi, e le inefficienze. Il problema è come si affrontano. Io ho già presentato 3-4 disegni di legge, che peraltro non costano, anzi, porterebbero risparmi di tempo e di denaro. Ma sono fermi in un cassetto, come se ci fosse un freno alla volontà di cambiamento. È un discorso che non dobbiamo avviare, lo abbiamo avviato molte volte. È un discorso che va chiuso. Dobbiamo darci un tempo entro il quale realizzare dei cambiamenti, è un impegno che anche il prossimo governo si deve assumere. E deve cambiare anche l’approccio del pubblico con l’impresa, che non deve essere vista con diffidenza, perché la stragrande maggioranza delle imprese agricole sono oneste e virtuose. Vanno trovati obiettivi comuni a pubblico e privato. E produrre e vendere alta qualità lo sono di sicuro. Operativamente, alcune cose si possono fare. Oggi ci sono enti che fanno più o meno gli stessi controlli, ma che rispondo a Ministeri diversi: Agricoltura, Sanità, Economia. Come minimo è indispensabile una banca dati con l’elenco dei controlli effettuati e dei risultati, con uno scambio di informazioni tra enti che crei un profilo dell’azienda, un indice di affidabilità. Se controllo 20 volte su aspetti diversi un’azienda che va bene, perché non pensare ad un meccanismo premiante, che magari nel tempo riduca i controlli in quella realtà. Sarebbe un riconoscimento alle imprese imprese virtuose, che diventerebbero anche alleate delle istituzioni sul territorio. Una bancadati, però, che deve essere solo il preludio ad una diminuzione degli enti. Dobbiamo arrivarci, anche se è difficile, perché ognuno ha delle peculiarità. Ma non possiamo mantenere questa frammentarietà, c’è troppa sovrapposizione di funzioni”.
Se tutto questo si tradurrà in fatti, il tempo lo dirà. Ma intanto, un tentativo in più di dare vita ad un percorso che tanti ritengono, da tempo, fondamentale, ma che non si è mai concretizzato, di certo non è un male.
Focus - L’Intervento di Angelo Gaja
“Se l’unico made in Italy consentito fosse il made in Italy al 100% (origine, luogo di lavoro, materia prima) il vino sarebbe il campione assoluto”. Esordisce così, Angelo Gaja, uno degli imprenditori di maggior successo del vino italiano nel mondo, e tra i più ascoltati nel Belpaese. “Il vino italiano, come sistema imprenditoria, funziona eccome. Abbiamo superato scandali incredibili. E non parlo solo del famigerato scandalo del metanolo, nel 1986. Subito dopo la guerra, per esempio, al nord si facevano vini in grande quantità, bassi di alcol e alti di acidità, e c’era la consuetudine “illegale” di aggiungere zucchero. Per risolvere, la scelta politica fu di legalizzare la pratica di importare vino dal sud per tagliarlo. È andata avanti per 30 anni, e il mondo del vino l’ha accettato, e si è diffusa una frode commerciale di fatto, in modo clamoroso. Ancora: fino a due anni fa il Paese produceva troppo, e l’eccedenza veniva eliminata con contributi pubblici per la distillazione, che si è fatta ogni anno, con vendemmie ricche o scarse che fossero. E nonostante questo, il vino italiano non è affondato, ma è andato avanti. È iniziata la rinascita, perché il sistema ha funzionato. Si sente molto parlare di fare sistema, cabina di regia, ma chi lo dice porti dei progetti dettagliati, non così come un mantra. Il “sistema” lo hanno fatto uomini che hanno costruito l’immagine del vino italiano nel mondo. Come Paolo Desana, “padre” prima legge sulle denominazioni, che il prossimo anno compie 50 anni, e che ha iniziato un percorso che oggi ci ha portato ad avere più del 50% è vino a denominazione o indicazione geografica. Uomini come Piero Antinori e Giacomo Tachis che, nel 1971, mentre si pensava, giustamente, a tutelare la tradizione, aprirono alla creatività e inventarono il Tignanello, chiamandolo vino da tavola, spendendo il loro marchio, e creando (insieme al Sassicaia), il movimento dei Supertuscan, che oggi sono una ricchezza enologica della Toscana e dell’Italia. E lo stesso Antinori, un leader come non hanno neanche in Francia, ha creato una nuova cantina, al Bargino, che è uno stabilimento enorme, vestito da boutique.
Abbiamo anche grandi enologi e consulenti, come Riccardo Cotarella e Carlo Ferrini, tra gli altri, che hanno aiutato chi voleva investire nel vino a non fare fesserie, hanno aiutato a crescere i produttori, contribuito ad una crescita qualitativa importanti. Persone come Carlin Petrini, che con Slow Food ha fondato anche l’Università di Pollenzo. E dico se danno soldi pubblici a quell’Università, sono soldi, ben spesi, per forma dei soggetti che imparano l’agroalimentare del mondo, ma studiano in Italia, visitano l’Italia, si arricchiscono e diventano narratori del gusto italiano, commercianti, sommelier, divulgatori del nostro patrimonio. Abbiamo uomini e donne capaci nel vino, giovani che sono la nostra forza. Abbiamo tanti artigiani del vino, spesso sviliti dai grandi industriali. E non è giusto. Gli artigiani sono complementari all’industria, fanno da richiamo, e fanno cose particolari, e i giudizi internazionali li premiano al 90% delle volte. Piccolo non è bello, è utile.
Ci sono uomini come Farinetti, che con Eataly, come nel caso di New York hanno avuto un successo incredibile per l’Italia, che racconta di come per noi, nel mondo, ci siano praterie. Spazi che però, vanno conquistati, perché i competitor come Francia o Australia di certo non sono li a regalarceli. Consci di questi punti di forza, però, dobbiamo stare attenti ad altri fenomeni. Quest’anno, dicono le stime, produrremo 39,3 milioni di ettolitri. Il cambiamento del clima avanza, e se andiamo ancora sotto a queste quantità diventa difficile, serve molta trasparenza. Gli addetti ai lavori parlano di un calo, sul 2011, dal 15 al 25%, le organizzazioni del -6-8%. C’è qualcosa che non torna. E in ogni caso, se contiamo che l’export assorbe 22 milioni di ettolitri, e l’Italia 25, che in tutto fa 47. Rischia di mancare il vino. Ma sui mercati esteri dobbiamo essere capaci di venderlo meglio, dobbiamo allargare le tante nicchie già aperte, non abbassando il prezzo, ma alzandolo, e non solo per incassare, ma per anche per ridistribuire reddito sulla filiera, in primis ai vignaioli. E poi dobbiamo separare l’immagine del vino da quella dei superalcolici e dei softdrinks. Sono cose totalmente diverse, in tutto. Serve, in generale, una maggiore trasparenza: i fondi per la promozione dell’Ocm, per esempio, a chi vanno? Sono soldi pubblici, serve un elenco pubblico ...”
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025