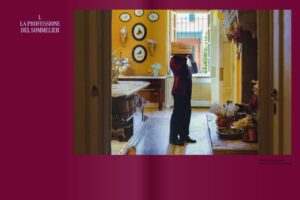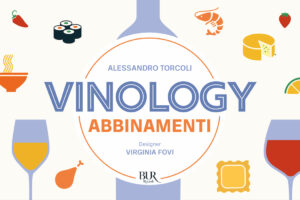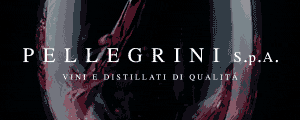Sono tante e in molti se ne occupano. Sono “Le sfide strategiche per il vino italiano” al centro della prima edizione verticale del Food Industry Monitor (Fim) - l’osservatorio sulle performance delle imprese italiane del food & beverage, realizzato da Ceresio Investors in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Unisg) di Slow Food - nel convegno andato in scena alla Biblioteca Internazionale “La Vigna” a Vicenza, grazie alla volontà di Remo Pedon, presidente dell’istituzione vicentina di rilievo internazionale, e con il patrocinio di Confindustria Veneto, nei giorni scorsi.
“Abbiamo cominciato ad occuparci di agroalimentare nel suo complesso 16 anni fa - ha introdotto Gabriele Corte, dg Ceresio Investors - e per la prima volta, con il gruppo di lavoro dell’Università di Pollenzo, abbiamo prodotto un’analisi verticale di un solo settore, il più importante, quello del vino. E ci è parso naturale e prestigioso presentarlo in questo tempio della cultura vitivinicola e agroalimentare con i suoi 62.000 volumi”.
A presentare i dati dell’Osservatorio è stato Carmine Garzia, professore di Management all’Università di Pollenzo e responsabile scientifico Fim, che ha illustrato, dapprima, i dati generali dell’evoluzione del settore, per poi arrivare a quelli originali scaturiti dall’analisi dei bilanci di 165 imprese, differenziate per tipologia, che rappresentano circa 5 miliardi di fatturato - più o meno simile al campione analizzato da Mediobanca, ma per dimensioni aziendali inferiori - su una stima del valore del settore di 16 miliardi di euro. Lo scenario generale vede, ancora, l’Italia leader nei volumi di esportazione, ma non nel valore, con 21,8 milioni di ettolitri nel 2024, e con un prezzo medio per litro significativamente più basso di quello francese. “Con i 3,7 euro al litro del vino italiano esportato, contro i 9 di quello francese, giochiamo un altro campionato”, ha sottolineato Garzia. Rassicuranti i commenti sull’inflazione, ma non quelli sui consumi e sul valore del settore vino. “In realtà in Italia le cose non vanno così male - ha commentato Garzia - guardando l’inflazione scomposta tra food ed energia, si vede che il rialzo è stato causato dal settore energia e che l’inflazione è rientrata, portandoci a uno dei livelli più bassi nell’Unione Europea, ma questa situazione è dovuta anche al taglio dei prezzi al consumo operati da molte aziende”.
Un poco di preoccupazione, invece, desta il dato dei consumi delle famiglie per il food, incluso il vino, che cresce dell’1,8%, cioè come l’inflazione, e che quindi è pari a zero. Il settore in Italia è inchiodato e non cresce. Relativizzando lo sguardo, a livello globale, l’intero settore del vino vale 90 miliardi di euro alla produzione, meno del fatturato di un’azienda alimentare Svizzera che fa le capsule del caffè.
Tuttavia, l’export è cresciuto costantemente con una media annua che è stata del 4,8% tra il 2019 e il 2024. Ma l’internazionalizzazione è ancora limitata: nonostante il 28% dell’export sia diretto verso gli Usa, infatti, solo poche aziende controllano direttamente la loro distribuzione. Questo evidenzia una vulnerabilità strategica rispetto alle politiche doganali e alle dinamiche geopolitiche”.
Ma, semplificando, guardando a “quanto guadagnano” le cantine italiane, “la nostra analisi di bilancio sulle 165 imprese vinicole italiane del panel - ha spiegato Garzia - evidenzia una crescita dei ricavi del 2,5% nel 2024, con una redditività commerciale (Ros- Return on sales) del 5,9% e un ritorno degli investimenti (Roic - Return on Invested Capital) medio del 5,3%. Il tasso di indebitamento si mantiene sotto controllo (1,04), segnalando una buona solidità finanziaria. L’analisi per cluster di aziende omogenee per tipo di business model adottato evidenzia che quello dei trader (imbottigliatori, ndr) emerge come il più redditizio, con un Roic medio 2020-2024 del 8,96%, superando produttori integrati (le aziende vitivinicole) e cooperative. Questo dato suggerisce una trasformazione strutturale del settore, dove la capacità di presidiare i mercati e gestire la distribuzione diventa centrale rispetto al focus sulla produzione agricola. Il comparto vino italiano ha bisogno di un salto strategico: non basta più esportare bottiglie, serve esportare valore, cultura e modelli produttivi. La sfida è passare da una logica di volume a una logica di posizionamento”.
Alla presentazione dei dati è seguita una tavola rotonda - moderata dal professor Michele Antonio Fino dell’Università di Pollenzo - per commentarli in particolare relativamente agli argomenti di preoccupazione e alle attese per la fine del 2025. “L’ultimo trimestre dell’anno - ha ricordato Marzia Varvaglione, produttrice in Puglia, con Varvaglione 1921, e presidente Ceev-Comité Européenne des entreprises Vins - è storicamente cruciale per le imprese produttrici di bollicine e rossi. A livello globale, si registra un clima di preoccupazione: in California la mancanza di domanda ha costretto le aziende a lasciare uva sulle piante. I dazi di Trump stanno incidendo negativamente sulle nostre esportazioni verso gli Usa, che trovano un’ulteriore complicazione nel mancato export dei vini statunitensi in Canada, quindi costretti sul loro mercato interno. In Europa, mentre in Francia la Borgogna continua a resistere grazie a un’“alone di esclusività”, a Bordeaux si parla in modo concreto di espianti e lo Champagne riduce la produzione. L’Italia soffre non solo per il prezzo medio all’esportazione decisamente più basso di quello della Francia, ma anche per l’iper-frammentazione delle aziende del settore”.
“Nonostante le difficoltà - ha sottolineato Filippo Polegato, neo nominato vice presidente di Unione Italiana Vini - Uiv e ad di Astoria - il settore delle bollicine sta generalmente tenendo i numeri in Italia, pur registrando una riduzione della marginalità. Questa contrazione è dovuta al calo del potere di acquisto delle famiglie, che impone alle aziende di ricorrere a “prezzi aggressivi" per mantenere il mercato. La vera sofferenza si concentra sul vino rosso, in particolare in regioni come Toscana, Montalcino e Puglia. Una crisi non solo legata al potere di acquisto, ma anche al fallimento nella comunicazione. Un altro elemento di crisi è la perdita del consumo di vino, escluse le bollicine, per l’aperitivo, mentre la ristorazione mantiene consumi più in linea. La risposta a queste sfide include l’aumento della trasparenza e l’incentivo alle visite in azienda, concepite come esperienze complete e non soltanto come degustazioni. È necessario che le aziende si interroghino se il vino rosso sia ancora attuale e moderno, in quanto i consumatori, e in particolare quelli delle nuove generazioni, chiedono prodotti più freschi, facili da capire e con gradazioni alcoliche più basse”.
Profilo a cui ben risponde il vino italiano di maggior successo, il Prosecco, non solo nel calice, ma anche per le corrette politiche consortili di governance delle denominazioni d’origine, “senza le quali - ha evidenziato Luca Giavi, direttore Consorzio Prosecco Doc - si rischia il fallimento. Il Prosecco Doc sta andando bene sicuramente grazie alla sua elasticità negli abbinamenti, all’apertura al suo uso nella miscelazione e al suo grado alcolico contenuto. A questo proposito stiamo avendo buoni risultati producendo Prosecco naturalmente intorno ai 9 gradi alcolici, e stiamo lavorando alle necessarie modifiche dei disciplinari e delle normative. Aggiungo anche il favorevole posizionamento di prezzo che garantisce una migliore marginalità agli esercenti: per esempio negli Usa, ad Aspen, un calice di Prosecco costa 16 dollari contro i 22 di uno di Champagne. Infine, il Consorzio sta lavorando per aumentare la trasparenza. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ultima modifica al disciplinare di produzione del Prosecco Doc (presumibilmente entro l’anno), al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del consumatori - ha spiegato Giavi - i soggetti non iscritti al sistema di controllo certificato che fanno imbottigliare a loro nome del Prosecco Doc, dovranno indicare tale status in etichetta con la sigla “Nr” (Not Registered) che indica che il vino è stato prodotto e imbottigliato da un soggetto (viticoltore, vinificatore, imbottigliatore) diverso dal titolare del marchio”.
Alessandro Santini, head of corporate advisory and investment banking Ceresio Investors, ha osservato che, sebbene il settore sia stato meno interessante per gli investitori negli ultimi due anni a causa del calo dei fondamentali economici, rimane “estremamente interessante” nel lungo periodo. “L’imprenditoria italiana - ha sottolineato - è frammentata: l’85% del tessuto vitivinicolo italiano è composto da piccole aziende con poche risorse finanziarie. Per competere a livello internazionale e attrarre risorse umane qualificate, è fondamentale aumentare la dimensione aziendale attraverso aggregazioni. Tuttavia il vino è un investimento di lungo termine che per avere successo richiede un orizzonte di almeno 7-10 anni. Un approccio finanziario con un orizzonte di 3-5 anni, come quello tipico dei Fondi di Private Equity, rischia di danneggiare l’identità, la cultura e il posizionamento del brand. Ritengo che il settore sia ancora di interesse per investitori sia industriali, che vogliono crescere con l’aggregazione, sia finanziari consapevoli di dover rimanere sufficientemente a lungo”. Santini ha fornito un outlook “neutral” fino a fine anno, prevedendo - con un ottimismo che non si leggeva, però, sui volti in sala - una ripresa del mercato nel 2026, grazie alla dinamicità degli imprenditori italiani e a un miglioramento della comunicazione.
“I fondi di Private Equity hanno trovato recentemente in Italia terreno fertile trattando il vino come se fosse un bene di lusso - ha osservato, a questo proposito, Varvaglione - ma il vino non è soltanto una commodity, non è un moltiplicatore che consente di rivendere un’azienda in tempi rapidi, a meno che non si tratti di una grossissima azienda che, in qualche modo, si spersonalizza. Ricordiamoci che il vino è cultura, il vino rappresenta delle radici, asset che non possono essere né valorizzati né comprati a meno che le aziende non vengano acquisite da un’altra famiglia che ne erediti radici e cultura”. E, agganciandosi a questo tema e superando la fredda lettura economica, Antonio Fino ha sottolineato come agli 88 miliardi di euro della produzione mondiale di vino corrispondono territori, storie, diffusione di una cultura agronomica sul territorio di cui la Biblioteca la Vigna è depositaria, e sono anche l’ostacolo al degrado e all’abbandono del territorio.
All’incontro è seguita la proiezione del docufilm dedicato a Demetrio Zaccaria, l’imprenditore a cui si deve la fondazione della Biblioteca Internazionale “La Vigna” nel 1981, punto di riferimento di eccellenza per la ricerca e la documentazione nei settori vitivinicolo, agronomico e della cultura rurale, riconosciuta dal Ministero della Cultura di “Eccezionale Interesse Culturale” nel 2020. Il bel docufilm “La Vigna di Demetrio Zaccaria”, diretto da Manuela Tempesta, con Gianmarco Tognazzi (anche lui produttore di vino con La Tognazza, a Velletri) e co-prodotto da Kublai Film, ne racconta la storia.
Clementina Palese
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025