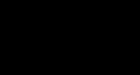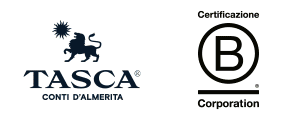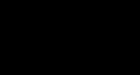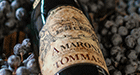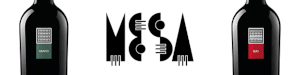Oltre 180 i racconti di tutta Italia nel concorso letterario “I giorni del vino e delle rose”, promosso dalla cantina Villa Petriolo di Cerreto Guidi. La giuria - presieduta dal critico cinematografico Enrico Grezzi e composta dalla cantautrice Chiara Riondino, dall’enologo di Villa Petriolo Federico Curtaz, dalla giornalista Cristina Tagliabue, da Ernesto Gentili della Guida “Vini d’Italia” de “L’Espresso”, dallo scultore Marco Bagnoli e dal sindaco di Cerreto Guidi Carlo Tempesti - ha decretato i seguenti vincitori: al primo posto il racconto “Ivre ovvero Cappotto Verdebottiglia (e porte scorrevoli)” di Giovanni Puglisi, Leonforte (Enna) e Daniela Pirani, Pieve di Cento (Bologna); al secondo posto, “Cammina, cammina” di Cristina Trinci, Empoli (Firenze); al terzo posto, “Il lago color del vino” di Luca Ragagnin e Enrico Remmert, (Torino).
Ecco, di seguito, i racconti, in versione integrale …
I classificato - Ivre ovvero Cappotto Verdebottiglia (e porte scorrevoli)
di Giovanni Pugliesi
Questo racconto non esiste da solo, si appoggia ad un racconto che è il più completo del mondo e il più vero, e non abbiamo pretese di espandere l’infinito, anche perché questa vanità lo spirito dei bambini se lo sogna. Questo è il gioco più triste.
* Uno, che non va spiegato *
e ci lascia un sogno di lucine, una prospettiva aerea da dentro la carlinga, un orlo tattile ci lascia il desiderio delle rose.
E fu così che per tornare il Piccolo Principe cadde morso e comprò il vino.
Prima mi sbronzo, poi lo scrivo.
Su un pallone lontano c’era un supermarket di legno d’olivo, e grasse signore vestite di giallo vendevano colori brevettati. Disse il bambino: voglio del vino. Posso offrirle un violetto carico, un giallo paglierino … Ma lui, che aveva il grano, e non arrossiva più per dire sì ma solo se gli andava, chiedeva dove fosse il bagno: aveva la pipì!: un dito grasso vestito di giallo volava alla porta con scritto toilette, volava consunto da Marlboro canarino. Lo prese rosso cuore come il tratto dei bambini contratto in uno spasimo di Nome di Fiore che non deve ricordarsi per ser Vivi.
Il Piccolo Principe sfogato dal vespasiano si lavò le mani, perché era pur sempre una personcina a modo; non se le asciugò sgocciolando di tutto sul legno d’olivo - Color Noce - non trattato. Intimidite dal gesto mai visto sul loro stellino, le grasse citrine cassiere gli diedero merce richiesta. Uscendo, il Piccolo Principe pensava che:
I suoi capelli, erano ben più gialli del grembiule delle cameriere;
E: Non aveva pagato, si contava gli spicci, nelle tasche.
Imbracciata la boccia si mise invano in cerca di un baobab disponibile, da ubriacare per far luce nella notte; ora che era lontana come mai la sua rosa, così separata ma intimamente reciprocamente sua. Principino si era arreso nel midollo, nelle spine; lei altrove, con fiori alteri e altre cose, sotto una calda campana.
• Due, o dell’Appeso. *
(Certe piante troppo grandi su un pianeta travertino; su un albero secco da un lato una faccia, coi capelli che sembravano una barba, il bavero sceso sugli occhi una benda bianca, i baffi capelli. Il Principe piccolo tremava a vedere la serpe di corda che lo aveva morso, annodarsi ad un ramo, spire intorno a una caviglia…)
Com’era solo. Oh, com’era solo, adesso che il vento stellare soffiava un po’ più freddo e un po’ più forte. Non c’erano che ombre e nemmeno amiche, non c’erano che luci e neppure utili. Neppure il grano, gli era rimasto.
Il vino gli diceva - Bevimi! E lui pensava: Strano, è un’altra storia, ma pazienza. E fece sorsi, gola calda, il cuore scappato dove? per non farsi inondare.
“Che fai?” – chiese. CheFFaIcHeFfaIIiChEfAAAiii? - il Piccolo Principe tre volte, ché non tradiva mai l’idea di fare una domanda.
“Sto appeso e vedere tutto al contrario mi fa felice”, rispose il revisionista.
Biondo bevve un altro goccio, tanto per avvicinarsi all’altrui posizioni; faceva una domanda, poi gli venne il mal di testa e stette zitto. Mai successo prima! Sedette di sotto all’appeso, pensò che il mento poteva avere un naso e come Revisione questo era un passo avanti non da poco.
Da lontano scorse due campane di vetro, e già qui cominciò a preoccuparsi, intanto andava prosciugandosi dalla bottiglia alla giugulare, ma del resto: qualsiasi forza è studiabile, sull’Asteroide.
* Tre Mendo, ovvero Calvario *
Un sentiero di spine gli stava imbottendo i piedi. Il pianeta era cavo e boscoso, senz’alberi, grotto di muschio; odorava di funghi a palline. Si schiuse al pensiero l’essente micete da lui conosciuto, or solo immaginato, i nomi sottratti dai libri di scienza, nella sua mente acidi i colori.
Pensava al deserto. Ma non al Sahara, all’aereo, alla volpe Paolo: al deserto pensava e basta, che certe cose a volte le scordi, se pagassi qualcuno ché seppellisca memorie e poi non le trovi, più sotto le dune a cercare ricordi. Disegnava nella sabbia che teneva tra le orecchie uno strumento con l’antenna e: “Gianluca, m’interessa questa rosa?” - “Com’è?” - chiedeva Gianluca, che era uno che non conosceva. “Bella”, rispondeva, e intanto inciampava. Derelitto. Sbattuto, ovattato, digerito, derelitto si sentiva se sentiva. Camminava con eco indistinte riflesse nella piccola persona, tante eco condensate nel cappotto come capelli di volpe, la falce che già patisce il grano e trascolora,
Contabili Rotolidicarta. Gli tornò in mente l’ubriaco e pensieri monarchici! Principe di cosa era? Costituzionale anticostituzionale concezionale i funghi vanno legiferati secondo il comma e l’equo canone delle pecore. Hic! Sic.
Mi vedi?
Urlava la campana rifratta due volte, una foto sfocata e sovresposta, scarto di un millimetro e mezzo. Occheccavolo, barcollava il principino. Idiota di un biondo, mi vedi? Son qui.
Il principe progettava reami in cui le quote Rosa maggioritarie non sarebbero state ammesse perché insurrezionali e sovversive e intanto inciampava, sul riflesso della rosa: davanti, mentre il riflesso della rosa, dietro, Crash. si scheggiava di cristallo, calpestata da uno specchio che l’aveva generata, lei e lo schianto, o il suo riflesso. Hic! Sigh.
Non agli astronomi, non all’aviatore avrebbe regalato un solo tintinnio di moneta che s’infrange sopra l’arido, non all’amore consegnava il morire di stella; si rialzava, duna, dall’abisso, faceva ancora un sorso dal rosso (fuoco!) - quel liquore incandescente come Fiamma del Vulcano, respirando dove l’abisso discende - girava la testa - nel lucore rigonfio dell’immagine di Lei ingigantita, dalle lenti bifocali che il liquore, quel Liquore, quel Vulcano deformava, rivoli scolavano tra spalle e angoli-di-labbra, spiriti ribelli al vivo. Spostavano i piedi le vampe etilate. Scioglievano le linee rette, in aperte spirali e steli dritti, mossi di voglia, di voglia gigante, Etna gigante. Rosa. Vino profumato di ferro e animale.
* Quattro, volte, Emmanuelle *
Quanto è fragile … Non lo diresti mai quant’è fragile una rosa, prima che si spezzi.
Impregnato ed ebbro il Principe Rimpiccolito dalla colpa osservava giacere MUTO lo stesso, doppio pensiero della vita sua/immillato dalla rifrazione circostante, rutilante nel silenzio dello schianto: rarefatta l’atmosfera sul B-52.
Si guardavano, lei, indifesa dalla vita, (rosa) mistica circonfusa in spiritoso. Di fronte lontani e tesi separati da un Piano nello sguardo giunti caricati di tensione.
Lui confuso vedeva spine al vento, pensava: il vento mi piace, e si sentiva stringere, e stingere, etilosolubile irrisolto. Lei alzava spine al vento, nel nuovo inganno d’essere bella, sono… bella… , diceva.
Tanti aggettivi nessun verbo, ché nella stasi l’azione preclude, perché rimasero immobili chi per la morte (brandiva cesoie) chi per lo stupore, non riuscendo ad uscire da alcun fotogramma. Galleggiavano, trappola a topi, canzone a manovella, pensiero stupendo, Chiara nel chiostro, ostrica, corazza scrostata.
Come volgere la parte scheggiata di un vaso, d’Estate, contro l’angolo del muro; Tremavano tirati dai cavalli del brunello che invadeva atrii, humus pori e simpatia ventricolare: BRRR, pensavano, scritto proprio così.
Scivolava nel frutto maturo e sentori la rosa. Faceva freddino. Brrr tutto d’un colpo s’accorse che, stando così messe le cose, non avrebbe più dovuto temere la pecora.
Il vento quello vero disegnato su una pietra, su un pianeta tempo fa, lo lasciò a terra il principino con gli zigomi che sapevano al lampone. Una volta lui voleva tatuarsi, una cometa che era un carcere, il Suo nome la Traccia di Lei - Sentiva vibrare i fili tesi tra le loro pupille, lentamente si chinava.
Mi sei mancata sbraitando in silenzio aveva voltato le spalle
* + *
borraccia e chitarra
e si dice beva ancora, in Alabama.
II classificato - “Cammina, cammina”
di Cristina Trinci
Cammina, cammina. Schegge di passi. Piedi impigliati nelle zolle. Tu davanti, e lui poco più indietro. C’è pace tutt’intorno. Solo armoniosi canti e note di scricchiolii. Natura, natura, ma anche uomo. Geometrie di filari e colori di colture autunnali, in riposo, in attesa: mano dell’uomo.
Tu, davanti: hai il volto invecchiato dal lavoro nei campi e stringi le palpebre per vedere lontano. Dietro a te, nostro figlio, appena adolescente, svogliato guarda i propri piedi mentre a fatica prosegue il cammino. Ai vostri lati, colonne di viti spossate dalla vendemmia.
D’improvviso, ti volti e parte la tua mano nodosa che colpisce secca e decisa la faccia di Giacomo. Meravigliato e quasi piangente, lui alza lo sguardo e, con il mento tremante per l’improvvisa violenza chiede: “Babbo! Perché?”. Tu impassibile rispondi: “Intorno. Le cose belle ti stanno intorno. Se ti guardi solo per te non impari niente”.
Perso nell’incomprensione, nostro figlio tace. Grappoli d’uva tardivi, o scampati al raccolto, colgono il suo sguardo furente per il torto ingiustamente subito dalla sua guancia. Ruggine, arancio bruno, e ogni tanto giallo profondo, le foglie di vite adornano il vostro incerto incedere.
Il sole, alle vostre spalle, comincia a ritirarsi, nell’inesorabile ritmo di luce e di buio.
Io, invece, lo ricevo ancora pieno sulle labbra, questo sole appena tiepido. Un po’ osservo e un po’ immagino, da quassù, quello che succede nella vostra camminata tra le nostre vigne. Affacciata alla finestra di buon legno antico mi abbraccio da sola, sperando che la luce finale del giorno mi lavi via i ricordi di questo giorno.
Indecenza, incoscienza, innominabile giornata. Gli occhi socchiusi, sorretti ai lati da inevitabili rughe, penso. Maledetta storia, distruzione e splendore. Ancora non credo di poter averlo fatto di nuovo. Sono passati trent’anni e quel profilo scolpito nel tempo non ha perso nessun contorno. Profilo di uomo, tra i tanti il solo. Profilo di voce, nell’aria immobile. Profilo di dita, veloci su corde. Senso, mi chiedo il senso … A vent’anni basta dire che si è stupidi davvero, cantare Guccini in un prato, le gambe incrociate all’erba, sentirne l’umidità, ingozzarsi di pessimo Lambrusco e alla fine traboccare di liquida tenerezza con la testa sulla spalla dell’uomo unico che si pensa, si vuole, si crede, si sceglie, si insiste, sia l’unico. E in pochi elastici anni, si costruisce un’inespugnabile verità che resterà lì, immobile, mentre noi si continuerà a camminare in avanti, in discesa, nella curva del tempo. Tempo, poco, sceltissimo tempo che ci ha voluti insieme, sempre tra straniere parole di volta in volta diverse, ora francesi, ora tedesche, ora arabe o greche, oppure tra note complesse e ritmate di lingua universale. Quanto poco basta e quanto è sempre troppo questo filo di sottile acciaio che non si ossida, non si corrompe e non si allenta. Si consuma, ma mai fino in fondo. Ancora sul filo danza la confusione di serate d’oro, chitarre e canti da poco, ma uniti in un unico vortice d’allegra compagnia, stretti braccio a braccio nel poco spazio di una poltrona in una piccola casa piena di tutto, di vecchio, di sporco, ma anche di libertà e nessuna spiegazione, vivi in un’unica nuvola di saggezza, ubriachi di vini senza nome, rossi, fermi, lenti come leoni sazi nello scendere giù nella gola, e feroci come leoni affamati quando raggiungevano il pensiero.
Poi il distacco. Insopportabile e cinico. Bastardo, te ne pentirai, tornerai con le mani imploranti, qui, tra le pieghe di una gonna che ora decidi di ignorare. Tornerai. Tornerai.
Maledetta profezia d’istinto e di rabbia. Maledetta. Con una rosa slabbrata adesso torni alla conquista di questo west che fu tuo, deserto esclusivo, terra possibile madre di futuro e di noi. Rosa. Carne dolce e profumosa. Rossa e spinosa. Regina d’ogni cosa. Conterrai qualcosa?
Non dirmi che sei vuota, che dentro non porti niente, non dirmi che torni per il gusto di tornare, di vedere com’è passato il passato anche per me. Rosa, fottutissima rosa, vattene. Vattene.
Porta chiuditi. Cosa vuoi che m’importi di questo fiore che mi porti. Cosa vuoi che mi freghi dei passati spregi. Niente. Niente, niente, niente eppure si piange e non si sa perché. Non ho paura, no, non ce l’ho. I giorni con te sono vischiosi come miele e rari come stelle cadenti che realizzano desideri, improbabili, nascosti e vivi, borbottanti nella pentola dell’anima. Cucina sazia e saggia. Sana e naturale. Siedi. Hai vinto, siedi. Tavolo di legno con il piano in marmo. Sì, mi fa piacere vederti uguale a sempre. Cosa hai fatto in trent’anni? Vuoi ridere? Che vuol dire? Ce ne vorrebbero altrettanti per raccontare. Dimmi qualcosa tu, mentre i pomodori appassiscono nel tegame e l’acqua bolle.
E lascia quella rosa, dammela. E grazie, eh. Davvero un bel pensiero. Tieni, bevi. Rosso della casa. Offro io. Offro io, come sempre, chi offre sono io, chi si prende tutto sei tu. Sei sempre tu. Bevi. Dimmi che ti piace. Chianti. Chianti divino. E come si fa, si ascolta il cielo. Si guarda in su e si cerca di prevedere il tempo, i pericoli, trovare i rimedi. Si pianta una rosa, una sola, in cima a un filare e si aspetta. Se la rosa si ammala, la vigna è salva. Noi vediamo la rosa e curiamo la vite che si ammala dello stesso identico male. Io mi ammalo e tu ti salvi perché qualcuno sembra che mi usi come antidoto. Più io ingrigisco e più tu mantieni il tuo vigore. Hai bevuto? Bevi ancora e poi ancora. Pensa, ora. Pensa. Questo è Chianti, amore mio, ex amore mio, vecchio amore mio, ma come sei invecchiato bene amore mio. Questo è vino che con le sue dita rosse accarezza di velluto la tua lingua, per poi lasciarla asciugare, a morire dalla voglia di avere ancora quella ingannevole carezza. La gola lascia passare. Lo stomaco accoglie. E tu stai bene. Solo bene. Tanto bene. Cominci a sentire più fatica in ogni gesto, come piccoli piombi appesi alla pelle. E intanto, cosa senti ancora? Lo senti il profumo denso, aroma di terra, di radice? E ora? Non ti sembra forse di sentire, appena accennata, la delicatezza della rosa che per lui si è ammalata? Non è potere salvifico questo? Come può non essere vino d’amore?
Sì, rimani. Cadi tra me e la mia ombra. Cadi nel letto alto, matrimoniale, di un matrimonio bugiardo e silenzioso, ma profondo e con un grande frutto. Anch’io cado. Ti cado addosso, e mi strappo di dosso ogni possibile no. In onore del vino della terra, del potere della rosa e del frutto del seno della vigna, io mi sento di nuovo io, mi ritrovo finalmente nella mia casa, per la prima volta io, sotto le travi di legno che ricordano numerose croci, sacrifici e rinascite. Io provo ancora guardandoti a sentirmi altro da te, ma non ce la faccio, e aggrappo un ultimo sguardo alla testata del letto in ferro battuto, poi mi stacco esausta da noi e siedo strafatta d’istinto e di pulsione vitale sul pavimento in cotto della mia, ora nostra, camera.
Il tempo di riprendere fiato. Il tempo di tradire. Il tempo di pensare che è tutto inutile. Chi se ne frega di sapere se mi vuoi portare via da qui, chi se ne frega, lo so che piango di nuovo, lo so, lo so. Ma tu vattene, che ora tornano dal campo e devo rifare il letto e buttarti fuori dal mio corpo. Vattene. A cinquant’anni io non ti voglio più. Il nostro è un amore giovane e di questi corpi vecchi non sa che farsene. Solo scuoterli un po’. Lo so che mento, ma ora vattene, tu e la tua rosa. Va bene, tengo la rosa perché oggi è il mio compleanno e questo regalo lo tengo da monito. Chiusa. Porta chiusa. Tradito … Ho tradito, con il bicchiere in mano, pieno del vino di mio marito. Spio di nuovo la vostra camminata. Siete ormai arrivati in cima al filare, vicini alla casa, vicini a me, anche se io non so dove sono lontana. Silenzio, cinguettio e sera appena iniziata. Tu arrivi accanto alla rosa, in cima al filare. Dici a nostro figlio che quella si ammala perché si possa salvare la vite.
Vorrei essere vite, mai più rosa.
III classificato - “Il lago colore del vino”
di Enrico Remmert e Luca Ragagnin
Gentile Signor Giacomo,
stia bene attento a quello che ora Le raccontiamo.
Come Lei sa, da un po’ di tempo andiamo in giro a presentare questo nostro trattato su vino e letteratura, il Piccolo Viaggio dal Bicchiere alla Luna.
Orbene, ieri, una freddolosa giornata d’inizio inverno, è stata una delle serate più commoventi tra le tante di questo piccolo tour che, tappa dopo tappa (e tappo dopo tappo), ha dettato la sua scaletta: ritrovo, partenza, arrivo in loco, bevuta di ambientamento, lettura, bevuta di alleggerimento, saluti, bevuta trionfale, meditazione, ritorno.
Allora, ascolti bene.
Noi si era a Ome, Signor Giacomo.
Ome è un piccolo paese con le case sparpagliate e distanziate in una terra verde e collinosa, con le montagne subito lì, appiccicate dietro, e il lago d’Iseo a un tiro di sguardo. Sembra un fotomontaggio lombardo, Signor Giacomo.
Siamo arrivati in anticipo di molte bottiglie e così, dopo una perlustrazione capillare sull’abitato e sugli abitanti (“A Ome siamo venuti a farci un Nome", come ha genialmente coniato il Signor Enrico), siamo risaliti in macchina e ci siamo spostati sul lago.
Alle cinque era già scuro pesto, e i colori delle case illuminate di Iseo facevano il loro bell’effetto.
Immagini, Signor Giacomo, una Liguria di gialli e rossi pastosi, antichi e caldi.
C’erano quattro piazze inanellate una dietro l’altra, con queste case su tre lati e un’apertura verso un freddo, buio brillio: il lago.
In una piazza, al centro del paese, abbiamo visto una statua di Garibaldi il cui piedestallo era una enorme roccia completamente ricoperta di muschio. Un’altra specie di fotomontaggio, anche se un po’ meno lombardo e più tirrenico.
Siamo andati verso l’acqua e lì abbiamo trovato un minuscolo attracco, una semplice rampa di pochi metri che scendeva nella penombra liquida.
Ci siamo avvicinati e, dall’ultima onda, verso di noi si è mossa velocemente una vera e propria tribù di papere e anatre e, subito dopo, più maestosamente e con maggiore lentezza, due cigni molto in carne.
Sono arrivati tutti da noi, e la prima fila non era più distante di un metro. Saranno stati una trentina.
Uccelli abituati all’uomo, crediamo, tant’è che uno dei cigni ci ha praticamente annusato, ma certamente uccelli non avvezzi alla poesia.
Già durante la corsa verso di noi la frotta pennuta aveva incominciato a parlarci, facendo un chiasso buffissimo, così ci è parso naturale rispondere.
”Cari ragazze e ragazzi, - abbiamo detto, - ci manca il pane ma non ci mancano le storie che nutrono,” e abbiamo estratto dalle nostre tasche il Piccolo Viaggio dal Bicchiere alla Luna, sfogliandolo alla ricerca
di una citazione adatta.
Il Signor Enrico ha trovato la pagina e ha incominciato a declamare:
“Amici pennuti, sfamatevi di poesia!”
Subito la platea si è fatta vigile, perciò il Signor Enrico, assunta una posa adeguata, si è rivolto ai pennuti così, centellinando le parole come un oste avaro:
“Abbiamo visto un sogno evaporare come una salma
verso una zona di segreti irrespirabili e fermentati;
e quella zona era la placenta, era l’incominciamento,
il nostro primordiale sogno, la nostra unica speranza
- prima ancora che il caleidoscopio di doveri venisse proiettato,
che il cordone fosse reciso, che l’aroma fosse dissolto -
un piccolo urlo d’aria e in quel momento
noi nascemmo alla sobrietà del mondo…”
Poi, dopo una pausa ad arte, il Signor Enrico ha concluso:
“… ma, per fortuna, bevendo, ce lo siamo dimenticati.”
La torma piumata è esplosa in strilli e starnazzi. Un crescendo di becchi, ali e zampe plaudenti, da stordire un direttore d’orchestra.
A quel trionfo ci siamo inchinati. Eravamo talmente inorgogliti che ci è parso di percepire anche degli applausi umani.
Ci siamo voltati e, dietro di noi, c’erano effettivamente gli applausi.
Alcune persone, infatti, si erano spostate da uno degli elegantissimi bar della piazza e si erano avvicinate per osservare meglio la scena: due signori stranieri che leggevano qualcosa ad alta voce, e con trasporto, a una banda di palmipedi molto attenti. Parole che sembravano avere a che fare con il bere, ma che era difficile mettere a fuoco: evaporare, fermentati, aroma, sobrietà, fortuna.
Perciò, Signor Giacomo, si domanderà com’è finita?
Be’, nel solito modo. Nutrite le anime dei palmipedi era venuta l’ora di bagnare i nostri becchi.
Il Signor Enrico (Remmert) e il Signor Luca (Ragagnin).
Copyright © 2000/2026
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026