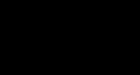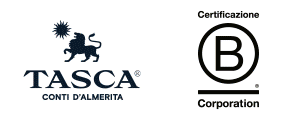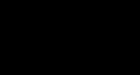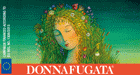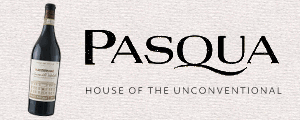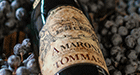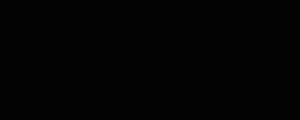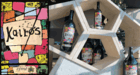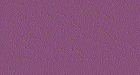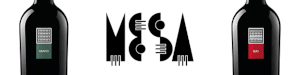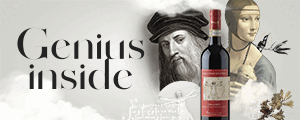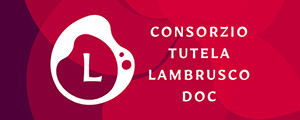Il sistema del vino italiano è basato sulle denominazioni di origine, e ad esse è affidata anche la tutela del prodotto, come se la denominazione stessa fosse un marchio collettivo. E nei fatti lo è anche, ma non a livello legale, tanto che le tutele delle denominazioni valgono, in automatico, solo nell’area Ue. In molti Paesi fondamentali per il commercio del vino del Belpaese, Usa su tutti, il loro valore legale è praticamente nullo, se non vengono riconosciute in accordi bilaterali specifici.
L’esempio più classico è quello del Chianti, che negli States è considerato un termine semigenerico, e con il quale alcuni produttori di California etichetta i loro vini senza troppi problemi legali. Di conseguenza, per una tutela davvero efficace dei vini italiani, la strategia vincente è quella di unire la tutela di regime “pubblicistico” delle denominazioni, a quella di stampo “privatistico” che passa dalla registrazione dei marchi collettivi. È il ragionamento alla base del volume “Il Vino e I Marchi - Teoria e pratica dell’Uso e della difesa dei marchi nel settore enologico e degli spiriti”, presentato oggi a Roma nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, scritto da Maria Cristina Baldini, Mandatario Marchi italiano ed europeo di Partner Studio Torta, storico riferimento italiano in tema di consulenza tecnica e legale in brevetti e marchi e nei vari temi della proprietà industriale, e Pierstefano Berta, direttore di Oicce (Organizzazione Interprofessionale per la Comunicazione delle Conoscenze in Enologia).
Il ragionamento è semplice: un marchio registrato, oltre a presentare diversi vantaggi a livello legale, come appunto la tutela in mercati che non riconoscono le denominazioni di origine, è valida anche nei confronti di altri settori merceologici che, in qualche modo, utilizzando un certo nome, possono danneggiare la denominazione del vino. “Un esempio è quello che è successo in Polonia, dove un’azienda di sanitari aveva prodotto dei bagni chiamandoli “Barolo”, e dove grazie alla registrazione del marchio è stato possibile intervenire, spiega Berta”. O, altro caso celebre in cui il fatto che certi marchi fossero registrati, è stato quello nella lotta contro i famigerati “wine kit”, venduti soprattutto via web, pacchetti di polverine idrosolubili e via dicendo che promettevano di dare per pochi dollari vini come quelli delle grandi denominazioni del vino italiano da fare in casa.
“Certo, registrare un marchio non è semplice, e modalità e costi variano da Paese a Paese - spiega Maria Cristina Baldini - ma è un aspetto fondamentale in un mercato sempre più globale e competitivo. E di questo, devo dire che il mondo del vino italiano non è molto cosciente”. In effetti, al di là di singole aziende che hanno depositato marchi su singoli brand, non sono molti i consorzi del vino italiano ad aver perseguito questa strada. “Eppure sono proprio i consorzi a dover svolgere questo tipo di azione, per il ruolo che hanno, e anche perchè i requisiti per poter ottenere l’uso di un marchio collettivo, spesso, coincidono con quelli per cui un consorzio può e deve utilizzare e tutelare quello della denominazione”.
“È un tema cruciale per la tutela della reputazione del vino italiano, che è stata costruita in primis dai produttori che realizzano grandi vini in tutta Italia e li portano nel mondo - ha commentato l’onorevole Massimo Fiorio - che noi, anche attraverso il Testo Unico abbiamo voluto rinforzare a livello giuridico, ma che richiede un passaggio in più. Soprattutto in un quadro di riferimento che vede la normativa europea in fase di cambiamento, con i nuovi regolamenti in arrivo nel 2019, e gli accordi internazionali come il Ttip con gli Usa che stanno prendendo una strada diversa da quello che auspicavamo per direzioni, modi e tempistiche, e che sul fronte della tutela delle nostre denominazioni del vino e non ci soddisfano. E il fatto che questo libro sia presentato in questa sede non è un caso, dato che questo è uno dei grandi temi che dobbiamo ancora affrontare, e che chiama in causa anche una questione che con il Testo Unico non abbiamo affrontato a pieno, che è quello dei consorzi, del loro sistema di rappresentanza e del loro ruolo. Sul quale - commenta Fiorio a WineNews - deve anche nascere una riflessione profonda, perché forse oggi non è più funzionale continuare a chiamare con lo stesso nome chi rappresenta milioni di bottiglie e chi ne rappresenta poche migliaia”.
Il libro, pubblicato da Oicce Editore, è una sorta di “guida pratica” alla registrazione di un marchio, visto che ne racconta una case history ad hoc. “Abbiamo inventato un marchio per una bollicina metodo classico facendo tutto il percorso necessario”, spiegano Berta e Baldini. Ovvero, si è partiti da una rosa di 50 nomi possibili, per poi scendere ad una decina. Tra questi, si sono guardati quelli già registrati da altre realtà del vino e non solo, e ne sono rimasti due, “Ciabum, che nasce dal suono del tappo che salta, e Benbutà, ispirato al dialetto piemontese che vuol dire ben vestito”. È stato scelto Ciabum perché meno connotato a livello regionale, e poi sono stati fatte delle prove grafiche con dei focus group. “Ed è stata scelta una versione, più floreale, perché secondo un panel di 110 esperti conferiva al prodotto una sensazione di maggior valore e di maggior costo, pur senza averlo assaggiato, e anche questo è un aspetto importante da valutare, quando si crea un nuovo marchio. Un altra, più colorata, era associata a minor valore e minor prezzo, ma anche a una maggiore semplicità e familiarità. Per questo la abbiamo scelta come immagine del libro, perché racconta in maniera semplice e pratica un aspetto che ancora oggi molte realtà del vino italiano non conoscono o sottovalutano”.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025