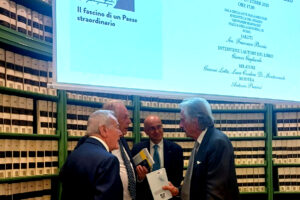Tante, troppe Doc e Docg, in Italia. Che spesso hanno addirittura appiattito la qualità e la distintività di certi vini. Molte che, nei fatti, esistono solo sulla carta. Ma la colpa non è dello spirito della legge 930 del 1963 che le istituì, quanto dei “produttori che hanno preteso di ottenere dalla legge i riconoscimenti che solo il lavoro e il mercato sanno dare”. Ecco il verdetto del “Processo” alle Doc, andato in scena alla Douja d’Or di Asti (www.doujador.it), alla vigilia delle 50 candeline (nel 2013) della prima legge che diede corpo alle denominazioni del vino italiano.
Nel “processo”, introdotto da Andrea Desana, figlio del Sen Paolo Desana, primo firmatario della legge 930/63, l’accusa è stata “interpretata” dal giornalista Elio Archimede quale Pubblico Ministero; la difesa da Vittorio Camilla, lo storico segretario del Comitato Nazionale Vini. Tra i due contendenti, il Giudice super partes: Giancarlo Montaldo, giornalista e direttore, in passato, del Consorzio del Barolo e del Barbaresco di Alba. Che ha “stilato” la sentenza e il resoconto del processo.
“Molti i temi del confronto. La legge 930 è stata nel 1963 la migliore possibile, ma certe situazioni che allora sembravano inoppugnabili, con il tempo si sono rivelate perfettibili. A cominciare - si legge - dalla variabilità delle Denominazioni di Origine. Ci si è chiesti se, invece di creare tre categorie di Denominazioni (Dos, ben presto cancellata, Doc e Docg) non sarebbe stato meglio puntare tutto sulla Doc, quella che di più è entrata nella parlata comune. Ma non solo il numero delle categorie, anche l’eccesso dei vini Doc e Docg, con una sorta di “corsa alla Denominazione” che non ha premiato sempre i prodotti migliori. L’accusa ha calcato la mano, ricordando vari vini che oggi hanno poco seguito e interesse, ma la difesa ha risposto alla pari, sottolineando come la colpa non sia della legge, del legislatore e neppure del Comitato Nazionale. Sono stati i produttori ha pretendere di ottenere dalla legge i riconoscimenti che solo il lavoro e il mercato sanno dare. Ha tenuto banco, poi, il confronto tra vini a Denominazione di Origine e quelli varietali: i primi di ispirazione europea, i secondi con molti consensi nel nuovo mondo. I primi sembrano essere gli esponenti della qualità e della selezione, i secondi della massa.
Ma la recente mossa dell’Unione Europea di aprire le porte anche ai vini di vitigno con un intervento specifico della nuova Ocm Vino lascia qualche dubbio di troppo. Senza dimenticare l’aspetto “appiattimento” che l’impostazione della Denominazione di origine ha portato con sé, soprattutto nel caso di vini come Barolo, Brunello, Barbera d’Asti, Barbaresco, Aglianico del Vulture, Valpolicella, ecc. Mettere sullo stesso piano qualitativo tutte le colline, tutti i vigneti all’interno della zona di origine di una Denominazione alla fine si è rivelato un errore. E così si è dovuto parlare di Crus, Sottozone, Vigne, Menzioni e a lavorare in questo senso. E molti di questi “riferimenti specifici” sono poi stati recepiti nelle nuove formulazioni della legge, sia la 164 che la 61. E qui c’è stato un altro elemento di confronto. La Francia ha usato termini di facile comprensione come Climat e di Cru. Perché l’Italia ha voluto optare per parole discutibili come “Sottozone” o incomprensibili come “Menzioni Geografiche Aggiuntive”. Non siamo noi italiani i maestri della fantasia?”.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025