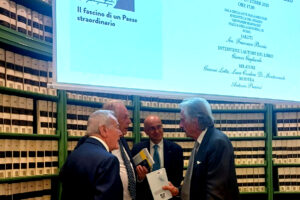Un mondo solo in apparenza piccolo e con radici antiche, che affondano “nei vulcani” e nei loro territori, che in italia vanno dal Veneto alla Sicilia, passando dalla Campania e non solo, e che merita di essere studiato e raccontato meglio e di più, perchè genera vini dalle caratteristiche uniche. Ma non solo. Ecco il messaggio di “Vulcania Napoli”, il think-tank che mette insieme zone di produzione significative come le venete Soave, Lessini Durello e Gambellara, la siciliana Etna, le campane Campi Flegrei e Vesuvio e la toscana Pitigliano, che è sbarcato in Campania, spostando il suo focus dalle zone dove un tempo (assai lontano, migliaia o centinaia di migliaia, se non milioni di anni) esistevano dei vulcani a dove esistono ancora e continuano ad essere in attività, e dove, anche nel vino, il fattore “V” la fa da padrone. La loro assoluta particolarità? La differenza offerta dai suoli vulcanici risiede, evidentemente, nella maggiore ricchezza di microelementi che garantisce ai vini prodotti in questi particolari terroir un plus qualitativo tendenzialmente importante e una originalità solida e chiara. In altre parole l’“antidoto” alla concorrenza basata sui meccanismi merceologici più banali, che vede gli oggetti, qualora non originali inimitabili, riproducibili dovunque. Si tratta, insomma, dell’“uovo di colombo”: condizioni climatiche e pedologiche uniche non possono essere riprodotte in altri luoghi e i prodotti che originano non possono essere imitati. Un valore aggiunto decisivo che solo il vino (e solo particolari prodotti come quelli “vulcanici”) possiede.
Ma non solo. “Vulcania”, siamo all’edizione n. 5, è anche una “iniziativa unica al mondo nel suo genere - spiega il professor Attilio Scienza, uno dei massimi esperti di viticoltura e fin dalla prima edizione di questo evento convinto sostenitore del progetto - perché riunisce vari territori, distanti e diversi, attraverso il filo conduttore del vulcano, attivo milioni di anni fa o ancora attivo. Con tutte le implicazioni pedologiche, climatiche e, soprattutto, culturali - prosegue Scienza - trasformandosi al contempo in un modo per promuovere piccole denominazioni che da sole non potrebbero emergere”.
Un vero e proprio “sottosuolo”, dunque, che unisce terroir culturalmente diversi, per pratiche agronomiche e di trasformazione (che di solito restano però tendenzialmente legate alla tradizione), capace di ricomporsi empiricamente nel bicchiere. Perché se il vino è un portatore di emozioni, questo per diventare prodotto deve essere capace anche di rivelarsi immediatamente atrraverso una sensazione, un ricordo o una immagine. E il vulcano, in questo senso, funge proprio da quel riferimento immediato che servee ad un vino per rivelarsi immediatamente.
Ma la trasferta in terra campana, sostenuta dalla Camera di Commercio di Napoli, è stata anche l’occasione per mettere “i piedi sul piatto”, come si dice, su problemi che alla fine riguardano l’intero assetto del comparto vitinicolo italiano. “La qualità di un prodotto come il vino deve partire prima di ogni cosa - afferma il professor Fabio Terribile, cattedra di pedologia della Facoltà di Agraria di Portici delll’Università di Napoli, e autore dei progetti di ricerca del Consorzio del Soave e della cartografia dei suoli dell’Etna - dalle potenzialità del territorio/terreno, e il mondo enoico è al centro della sempre più importante lotta per la salvaguardia del suolo, come indica anche la Soil Thematic Strategy della Ue. Una lotta che, per di più, produce reddito”.
Ma, purtroppo, le condizioni della ricerca in Italia, come troppo spesso viene ricordato, non permettono di lavorare serenamente per raggiungere tali obbiettivi e il professor Terribile lancia anche un appello significativo: “i suoli piroclastici campani sono un mosaico pedologico e climatico in parte ancora da scoprire. Purtroppo, però, manca un serio studio, come da altre parti è stato realizzato, per sistematizzare queste conoscenze e offrire al settore viticolo uno strumento di grande utilità”.
Parlare di vino a due passi dall’antro della Sibilla Cumana e dell’isola di Circe ha evidentemente stimolato suggestioni affascinanti. “I vulcani sono i luoghi del vino dove il mito persiste ancora oggi - ha sottolineato Scienza - sono dei veri e propri “monumentum”, cioè dei “totem” ancestrali che restano nella memoria di tutti. In questo senso, il consumatore è indotto ad associare immediatamente al vino - conclude il professore dell’Università di Milano - quell’immagine, che è collegata ad una sensazione immediata”.
Vesuvio e Campi flegrei sono anche un universo in parte dimenticato e che solo nel recente passato sembra riacquistare la propria centralità. “All’inizio del ‘900 - ha spiegato Antonella Monaco del Centro Museale delle Scienze Agrarie di Portici - i vigneti della zona flegrea erano praticamente l’unica coltura esistente. Dal 1950 in poi questo patrimonio si è perso quasi del tutto a favore della frutticoltura. Attualmente si sta tornando un po’ indietro, ma il danno è stato fatto. Non solo - prosegue Monaco - la ricchezza ampelografica della zona, che piano piano si sta ricostruendo attraverso un lavoro di recupero di vecchie viti, era straordinario come testimonia la collezione della Regione Campania. Una fonte di biodiversità incredibile che messa insieme all’altrettanto vasta ricchezza di forme di allevamento testimonia una cultura del vino unica nel panorama italiano".
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025