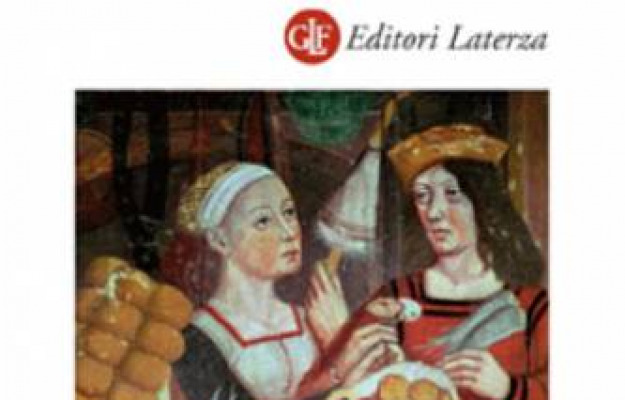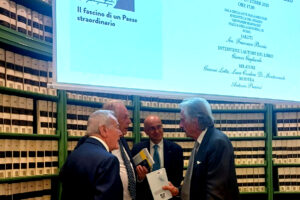Da molti secoli fa alla storia più recente, è la tavola che ci unisce e ci dà identità: dalla pasta al pane a moltissimi altri piatti che ancora oggi sono il simbolo della nostra identità alimentare, lo racconta il professor Massimo Montanari, tra i massimi storici al mondo di cultura enogastronomica, nel volume “Gusti del Medioevo”, di scena il 24 novembre al Caffè Quadri di Venezia con il Master in “Cultura del cibo e del vino” dell’Università Cà Foscari di Venezia diretto dal professor Roberto Stevanato (info: www.unive.it/challengeschool). E poi c’è il vino, fattore identitario che accomuna la maggioranza dei Paesi del Vecchio Continente, considerato a tutti gli effetti valore concorrente all’unificazione dell’Europa: se ne parla al Convegno internazionale “55 anni di Unione Europea (1957-2012): la cultura del vino come elemento identitario ed unificante dell’Europa”, il 30 novembre alla Sala convegni Cra-Vit di Susegana (Treviso), promosso dal Cra-Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura del Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano diretto dal professor Luigi Bavaresco, in collaborazione con l’Accademia Italiana della Vite e del Vino, che ha chiamato a raccolta importanti personalità della politica europea, dell’università e della ricerca internazionali e del mondo del vino (info: www.entecra.it).
Siamo seduti a tavola e il cibo viene servito in una successione uguale per tutti: oggi accade normalmente e ci pare ovvio: ma è stato sempre così? Non nel Medioevo. La tavola medievale segue un altro modello, simile a quello che troviamo ancora praticato in Cina e in Giappone: i cibi sono serviti simultaneamente e spetta a ciascun convitato sceglierli e ordinarli secondo il proprio gusto. Ancora: la cucina contemporanea tende a rispettare i sapori naturali e a riservare a ciascuno di essi uno spazio distinto, nei singoli piatti come nell'ordine del menu. Ma queste regole non sono un archetipo universale. La cucina medievale preferiva mescolare i sapori ed esaltava l'idea dell'artificio, che modifica la natura. Sia la preparazione delle singole vivande, sia la loro dislocazione all'interno del pasto rispondevano a una logica sintetica: tenere insieme più che separare. Ma se le differenze di gusto fra noi e il Medioevo sono importanti, altrettanto forti sono le continuità, e alcune preparazioni costituiscono tuttora un segno forte dell'identità alimentare: la pasta, la polenta, il pane, le torte, una molteplicità di piatti a base di carne, pesce, formaggio, verdure che hanno garantito nei secoli la sopravvivenza e il piacere degli individui. Il viaggio con il professor Massimo Montanari tra le pagine di “Gusti del Medioevo”, nell’evento promosso con il Centro di Cultura “La Vigna” e il Caffè Quadri dei Fratelli Alajmo, farà conoscere un territorio doppiamente affascinante, perché vicino e, al tempo stesso, lontano.
Ma anche la coltivazione della vite e la produzione ed il consumo di vino, fenomeno culturale e diffuso stile di vita, sono tra quei singolari elementi di convergenza, che, accanto a matrici comuni come la contiguità territoriale, l’idea democratica, i fondamenti giuridici, la sensibilità religiosa cristiana, il percorso storico fortemente intrecciato tra i vari Stati nazionali, costituiscono quel basamento su cui, dal Trattato di Roma (1957), ebbe origine il lungo processo di integrazione dell’Europa. Mission del Convegno promosso dal Cra - con il patrocinio della Commissione e del Parlamento Europei, Unisco, Ministeri delle Politiche Agricole e per i Beni e le Attività Culturali e dell’Oiv-Organisation Internazionale de la Vigne e du Vin - e con il presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo Paolo De Castro in veste di “chairman”, è quello di contribuire al rafforzamento della dignità culturale del binomio vite-vino in chiave di strumento di convergenza identitaria, a partire da “La vite e il vino nella storia dell’Europa occidentale” raccontata dal presidente dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino Antonio Calò. A seguire, in una tavola rotonda presieduta dal professor Mario Fregoni, presidente International Academy of Sensory Analysis si parlerà di “Le sfide culturali del settore viti-vinicolo europeo” con il diretto Oiv Federico Castellucci, Herbert Dorfmann, membro del Parlamento Europeo, Vicente Sotes dell’Universidad Politecnica de Madrid, Christian Asselin, rettore dell’Union des Oenologues de France, Hans Reiner Schultz, direttore Fg-Geisenheim in Germania, ed Erno Peter Botos della Corvinus University di Budapest, insieme al professor Luigi Bavaresco e Gianni Zonin, tra i produttori più importanti del vino italiano. E se Barry Smith, direttore dell’Istituto di Filosofia della University of London’s School of Advanced Study parlerà di “Il valore filosofico-culturale del vino in Europa”, ad intervenire saranno anche Giuseppe Blasi, direttore generale della Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale del Ministero delle Politiche Agricole, il professor Vasco Boatto del Cirve dell’Università di Padova, Antonella Bosso del Cra-Eno di Asti, Carlo Flamini del “Corriere Vinicolo”, Franco Manzato, assessore all’Agricoltura della Regione Veneto, Giuseppe Martelli, direttore generale di Assoenologi e Comitato Nazionale Vini, Eugenio Sartori, alla guida dei Vivai Cooperativi Rauscedo, e Damiana Tervilli, preside Isiss “Cerletti” di Conegliano.
Ma le molteplici denominazioni, la ricchezza varietale, le raffinate tecniche di coltivazione delle viti e dei produzioni dei vini contribuiscono non solo connotare il tessuto comunitario di una molteplicità di interessi, di stimoli economici, di occasione di occupazione e di crescita economico-sociale, ma concorrono anche ad identificare i singoli territori per la loro peculiarità e, in tal modo, a fornire gli stimoli per una complessiva maturazione, nelle diversità, di una omogenea sensibilità culturale e ambientale di cui l’Europa ha sempre più bisogno.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025