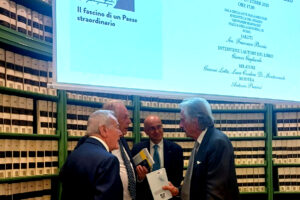L’Unione Europea ha 55 anni, ed è ancora in cerca di una sua identità condivisa. Un percorso che, forse, può essere più facile se passa dal vino e la vigna. Perché sono due elementi che, fin dall’antica Grecia, passando per i Romani che la diffusero in tutto il continente, e per le abbazie e i nobili che la salvarono dalle invasioni di barbari e musulmani, legano con un filo rosso, raccontato dal professor Antonio Calò (Accademia Italiana della Vite e del Vino), tutti i Paesi europei. Siano grandi produttori come Italia, Francia o Spagna, o consumatori. Che se anche oggi sono divisi su alcuni aspetti, come la liberalizzazione o meno dei diritti di impianto, su un concetto sono tutti uniti: il legame tra vino e territorio. Dall’Italia, con le sue 443 varietà di vitigni iscritte al registro per la produzione, in gran parte autoctone o di antica coltivazione, alla Spagna, che dai “propri” vitigni ottiene il 93% della sua produzione, fino alla Germania, dove la viticoltura è arrivata grazie ai Romani nel bacino del Reno, e da li si è propagata, all’Ungheria, dove la storia del vino nasce da un coacervo di popoli (turchi, francesi, polacchi e via dicendo), ed è molto legata alle antiche varietà dei suoi territori, Tokaji in primis, ma non solo. Emerge dal convegno “55 anni di Unione Europea: la Cultura del Vino come elemento identitario ed unificante dell’Europa”, promosso dal Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano.
Con il vino che unisce l’Europa, nel bene e nel male: dal calo dei consumi che colpisce i produttori storici, Francia, Italia e Germania, che si difendono (e bene) con l’export, ma che devono “stare attenti, insieme, a non diventare semplici fornitori di materia prima - spiega Federico Castellucci, direttore Oiv - visto che sta crescendo l’export di prodotto sfuso verso poli logistici come Olanda o Regno Unito, che poi imbottigliano ed esportano a loro volta, trattenendo dunque valore aggiunto”.
Ma tutti, da Luigi Bavaresco, direttore del Cra, a Vicente Sotes (Universidad Politecnica di Madrid), da Hans Reiner Shultz, direttore della scuola agraria di Geisenheim in Germania, a Christian Asselin, Rettore dell’Union des Oenologues de France, fino ad Erno Peter Botos, della Corvinus Univesitydi Budapest, fino al produttore Gianni Zonin, concordano: il legame tra vitigni, territori e uomini è forte come in nessun altro luogo nel mondo, ed è la forza del vino europeo.
Vino che è anche “tra i migliori simboli per tornare a sostenere l’Europa - ha detto in un messaggio il Ministro dei Beni Culturali Lorenzo Ornaghi - perché è nutrimento della terra e convivialità, è festa di tutti, e mette in evidenza le radici radici geoculturali comuni dell’Europa, e simbolo degli stili di vita di tanti popoli”.
Un simbolo che ha attraversato le epoche, nel nome del legame con la sua zona di origine. “Già Omero nell’Odissea parlava di “vino di Ismaros” e non di un vino generico, nell’episodio di Polifemo - ha ricordato il professor Calò - e ancora ai campioni di Olimpia veniva dato in premio il vino “di Crotone”. Ma anche negli “ostraka” delle anfore egizie ritrovate nella tomba di Ramses II, nell’antico Egitto, c’era la provenienza del vino, e addirittura il poeta Archestrato testimonia il primo duello “territoriale”, quando scrive “lodo il vino di Biblo della sacra Fenicia, ma certamente non lo paragono a quello di Lesbo””.
Tracce che raccontano di un uso antico che, nel tempo, si è “trasformato” nelle moderne denominazioni. Con il vino che ha conquistato un’attenzione e un importanza, anche a livello normativo, che non ha eguali.
“Festeggiamo i 55 anni di Europa, ma anche i 50 di Politica Agricola Comunitaria - ha ricordato l’europarlamentare Herbert Dorfmann - e da quando c’è il vino è sempre stato uno degli argomenti più importanti, e lo è tuttora, tanto che è rimasto uno dei pochissimi prodotti agricoli che ha avuto un Ocm a se stante. E ha tracciato la strada per le denominazioni di origine e le indicazione geografiche di tutti gli altri prodotti”.
Un ruolo che ha potuto avere perché la sua importanza è stata riconosciuta singolarmente dai Paesi più importanti che lo producono, nell’Unione Europea, ancora prima di farne parte. È il caso dell’Italia, ovviamente, ma anche della Spagna, come ha spiegato il professor Vicente Sotes, dell’Universidad Politecnica de Madrid: “la coltivazione della vite è molto antica, molto legata alla tradizione e a vitigni antichi, con i viticoltori che prima sono riusciti a salvarli da 800 anni di dominio musulmano, e poi sono stati capaci anche di esportare la propria conoscenza in Sudamerica e in California. E oggi la Spagna ha una delle maggiori superfici mondiali a vigneto, nonostante sia difficile coltivare la vite perché è un Paese dove piove poco, e dove le conformazioni dei terreni delle zone più importanti per il vino consentono poca meccanizzazione, e poca redditività, calcolando anche che il nostro vino viene esportato a meno di un euro al litro. Ma il vino ha un grande valore sociale, anche perché garantisce tanti posti di lavoro, ed è molto identitario, al punto che il 93% della produzione arriva da vitigni autoctoni. Certo, anche noi - aggiunge Sotes - soffriamo il calo dei consumi interni, tanto che per riconquistare i giovani è partita una campagna culturale (“Quien Sabe Beber, Sabe Vivir”), anche perché il consumo è a livelli tragici, 18 litri procapite. Ma si punta molto sulla formazione, sulla cultura del vino e sull’enoturismo”.
Radici antiche, magari meno conosciute, il vino ce le ha anche in Germania, dove la viticoltura “è arrivata al tempo di Cesare - spiega Hans Reiner Shultz, direttore della scuola agraria di Geisenheim, tra le più importanti del Paese e d’Europa - nella Mosella, e poi da li si è estesa in tutto il bacino del Reno. È una viticoltura in forte pendenza, forse con la maggiore pendenza al mondo, ma ci si è creduto molto, si è subito radicata nel territorio, e i tedeschi hanno lavorato molto per ristrutturare il vigneto e renderlo meccanizzato. Oggi se ne vedono i frutti: in Baviera per esempio, paradossalmente cala il consumo di birra e aumenta quello di vino, si punta sull’enoturismo, si pensa anche a produrre vini più accessibili, anche nei gusti, per i giovani. Ma serve più formazione a diversi livelli: io ho 730 studenti, di cui 58% fa una parte del suo percorso all’estero, e spesso in Italia a Conegliano o a San Michele all’Adige. Perché condividere esperienze con altri Paesi è fondamentale, ed è nella natura stessa del vino”.
Vino che a volte è anche catalizzatore ed elemento pacificatore tra popoli e culture: è il caso dell’Ungheria, “dove intorno al Tokaji e altri - ha detto il professor Erno Peter Botos, della Corvinus University di Budapest - hanno lavorato ungheresi, polacchi, francesi, turchi, ebrei e anche italiani che sono venuti nell’antichità a coltivare la vigna. E sebbene il vino ungherese sia molto legato alle varietà autoctone, è stato un fattore di integrazione internazionale molto importante”.
Ma se queste sono le radici “comuni” del passato del vino, in Europa, ora il futuro passa anche da una visione comune e da un’alleanza tra Paesi produttori sul mercato.
“Quest’anno è successo un fatto straordinario - ha detto Gianni Zonin, alla guida di uno dei più importanti gruppi del vino italiano - abbiamo raggiunto l’equilibrio tra produzione e consumo. Anzi sembra che per soddisfare tutta la domanda manchino 15 milioni di ettolitri. E questo sia per la vendemmi scarsa, ma anche perché, con un cambio di rotta dell’ultima Ocm, si è smesso di produrre vino in eccesso al solo fine di distillarlo e prendere i contributi, che non ci sono più. E che sono stati dati per estirpare vigneti e promuovere l’export. Nel 1983 vennero distillati in Italia 32 milioni di ettolitri (quest’anno ne saranno prodotti meno di 40 milioni, ndr). Ora dobbiamo fare i conti con questo nuovo scenario. Ad Amsterdam c’è stato il salone del vino sfuso, e tanti imbottigliatori hanno già prenotato tutto il vino del Sudafrica che verrà prodotto nella prossima primavera per avere scorte. Questo ci dice due cose: una è che l’Italia e gli altri Paesi europei non possono perdere il treno dell’export, sia perché ormai il vino prodotto e consumato all’estero è più di quello bevuto nei propri confini. E l’altra è che Italia, Spagna, Francia e altri Paesi europei, che hanno molte regole e molti tratti culturali in comune, devono smettere di vedersi come competitor tra loro. Perché il mondo si è fatto più piccolo, i Paesi ormai sono come Regioni, e la competizione non è tra loro, ma con altri Paesi del Sudamerica, con gli Stati Uniti, con l’Australi, e presto anche con la Cina”. Una partita che l’Europa del vino può vincere solo se si unisce, ancora di più, nel segno di Bacco.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025