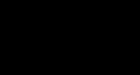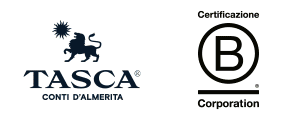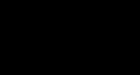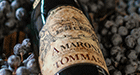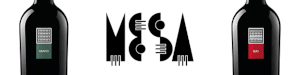Un viaggio dagli anni 60 ad oggi, per ricordarsi da dove è partito il vino italiano quando, in uno dei suoi territori più prestigiosi, le Langhe, in tanti imbottigliavano e in pochi producevano, e dove è arrivato oggi, riconosciuto come sinonimo di qualità nel mondo: ecco il senso della “Lectio Magistralis” di Bruno Giacosa, maestro del Barolo (e non solo), “il più grande di tutti”, come la ha definito Angelo Gaja, che ieri, a 83 anni, ha ricevuto la laurea honoris causa n. 1 dell’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo. Laurea che celebra il lavoro di un uomo e di una famiglia e, più in generale, la tradizione di un territorio di cui l’Università è parte e in cui è radicata”, ha detto il rettore Piercarlo Grimaldi. Un percorso ricco di storia, che parte da un uomo strettamente legato al territorio, nato da una famiglia di ristoratori, come ha ricordato il già rettore Alberto Capatti, “presente a Neive da sempre, tanto che avevano preparato il pranzo per Cavour quando era venuto a inaugurare la ferrovia”, diventato “simbolo della diversità e ricchezza - ha aggiunto il fondatore e presidente Internazionale di Slow Food Carlo Petrini - del nostro territorio”. Giacosa ricorda le sue origini, ringrazia figure come Luigi Veronelli, ma anche come Robert Parker e James Suckling per la notorietà che hanno contribuito a dare alle Langhe attraverso i suoi vini e non solo, sprona i giovani a credere nel lavoro in campagna e in vigna, ai quali però dice: “viaggiate, andate per il mondo, assaggiate vini fatti da altre parti e quelli dei vostri vicini, perché non è più il periodo adatto per occuparsi di cantina e vigna e basta. Imparate a confrontarvi con produttori e mercati di altri Paesi, perché sarà utile a formare anche una cultura più aperta e non più chiusa nel nostro provincialismo”. Non rinnega il suo essere tradizionale, ma non ha paura di ammettere che via via, nel tempo, le innovazioni nel metodo produttivo hanno fatto parte della sua carriera, ma non stravolto i suoi prodotti. Esorta i giovani produttori a conservare le vecchie bottiglie per costruire una memoria storica della cantina, riconosce l’importanza del confronto costruttivi con i colleghi, in primis Bartolo Mascarello e Aldo Conterno, su come migliorare il prodotto. E, in conclusione, spiega in poche parole cosa vuol dire quel “fare sistema” che tutti invocano: “la cosa che mi fa più piacere è vedere che le Langhe sono diventate sempre più un luogo in cui si produce qualità, che il nome di queste terre è stato inserito nella ristretta cerchia delle aree più vocate del pianeta, che questi vini hanno finalmente il successo che io, fin da giovane, speravo che avrebbero potuto meritarsi”. La lezione del Dottor Bruno Giacosa.
La lectio magistralis di Bruno Giacosa
Come sanno quelli che mi conoscono, a me non è mai piaciuto molto parlare in pubblico, e in un’occasione come questa sarei anche troppo emozionato, per cui ho pregato l’amico Vittorio Manganelli di leggere questi miei pensieri in una giornata così importante per me, per la mia famiglia e per tutti i produttori di vino delle Langhe.
Io sono nato nel 1929 e i primi profumi che ho sentito sono stati quelli del latte di mia mamma e del vino di mio nonno, che veniva da una famiglia di ristoratori presente a Neive da sempre, tanto che avevano preparato il pranzo per Cavour quando era venuto a inaugurare la ferrovia.
Proprio il 1929 è stato anche l’anno in cui nonno Carlo è morto e in cui mio padre Mario ha preso in mano l’attività. Il nonno Carlo aveva iniziato a vinificare e imbottigliare già alla fine dell’Ottocento, ottenendo medaglie d’oro nei concorsi internazionali del tempo: come venne poi stampato per anni sulle etichette, i premi più importanti furono le medaglie d’oro di Genova nel 1901, di Torino nel 1902, di Reims nel 1903 e di Bruxelles nel 1910.
I vini prodotti erano quelli classici piemontesi, quelli che conosciamo ancora oggi: soprattutto Dolcetto, poi Barolo, Barbaresco, Nebbiolo, Barbera, Freisa e Brachetto. L’unico bianco era l’Asti Spumante.
Ovviamente il 1929 è stato anche l’anno della grande crisi, per cui mio padre decise di smettere di vendere il vino in bottiglia e di limitarsi a comprare uve, che successivamente o rivendeva direttamente oppure vinificava per poi cedere il vino sfuso.
In quei tempi, infatti, le pochissime cantine che imbottigliavano con una propria etichetta per lo più non avevano vigneti di proprietà e acquistavano le uve dai cosiddetti mediatori, ossia intermediari tra i vignaioli e le aziende che vinificavano. Erano gli anni di cantine quali Calissano, Bonardi, Gancia, Contratto, Pio Cesare, Prunotto, Serafino, solo per ricordare le più famose, e alcune di queste sono attive ancora oggi. Per completare il quadro di allora, occorre di sicuro ricordare l’importanza di quei pochi nomi che invece producevano vini ricavati da vigne di proprietà, come l’Opera Pia Barolo e Fontanafredda, ma quelli furono anche gli anni della loro crisi, quando dovettero vendere terre e cantine a nuovi proprietari. C’era già qualche piccola azienda agricola che vinificava, e sono nomi di prestigio come quelli dei Conterno, degli Oddero o dei Rinaldi, ma a livello di quantità di bottiglie erano poca cosa, il grosso del mercato era in mano agli imbottigliatori. Io mi sono quindi trovato, avevo 16 anni ed era appena finita la Seconda Guerra Mondiale, a entrare in cantina a fianco di mio papà e ho iniziato a girare con lui per le Langhe, a vedere come si faceva a comprare e a rivendere le uve, come si faceva a sceglierle e a distinguere quelle più buone da quelle poco interessanti, a ricordarsi quali erano le vigne che davano i migliori risultati.
C’era anche il mercato delle uve in Alba, di cui io, come i tanti contadini che portavano lì le uve, non ho un bel ricordo, perché i mediatori aspettavano sempre all’ultimo momento prima di comprare, per costringere i vignaioli a vendere a qualsiasi prezzo pur di non riportarsi indietro il carro pieno. Era una cosa un po’ triste, soprattutto quando non c’era una grande richiesta di uve da parte degli imbottigliatori. Noi, invece, preferivamo andare direttamente nelle cascine, anche perché così potevamo scegliere le uve che ci piacevano direttamente sul posto. Dopo aver comprato le uve, davo anche una mano in cantina, dove si produceva comunque un po’ di vino che poi veniva venduto sfuso a quelle stesse cantine che compravano anche delle uve. Facendo il vino si guadagnava qualcosa di più, ma bisognava che fosse buono davvero, perché altrimenti c’era il rischio di non venderlo.
Qui devo dire di me una cosa che poi mi ha accompagnato per tutta la vita, e che faccio ancora oggi: io allora ero un ragazzo, e quindi non bevevo vino, però ho avuto subito un buon naso, nel senso che ho capito che facendo attenzione agli aromi che escono già dal mosto in fermentazione e poi dal vino si possono capire quasi tutte le cose che servono.
Ho imparato, cioé, a usare il mio naso come mezzo per giudicare se un vino era pulito o sporco, se era in grado in invecchiare bene, se aveva abbastanza sfumature o se non si sarebbe mai aperto bene, se poteva meritare una sua etichetta apposita o se era preferibile mescolarlo con altre partite, se facevo meglio a tenermelo per qualche anno in cantina prima di imbottigliarlo o se era meglio che lo vendessi subito a qualcun altro. Ovviamente ho anche messo in bocca centinaia di vini, ma posso garantire che il mio naso si è sbagliato raramente. E questa è una cosa che continuo a ripetere anche ai giovani: imparate a usare l’olfatto, che oggi molti pensano che non serva più a niente: è con il naso che si capiscono le cose più importanti in un vino.
E aggiungo un’altra cosa proprio mia personale, e spero che faccia capire qual è stato il mio approccio al vino: io non ho mai bevuto fuori pasto, anche perché credo che il vino non faccia bene a digiuno, con lo stomaco vuoto, come fa invece tanta gente e non solo in Italia. E, mangiando, a me piacciono i vini semplici, ma appaganti, ricchi di frutto, diretti, che non diventino più importanti del cibo.
Per cui a me è sempre piaciuto il Dolcetto, che va benissimo con quasi tutti i piatti della cucina piemontese.
Quando ho proprio voglia di un bicchiere importante, che mi pare stia bene con una certa ricetta, allora mi apro un Barolo o un Barbaresco, ma un po’ vecchi, in modo che abbiano già tutti i loro profumi ben aperti e chiari, e la cosa a cui sto più attento sono sempre e ancora i profumi. Intendiamoci, quando dico vecchi intendo da dieci anni in su, non è obbligatorio che ne abbiano trenta o quaranta.
Anche se devo dire, e lo faccio anche con un po’ di piacere, che molto spesso i miei vini si sono dimostrati capaci di maturare in bottiglia proprio per trenta o quarant’anni, senza avere nessuna nota di vecchio o di marsalato. E credo che questa sia una delle ragioni che mi hanno fatto conoscere in giro per il mondo. Ancora adesso leggo di giornalisti che assaggiano delle mie bottiglie degli anni Settanta e scrivono cose magnifiche, dicendo che sono vini maturi, ma non vecchi, non decrepiti, molto profumati e belli rotondi in bocca. E questo mi dà ancora qualche bella soddisfazione. Tornando alla mia gioventù, finalmente se ne vanno i periodi più difficili, la guerra è finita e negli anni Cinquanta comincia già a vedersi qualche segnale di ripresa, l’economia si rimette in movimento e torna anche l’interesse per il vino di qualità, assieme a un po’ di soldi che consentono agli italiani di bere qualche bottiglia più di prima. E allora convinco mio padre a lasciarmi fare e a riprendere in mano la produzione di bottiglie che aveva iniziato mio nonno: è il 1960 e decido di far nascere la Bruno Giacosa. Avevo 31 anni e da 15 giravo per le cascine e per le vigne, per cui mi sentivo pronto a prendere l’iniziativa e a dimostrare che ero in grado di fare dei buoni vini. A quei tempi, per dire la verità, non avevo grande conoscenza dei vini del resto d’Italia e del mondo, ne avevo assaggiati ben pochi. Avevo però già degustato tantissimi vini delle Langhe e mi ero convinto che meritassero di più, che potessero tornare a essere importanti come ai tempi della nascita del Barolo, quando questo vino veniva apprezzato anche nelle corti europee. E, per dirla tutta, avevo anche assaggiato tanti vini non buoni, con dei difetti evidenti o che il nome Barolo ce l’avevano scritto solo sull’etichetta. Erano gli anni in cui non c’erano ancora le Doc, arrivate nel 1963, e men che meno le Docg, che sono del 1980; allora la produzione non era tenuta a rispettare molte regole e si continuava, addirittura, a sentir parlare di imbottigliatori locali che andavano nel Sud Italia a comprare partire di vini che venivano poi mescolate con il nostro nebbiolo. È così che decido di dedicarmi a fare solo vini di qualità. Intendiamoci, qualità per me non ha mai voluto dire solo Barolo e Barbaresco. Qualità per me ha sempre voluto dire fare il meglio possibile con le uve tipiche della nostra zona, con tutte le uve che si erano sempre coltivate nella parte meridionale del Piemonte, quindi dal Grignolino alla Freisa alla Barbera al Dolcetto. E, per fare vini di qualità, decido anche che avrei iniziato comprando le uve più belle che potevo nei più bei vigneti delle Langhe. A dire la verità, quando ho iniziato non avevo neanche la possibilità economica per pensare di comprare delle vigne, per cui mi andava bene così: era il 1960 e in quell’anno ho cominciato a etichettare 20.000 bottiglie di vini diversi, che ovviamente avevo vinificato e conservato nelle vendemmie precedenti, a partire dal 1957, che è la data della prima etichetta che ha portato il mio nome.
In quel periodo non avevo ancora una distribuzione come esiste oggi attraverso rappresentanti e importatori, per cui per lo più ricevevo direttamente in cantina dei privati e dei ristoratori che si caricavano direttamente il vino in macchina. Ma posso dire di aver avuto anche un po’ di fortuna, almeno per il bel periodo in cui ho iniziato. Infatti ho cominciato presto a vedere dei tedeschi, c’è stato un buon passaparola, qualche giornale ha fatto subito il mio nome e, insomma, sono riuscito a far crescere la produzione con buona costanza e a non avere mai dei problemi di vendita. Anzi, devo purtroppo dire che non sono mai stato attento a conservare delle bottiglie delle varie annate: e questo è uno sbaglio, perché non mi consente di far conoscere la memoria storica della mia cantina e di organizzare degustazioni di vini molto vecchi. Quindi voglio fare una raccomandazione a tutti i miei colleghi più giovani: tenete da parte delle bottiglie, soprattutto quelle delle annate più buone, perché vedrete che vi saranno utili e che faranno parlare di voi anche dopo decenni. Perché l’importanza di una zona enologica si dimostra quando si possono stappare delle bottiglie di 20, 30 o 40 anni e scoprire che sono ancora più buone di quando sono state messe in commercio, come hanno ben dimostrato i francesi.
A questo punto non posso non citare la persona che mi ha fatto decidere a fare un cambiamento che poi si sarebbe rivelato molto importante per la mia cantina e per tutta la zona.
E parlo di Luigi Veronelli.
Veronelli è venuto spesso ad assaggiare i miei vini, gli piacevano molto già nei primi anni Sessanta, però si lamentava perché “non avevano un nome”. Seduti a tavola - mentre mangiavamo assieme i piatti preparati da mia moglie Mariuccia, che quando poteva non dimenticava mai di fargli trovare dei tartufi, di cui lui era un grande appassionato - Veronelli continuava a dirmi di scrivere in bella evidenza sulle etichette il cru delle mie diverse selezioni. Infatti io, fino ad allora, scrivevo solo il nome del vino (ad es. Barolo o Nebbiolo d’Alba), al massimo arrivavo a scrivere Riserva nelle migliori annate, come ho fatto per la prima volta con il Barbaresco Riserva Speciale 1961. Io avevo ben in mente l’importanza dei singoli vigneti, che allora non si chiamavano ancora cru; era proprio il concetto che avevo alla base del mio lavoro di selezionatore di uve per me e per altre cantine con cui continuavo a fare il mediatore, però avevo un po’ di paura a fare questa scelta. Questo perché la tradizione più consolidata nelle Langhe era quella di unire le uve di vigne diverse (parlo soprattutto di Barolo e Barbaresco), e devo anche dire che qualche buon motivo per fare questi assemblaggi c’era: un anno c’era più siccità e venivano meglio le uve in una posizione un po’ meno soleggiata, un anno c’era la grandine che ti portava via mezzo raccolto in una vigna, e così via.
Inoltre, erano ben pochi i produttori che avevano già iniziato a scrivere il nome del vigneto sull’etichetta. Ricordiamoci che non c’era ancora la Carta dei vigneti del Barolo di Renato Ratti ed era ben lontano da venire l’Atlante delle vigne di Langa di Slow Food; però, in effetti, io una mia idea sulle migliori posizioni delle nostre colline me l’ero fatta.
Quindi, decisi che Veronelli aveva ragione e che chi si stava appassionando ai miei vini aveva il diritto di sapere il nome del vigneto in cui si coltivavano le uve che decidevo di vinificare; esco nel 1967 con le mie prime due etichette cru: Barbaresco Asili e Barolo Collina Rionda (quella che poi avrebbero chiamato Vigna Rionda), seguite nel 1968 dal Barbaresco Santo Stefano.
La mia idea di vino era allora, e lo è ancora oggi, piuttosto semplice: volevo fare dei vini molto buoni, quelli a base di nebbiolo dovevano migliorare per molti anni, e il tutto doveva avvenire nel modo più naturale possibile. Per fare un esempio, io non ho mai voluto, e ancora non voglio, aggiungere lieviti esterni, che ovviamente vanno a modificare un po’ le caratteristiche del vino, per cui tutte le fermentazioni voglio che si attivino solo con i lieviti naturali che ci sono nelle vigne e in cantina. E in vigna ho sempre cercato uve che fossero trattate il minimo possibile, anche se è diventato sempre più difficile. Faccio qui un inciso importante, che mi ha poi portato a cambiare l’impostazione dell’azienda e a comprare della terra: fino a quando non c’è stata la meccanizzazione e non ci sono stati i Consorzi agrari che hanno iniziato a vendere prodotti di tutti i generi, il lavoro in campagna era assolutamente semplice e avveniva senza tante diavolerie. Si faceva tutto a mano e ci si limitava a fare trattamenti con il verderame e con lo zolfo. Punto e basta, e le bucce delle uve erano spesse e compatte, non si disfacevano mai.
E voglio dire subito anche un’altra cosa: quando, siamo negli anni ’80 e ’90, c’è stata la polemica tra innovatori e tradizionalisti, spesso mi sono visto attribuire la qualifica di tradizionalista. Ma io non mi sono mai inserito nel dibattito. Voglio però dire che, in realtà, sì, io sono profondamente legato all’espressione più classica dell’uva nebbiolo, perché sono convinto che non abbia bisogno di aggiunte esterne. Sono sempre rimasto legato, quindi, all’uso di botti piuttosto grandi per la maturazione di Barolo e Barbaresco e non ho mai voluto adottare le barrique, proprio perché ho visto che una lenta evoluzione, come quella che avviene in una botte grande, è il modo migliore per arrivare a vini che rispettino al meglio la personalità delle nostre uve e che migliorino per molti anni in bottiglia.
Però devo anche dire che io ho sempre fatto dei cambiamenti, certo in modo lento, ma continuo. E che anno dopo anno ho studiato come realizzare vini ancora più buoni, come trattare le diverse vendemmie e i cambiamenti di clima che, comunque, ci sono sempre stati tra una vendemmia e l’altra.
Un tempo, ad esempio, facevo macerazioni sulle bucce che arrivavano a due o addirittura a tre mesi: ma quando non ho più avuto a disposizione delle uve che consentissero delle macerazioni così lunghe, ho ridotto gradualmente, e oggi è raro che superi i 20 giorni di contatto tra bucce e vino. Come ho anche presto abbandonato il cemento, che non mi dava tutte le garanzie di pulizia e di igiene che mi dà invece l’acciaio.
Allo stesso modo, ho visto che usare le stesse botti per molti anni, per decenni addirittura, come si faceva una volta, dà al vino dei profumi che, appena aperta la bottiglia, non sono sempre nitidi e franchi, per cui bisognerebbe fare come si consigliava un tempo, e cioè aprire la bottiglia qualche ora prima di berla. Ma oggi, quasi nessuno è più in grado di fare così, perché si va al ristorante e si sceglie un vino che sarà bevuto dopo 5 minuti.
Dopo varie esperienze ho allora deciso di non cambiare il volume delle botti, che possono tranquillamente restare attorno ai 10.000 litri o anche di più, ma che è opportuno cambiarle più spesso, diciamo attorno ai 10 anni. E, senza con questo fare l’occhiolino alla moda delle barrique, devo dire che da tanti anni uso solo legno di origine francese, che trovo molto fine, elegante e sicuramente adatto a far maturare bene il nebbiolo. Ma non voglio dire che mi sono inventato questo stile tutto da solo: con pochi produttori con cui avevo un rapporto di amicizia e di fiducia mi sono sempre confrontato volentieri, e insieme abbiamo parlato cento volte di come migliorare sempre di più i nostri vini.
Tra questi produttori ce ne sono almeno due che voglio ricordare e che voglio indicare a tutti come persone che hanno veramente fatto del bene al mondo del Barolo: sono Bartolo Mascarello e Aldo Conterno, che purtroppo ci hanno lasciati ma che spero di cuore che non siano mai dimenticati. Per quanto riguarda le mie scelte produttive, devo aggiungere che negli anni ’70 stava nascendo nel mercato anche una richiesta sempre più forte di vini bianchi, per cui ho deciso di dedicarmi al vitigno locale più importante, l’Arneis, e devo dire che ho avuto ottimi risultati da parte dei consumatori fin dal primo anno, che è stato il 1976. Pur non essendo io personalmente un appassionato di bianchi, ho cercato di fare un Arneis piuttosto intenso e importante, sempre e solo con uve di prima qualità, per cui è andata bene e sono contento di questa scelta.
Passa il tempo, intanto, e mi accorgo che trovare le mie uve ideali è sempre più difficile: a volte produzioni troppo alte di uva, in altri casi trattamenti che mi sembrano troppo incisivi, in altri casi ancora i vignaioli iniziano a diventare cantinieri e a prodursi da soli il loro vino: come tutti sanno questo è un fenomeno che dalla fine degli anni Settanta ha interessato in modo massiccio tutte le Langhe. Intanto avevo risparmiato qualcosa (anche perché non mi sono mai dato alla bella vita, ho sempre lavorato sodo, non ho mai sperperato soldi in giro e non mi sono fatto ville e barche) ed ero divenuto in grado di comprare qualcosa di importante.
Ovviamente, avevo già deciso che, quando avrei potuto mettere su delle vigne di mia proprietà, avrebbero dovuto essere quelle a cui ero più legato, quelle che mi avevano dato delle emozioni e che ero sicuro avrebbero potuto garantirmi di fare grandi vini. Ecco quindi che, nel 1980, riesco ad acquistare una grossa vigna in Serralunga, i 13 ettari del cru Falletto al completo (qui avevo già preso 1,5 ettari 5 anni prima e avevo visto che belle uve nascevano). Per arrivare a trovare un bellissimo vigneto in vendita nella zona del Barbaresco ho invece dovuto aspettare fino al 1996, quando ho avuto l’occasione di acquistare più di 5 ettari negli Asili. Nel ’98 ho comprato anche qualche ettaro vitato a La Morra, ma devo dire che ho poi rinunciato a fare un cru di Barolo con queste uve: ormai i miei vini erano piuttosto conosciuti, e non solo in Italia, per cui gli appassionati da me si attendevano vini robusti e importanti, mentre il Barolo che ricavavo di qui era un po’ più sottile e delicato. In compenso a La Morra faccio ottimi Dolcetto e Barbera.
Qui c’è una cosa molto importante che voglio dire: lavorare la vigna, oggi, non è più duro e faticoso com’era una volta, anche se comunque c’è da sudare. E resta un lavoro difficile e molto delicato, che deve essere fatto da persone che abbiano esperienza e voglia di fare bene. Per questo, quando devo comprare delle uve, voglio sempre essere ben sicuro di chi va nei filari, di chi fa le potature, eccetera. E io, nei miei vigneti, ho tutto personale fisso e regolarmente assunto, che anno dopo anno migliora le proprie capacità.
Mi spiace anche molto vedere che i giovani italiani non vogliono più fare i vignaioli, come se fosse un lavoro di serie B.
Io invece voglio dire a tutti che lavorare la campagna può dare grandi soddisfazioni: vedere come si fa crescere un vigneto, che tipo di uve maturano e fare una bella vendemmia può essere un bel lavoro anche se poi si vendono le uve e non le si vinifica direttamente, per cui mi auguro che ci sia una rivalutazione della figura del vignaiolo, che, non dimentichiamolo mai, è quello che decide se il vino sarà buono oppure no, perché in cantina c’è ben poco da inventare e, se le uve non sono sane, non si potrà mai inventare una grande bottiglia. Quindi il mio augurio è che, come noi produttori siamo diventati famosi e abbiamo fatto un po’ di fortuna, e quindi adesso tutti ci guardano con rispetto, anche il lavoro del contadino riacquisti la considerazione che merita, anche a livello economico.
Come dicevo, sono stato tradizionalista anche in tutti i vitigni che ho scelto di vinificare, tutti espressione del nostro territorio. Ho voluto fare un’eccezione solo con lo Spumante, che ho iniziato a proporre nel 1983 con uve pinot nero provenienti dall’Oltrepò Pavese. Ma, a guardare bene, in Piemonte c’era una tradizione ormai più che secolare di produzione di spumanti, per cui mi sono semplicemente collegato alla nostra storia, senza fare strappi.
Vorrei aggiungere una cosa sul mio modo di lavorare, sperando che serva come indicazione anche ai più giovani: io sono sempre stato un po’ accentratore, forse anche troppo, quando c’era da controllare che le fermentazioni andassero bene io stavo in cantina anche di notte e mi fidavo più di me che degli altri. Ma ho avuto la fortuna di avere attorno a me una squadra valida che ha capito l’importanza di questo lavoro e che ha collaborato alla sua riuscita: da mia moglie Mariuccia, che non si è mai occupata direttamente di vino, ma che ha organizzato la mia vita in modo che io mi sentissi sempre a mio agio nel lavoro, a mia figlia Bruna, che da vent’anni è impegnata con entusiasmo e spirito di sacrificio a valorizzare i nostri vini qui e nel mondo, ai miei collaboratori, tra cui cito solo lo storico cantiniere Dante Scaglione e il giovanissimo e prezioso Francesco Versio. Per concludere vorrei dire questo: ho avuto molta fortuna, i miei vini sono apprezzati in tutto il mondo, lascerò alla mia famiglia e alla mia terra un nome che è diventato importante per tanti appassionati di vino, e la cosa mi fa ovviamente piacere.
E di questo devo rendere omaggio anche a chi si è con passione dedicato alla valorizzazione dei nostri vini e delle nostre terre. Ho già ricordato Luigi Veronelli, ma, a partire dalla fine degli anni ’80, Slow Food è stato quello che impresso una nuova marcia e ha consentito l’affermazione a livello mondiale dei vini delle Langhe. Con la sua guida Vini d’Italia, pubblicata assieme al Gambero Rosso e tradotta in tedesco e in inglese, con l’Atlante delle vigne di Langa, con mille iniziative che ci hanno messo sotto i riflettori di tutto il mondo.
E, a proposito di mondo, devo ringraziare tutti i giornalisti che in noi hanno creduto. Per quanto riguarda me personalmente, io non ho mai frequentato molti giornalisti, ma ci tengo a sottolineare il ruolo che hanno avuto e che hanno Robert Parker e James Sackling, e prima ancora i simpatici coniugi Wasserman: ma se ci penso devo dire che siamo un po’ tutti a dover ringraziare questi giornalisti, non solo io, perché hanno veramente aperto alle Langhe i mercati internazionali, non solo quelli nordamericani.
Ai giovani che sono qui oggi a sentirmi voglio dire un’altra cosa, voglio segnalare un errore che io ho fatto ma che loro non devono ripetere: viaggiate, andate per il mondo, assaggiate vini fatti da altre parti e quelli dei vostri vicini, perché non è più il periodo adatto per occuparsi di cantina e vigna e basta.
Lo ripeto: è stato un mio errore quello di aver viaggiato poco e di non aver studiato altre lingue, ma voi giovani imparate a confrontarvi con produttori e mercati di altri Paesi, perché sarà utile a formare anche una cultura più aperta e non più chiusa nel nostro provincialismo. E con questo ho finito davvero. La cosa che mi fa più piacere, al di là della mia cantina, è vedere che le Langhe sono diventate sempre più un luogo in cui si produce qualità, che il nome di queste terre è stato inserito nella ristretta cerchia delle aree più vocate del pianeta, che questi vini hanno finalmente il successo che io, fin da giovane, speravo che avrebbero potuto meritarsi. Non è stato facile, e anche oggi viviamo dei momenti poco sereni, ma sono orgoglioso di aver contribuito a diffondere nel mondo l’immagine dei vini Barolo e Barbaresco: ci saranno ancora crisi economiche e si potranno ridurre ancora i consumi di vino, ma questi due nomi sono entrati nel cuore, e nella bocca, di tanti appassionati e ci garantiscono di poter guardare al futuro con un po’ di serenità.
Io non so se merito questa laurea, ma sono lieto di poterla dedicare a tutti i produttori che fanno vino di qualità nelle Langhe.
Focus - Prolusione del prof Nicola Perullo alla laurea “Honoris Causa” a Bruno Giacosa
Giunta all’ottavo anno dalla sua fondazione, l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo conferisce la sua prima Laurea honoris causa. L’inaugurazione di questo atto, importante per ogni Università ma particolarmente rilevante per una piccola realtà quale Pollenzo, s’incarica perciò di un valore simbolico forte, che intende esprimere la cifra culturale e il segno distintivo della nostra piccola e recente Accademia. Date tali premesse, la decisione su chi investire del significato di tale inaugurazione poteva sembrare difficile. Se, da una parte, è stata una decisione a lungo ponderata, d’altra parte occorre però confessare che questa scelta non si è rilevata poi così ardua.
Appena si è proposto il nome di Bruno Giacosa, infatti, tutto il corpo accademico ha facilmente convenuto che si era di fronte a un caso lampante. A un raro caso di perfetta corrispondenza tra oggettivi meriti, propri dell’uomo a cui si voleva conferire il riconoscimento di una honoris causa, e quei valori culturali attorno a cui si è costituita l’idea stessa dell’Università di Pollenzo e che essa, con la sua didattica e la sua ricerca, tenta di promulgare e insegnare.
In sintesi, ecco i meriti oggettivi e evidenti dell’uomo: produttore di grandi vini da più di sessant’anni, Bruno Giacosa è stato uno dei precursori della stagione della rinascita della vitivinicoltura italiana di qualità, avvenuta negli anni ’80. Egli, infatti, già dagli anni ’60 e ’70 si è proposto sul mercato internazionale con vini, apprezzati da tutti gli appassionati, che lo hanno fatto conoscere come firma individuale ma che, al contempo, hanno fatto conoscere la sua terra d’origine, quella nella quale ha sempre operato, le Langhe. Questi meriti oggettivi si declinano però in una serie di valori, intellettuali e umani, che rappresentano l’emblema specifico dell’opera di Giacosa e che, come dicevo, corrispondono perfettamente ai compiti che la nostra Università si è data, fin dalla sua fondazione. Mi soffermerò particolarmente su tre di essi, per evidenziare come Giacosa ne rappresenti l’incarnazione piena e puntuale.
Il primo valore è l’artigianalità.
La nozione di “artigiano” è oggi al centro di un intenso dibattito nelle scienze sociali e nella filosofia; qui interessa sottolinearne sia la valenza innovativa e euristica rispetto al modello di conoscenza assiomatico, astratto e deduttivo proprio della società industriale sia la valenza etica ed estetica. Considerare l’artigianalità un valore, in altri termini, significa promuovere la piena dignità intellettuale, cognitiva e sociale del lavoro manuale proprio dell’homo laborans. L’homo laborans non è l’homo faber: se quest’ultimo si caratterizza per uno studio teorico che sfocia solitamente in mansioni di tipo intellettuale richiedenti un’alta capacità di concettualizzazione e verbalizzazione, l’homo laborans si caratterizza al contrario per un apprendimento induttivo ed esperienziale che sfocia in attività “sul campo”, pratiche e induttive le quali, a differenza di quelle intellettuali, si esprimono quasi sempre attraverso quello che per la prima volta il filosofo Michael Polanyi definì “sapere tacito”. Pratica, expertise, sapere tacito sono le caratteristiche del lavoro artigianale nel suo senso più alto.
Ora, Giacosa rappresenta in misura esemplare - per usare le parole del titolo del libro di Richard Sennett - l’“uomo artigiano”, colui che arriva a possedere, grazie a un esercizio continuativo e appassionato, le più alte capacità tecniche in un determinato campo. Queste capacità tecniche si cristallizzano in un sapere che, più che concettuale e teorico, risulta tacito e implicito. Tutti coloro che lo conoscono di persona, sanno della poca propensione di Giacosa per la parola parlata, per la spiegazione verbale delle sue opere, i vini che ha elaborato in tutti questi anni: questo lato quasi proverbiale del suo carattere coglie forse anche un aspetto specifico della figura dell’artigiano ma anche dell’artista, almeno nel significato classico della nozione, non quello dell’arte contemporanea in cui l’artista è anche manager e promotore di se stesso.
Chi è infatti Bruno Giacosa? Forse la definizione più bella fu data tanti anni fa da Luigi Veronelli: Giacosa è un grande vinicultore.
“Il termine - scriveva Veronelli recensendo quel capolavoro che fu il Barbaresco Santo Stefano del 1971 sulla rubrica “Il buon vino” del settimanale Panorama - sembrerebbe ‘coniato’ su di lui”. Vinicultore, nell’intenzione di Veronelli, è innanzitutto colui che, grazie a cura, sensibilità, passione e giudizio, conferisce un senso culturale pieno a quegli strani artefatti naturali che sono i vini. Ma questa parola - vinicultore - gioca anche con un altro significato, nel quale risiede un aspetto molto specifico dell’opera di Giacosa, quello cioè di aver legato la sua fama anche al fatto di essere un acquirente di uve dal fiuto infallibile. Giacosa infatti per molto tempo e per buona parte della sua produzione non ha posseduto vigneti di proprietà: alcuni arriveranno in piccola parte solo dopo, la prima nel 1980, poi nel 1996 e nel 1998.
Il secondo valore è il sentimento di comunità.
Esso corrisponde, in un senso generale, a un profondo attaccamento nei riguardi del proprio luogo e dei suoi relativi saperi. Questo sentimento, insieme geografico e storico, si esprime come relazione dinamica tra la propria origine e il proprio destino: Giacosa nasce infatti ad Alba nel 1929, in una famiglia legata al vino e alla ristorazione, e nel 1960 decide di ripartire con l’attività produttiva che già faceva il nonno e che poi era stata interrotta dal padre per le vicende belliche. Il sentimento di comunità che Giacosa incarna corrisponde a quella che è stata definita ecumene (etimologicamente, la porzione di terra abitata dall’uomo, indi la casa dove tutti viviamo): è una nozione ripresa dalla geografia umana e dalla filosofia francese (in particolare da Augustin Berque) che vuole esprimere la relazione attiva e produttiva, ma al contempo attenta e rispettosa, tra l’uomo e lo spazio che abita. Giacosa ha interpretato tale relazione tra spazio e tempo, tra origine e destino, nel significato più alto: non con la chiacchiera né con relazioni opportunistiche e formali, ma con la conoscenza profonda e incessante di un territorio come mappa colturale e culturale. Ciò lo ha portato a diventare non solo un punto di riferimento per tutti i produttori italiani di vino di qualità ma, anche e innanzitutto, un vero e proprio genius loci delle Langhe.
Concretamente, questo è avvenuto grazie alla strada, intrapresa già negli anni ’60, in tempi non sospetti, della valorizzazione dei vitigni locali e dei singoli vigneti, che lo hanno condotto, nel 1967, a produrre rispettivamente il primo Barolo e il primo Barbaresco frutto di singoli cru, quando in quegli anni l’uso corrente era quello di citare sulle etichette solo il nome generico del vino. Però, Giacosa incorpora l’abilità di conoscere e di essere parte di quella ecumene, come dicevo prima, di quello spazio antropizzato - si potrebbe qui dire letteralmente calpestato e vissuto passo dopo passo - non in senso conservativo e passatistico: per quanto sia stato solitamente identificato come uno strenuo difensore della classicità dei vini delle Langhe, Giacosa non è mai stato un nostalgico. Egli in realtà ha interpretato con perizia, passione e conoscenza pluridecennale la sua provenienza, trasformandola in un destino di ricerca: continue sono state le sue sperimentazioni volte a realizzare, con i suoi vini, l’espressione più fedele di quel sentimento dinamico e interattivo di comunità. E sicuramente la filosofia di Giacosa è stata seguita da tutti coloro che, innanzitutto in Langa, hanno voluto intraprendere percorsi di eccellenza qualitativa.
Il terzo valore è infine quello della imprenditorialità d’eccellenza.
Esso corrisponde allo sviluppo concreto e fattivo dei due precedenti valori all’interno del mercato e della competizione. Forte di un successo immediatamente decretatogli dal mercato locale, con i grandi ristoranti delle Langhe che proposero da subito e con fiducia le sue diverse etichette a un turismo enologico che era allora in fase di forte sviluppo, Giacosa decise già negli anni ’70 di lanciarsi con determinazione sul mercato internazionale, in particolare quello tedesco e quello statunitense. E lo ha fatto con uno stile unico, proprio di chi intende accettare il successo solo come conseguenza della sua opera, cioè sul valore dei propri vini. Egli, in altri termini, non si è dedicato a operazioni di marketing né a pubbliche relazioni, nella convinzione, propria del vero e ostinato artigiano, che la qualità del prodotto sia condizione necessaria, e di per sé sufficiente, per guadagnare ovunque stima e apprezzamento. Bruno Giacosa è oggi riconosciuto come ambasciatore del vino italiano di qualità a livello mondiale, ma è forse anche un volto poco noto ai ristoratori californiani, tedeschi o giapponesi che conoscono invece perfettamente tutte le sue etichette. Questi tre valori - artigianalità, sentimento di comunità, imprenditorialità d’eccellenza - sono valori che, come spesso si dice, dovrebbero caratterizzare il “made in Italy” nel mondo; e che, nelle loro espressioni migliori, corrispondono a un artigianato artistico o un’arte artigianale di primario rilievo. Ora, il vino di Giacosa è da intendersi proprio così: non quale mera commodity, non semplice “prodotto di consumo” ma qualcosa di più, qualcosa che incarna valori simbolici, sociali, storici, estetici. Tutti coloro che amano il vino, e che ne apprezzano le sue uniche caratteristiche - la sua varietà espressiva dovuta all’interazione tra vitigno, suolo, lavoro umano, e la sua capacità di evolvere e di invecchiare, di modificarsi sorprendendo - sanno che il vino non è una bevanda come un’altra.
All’inizio ho ricordato il Barbaresco Santo Stefano di Neive del 1971, ma avrei certo dovuto anche ricordare il Barolo Vigna Rionda. Fu un anno memorabile per i vini di Giacosa e per i vini delle Langhe: “un vino così non si farà mai più”, disse Giacosa a Veronelli.
Ma il 1971 fu un anno importante anche perché furono dati alle stampe due opere notevoli. La prima è Il vino giusto, appunto di Luigi Veronelli, a cui la nostra Università ha dedicato lo scorso Maggio un convegno, il primo specifico a lui dedicato dalla sua morte, avvenuta nel 2004. L’altra opera è la seconda serie di Vino al vino, un libro-reportage di Mario Soldati sulla produzione vitivinicola italiana. Nell’introduzione, “Il vino come opera d’arte”, Soldati scriveva: “Tra i due estremi, il manufatto calcolabile e programmabile sia nei modi e nei tempi della lavorazione sia nella qualità del risultato finale, e l’opera d’arte, imprevedibile e misteriosa, il vino assomiglia, in ogni caso, più a questa che a quello. Il profumo, il sapore, l’incanto ultimo e individuale di un buon bicchiere di vino si identifica, in definitiva, con un quid che sfugge a qualsiasi analisi scientifica: allo stesso modo, appunto, che nessuna dimostrazione filologica potrà mai tradurre in formule o in ragionamenti la bellezza di un Tiziano o di un Leonardo; né la bellezza o la bontà di una persona umana”.
Perché la capacità tecnica, il savoir-faire artigianale incarnato dal vinicultore non è in nulla diverso dall’arte nel suo significato più antico e longevo, quello di techne, un saper-fare secondo regole, una perizia tecnica guidata da abilità e giudizio, ma anche da sensibilità e rispetto. Il vino non è una cosa, non è materia inerte: è un sistema vivo e complesso che, come tale, va trattato con cura. Il vinicultore è colui che sa educare e allevare questo “essere vivente” per lasciarlo esprimere secondo tutte le sue potenzialità e senza stravolgerlo.
Questa breve Laudatio è giunta al termine. Voglio concludere dedicando a Bruno Giacosa e ai suoi vini, ma anche a tutti i produttori di Langa oggi qui presenti per testimoniare il loro affetto e la loro stima nei confronti del nostro nuovo Dottore in Scienze Gastronomiche, due brevissimi versi del grande poeta persiano Hafez, vissuto nel XIV secolo e autore del Divan, un classico della letteratura persiana in cui si cantano l’amore, le gioie della vita e il vino. In questi versi possiamo cogliere tutta la saggezza del vino:
Vieni, il palazzo del cielo riposa su pilastri d’aria.
Vieni e portami il vino: i nostri giorni sono vento.
Copyright © 2000/2026
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026