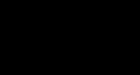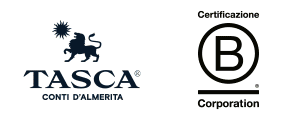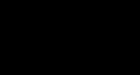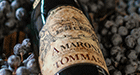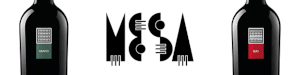Nata nel Sussex, nella campagna inglese, e trasferitasi nel 1971 a Milano, dove ha collaborato con “Il Giornale” di Indro Montanelli e il periodico “Casabella”, nella città italiana che l’ha accolta, ha sentito da subito una forte nostalgia per il paesaggio inglese. Dal 1988, collaboratrice del quotidiano “International Herald Tribune”, si è trasferita così in Val d’Orcia, dove ha scoperto il fascino del mondo agricolo legato al territorio, ai suoi prodotti enogastronomici e alla loro storia.
La giornalista inglese Kate Singleton ha scelto così di raccontare il suo approccio al paesaggio italiano, partendo dalla sua esperienza di paesaggio inglese, ed evidenziando come proprio il paesaggio sia un mirabile incontro tra cultura e coltura e la più eloquente espressione della storia, per la sua capacità di raccontare ogni civiltà: un ruolo, che rischia però oggi di essere perso.
E’ all’Accademia dei Georgofili a Firenze, che la Singleton ha scelto di interrogarsi sulle ragioni che contribuiscono a questa perdita, proponendo alcune idee per rendere consapevole, partecipe e responsabile il cittadino, fruitore diretto e indiretto del paesaggio.
Focus - Lo sguardo di Kate Singleton
Da molto giovani è facile credere che la propria realtà sia comune a tutti, che certe cose che ci sembrano normali siano esperienza condivisa dai coetanei dovunque abitino. Per esempio, da ragazza ho creduto che tutti godessero del paesaggio, che considero un bene generoso e esigente. Ho potuto nutrire questa ridicola illusione perché non conoscevo la città.
Sono nata e cresciuta in una zona molto bella dell’Inghilterra, vicino al Galles centrale. La contea si chiama Herefordshire, che è anche il nome di un’ottima razza bovina. Il paesaggio è collinare, e l’agricoltura mista. Da ragazzi, verso la fine dell’estate assistevamo alla raccolta del luppolo, che si usava per dare sapore alla birra. Quei fiori verdi e un po’ oleosi tingevano le mani di scuro, impregnandole di un sapore amaro e sgradevole. Assai più piacevole era la raccolta delle mele che si adoperavano - e si adoperano ancora, grazie a un felice ritorno a una tradizione antica - per il sidro. Nei frutteti le varietà erano miste. Si riempiva un sacco di iuta con le mele, poi lo si scuoteva. Se le mele scricchiolavano, voleva dire che la mescolanza di varietà era adatta per creare la bevanda desiderata. Il sidro buono era assai alcolico. Ricordo che si stipulavano accordi con i braccianti per fissare non solo la somma da pagare per il lavoro svolto, ma anche la quantità di sidro da fornire ogni giorno. Era considerato alla stregua di un arnese liquido, un rimedio per la fatica: troppo poco, e il lavoro era ingrato; troppo, e andava storto. L’equilibrio era tutto, come sempre.
Non immaginavo che si potesse vivere senza paesaggio. O meglio, non immaginavo che ci fossero persone che vivevano senza paesaggio. Era una parte essenziale della mia realtà. Attraversare i campi e un boschetto di larici a piedi per raggiungere la cresta delle colline era una delle nostre spedizioni preferite. Di solito ci fermavamo a metà percorso in una fossa ombreggiata, dove la parete rocciosa, con il nostro aiuto, si lasciava sbriciolare. E in quelle schegge trovavamo dei piccoli fossili impressi con la forma perfetta di conchiglie di varia natura. Eppure eravamo tanto lontano dal mare. Incominciavamo a capire che il paesaggio è anche mutevole e narratore.
L’altro mio apprendimento dal paesaggio d’infanzia era l’esperienza del senso di benessere, di prospettiva ritrovata, che esso poteva impartire. Immergersi nel paesaggio favorisce la riflessione centrifuga, altruista in senso lato, porta il pensiero lontano da sé, il che è spesso salutare. Infatti, i miei genitori, ognuno per conto proprio, uscivano non appena potevano per camminare, e in quelle ore rubate ad altri impegni trovavano sicuramente un appagamento profondo. Mio padre, severo professore di latino e greco, si era accollato il compito di controllare che la sconfinata rete di sentieri che dai tempi antichi creava collegamenti nelle campagne non venisse decurtata da agricoltori pronti a eliminare vecchie siepi e vie sterrate con i loro mezzi sempre più grossi e onnivori. I sentieri erano un patrimonio di tutti. Andavano tutelati. Fino all’età di ottantadue anni mio padre ha mantenuto questo impegno, alle volte con una ferocia che ci sembrava quasi comica. A pensarci oggi, riconosco in lui un’attenzione alla realtà rurale che è sempre più necessaria, e - temo - rara.
Nel 1971, ancora studentessa, mi sono trasferita a Milano, città che offriva molti stimoli a una persona giovane, ma non certo la consolazione del paesaggio. Ogni tanto la nostalgia per la campagna mi spronava a pedalare lungo i Navigli, i canali che un tempo costituivano le vie di trasporto principali per la città. Lasciati gli ultimi casermoni dell’ingorda periferia, quello che trovavo mi sembrava deludente: qualche campo di granoturco e maleodoranti risaie dai bordi schiumosi - possibile che il dorato risotto alla milanese trasse origine da un tale piattume?
Dopo qualche anno, comunque, ho capito che anche la pianura aveva una sua bellezza, soprattutto quando i riflessi nell’acqua di un mutevole cielo e i filari di pioppi investivano la preponderante orizzontalità con un poco di movimento. Inoltre, per fortuna mia, avevo cominciato a conoscere il più vasto e vario paesaggio italiano per vie indirette. Dal 1975 per qualche anno ho lavorato in redazione presso “Casabella”, la storica rivista di architettura italiana. Uno dei primi numeri della gestione cui ho partecipato era una monografia imperniata sul governo del paesaggio. Recava il presciente titolo: “Agricoltura - un appuntamento mancato”. Ai primi degli anni Ottanta, poi, ho iniziato una lunga collaborazione con “il Giornale” di Indro Montanelli. Modesta collaboratrice esterna com’ero, mi occupavo volentieri delle mostre considerate “minori” e quindi non degne dei grandi critici. Tra queste, esposizioni sulle tradizioni ceramiche e tessili italiane. Me ne sono occupata con crescente entusiasmo, anche perché, a pensarci bene, sia la terracotta che il tessuto hanno legami diretti e imprescindibili con paesaggio. A riprova del valore di questo nesso, oggi c’è un’azienda del Veneto che produce tessuti magnifici a base di lane autoctone provenienti da piccoli allevamenti nelle Marche e nel Piemonte. Ancora più confortante è il produttore tessile d’avanguardia dell’area bresciana, che ha sviluppato dei filati di grande interesse ottenuti da fibre provenienti dal latte, dal legname verde, dal mais e dalla ginestra.
A un certo punto, ho sentito la necessità di vivere di nuovo in un ambito rurale. Mi sono trasferita in Val d’Orcia. Era il 1988, prima della diffusione dell’agriturismo, prima della fondazione di Slow Food, prima del Salone del Gusto di Torino e delle varie guide che oggi dettano legge sull’enogastronomia italiana. Molti poderi erano già vuoti, anche se a coltivare i terreni intorno erano spesso ancora gli ex-mezzadri, trasferitisi “in paese”. Le strade vicinali e poderali erano ancora percorribili, si vedevano ancora vigneti con le viti sostenuti dal testucchio, e ai mercati erano i piccoli coltivatori diretti a vendere frutta e verdura.
A quell’epoca, collaboravo già da diversi anni con il quotidiano “International Herald Tribune”, scrivendo spesso di arte. Andavo qualche volta a Roma, Padova o Napoli per recensire una mostra, ma poi poco alla volta ho puntato l’attenzione su arti altrettanto storiche, ma meno auliche: quelle inerenti la coltivazione e la preparazione di particolari prodotti alimentari, e il rapporto tra questi beni e la conformazione del paesaggio. L’Italia ne era particolarmente ricca, mentre l’Inghilterra della mia gioventù ne era già impoverita. Mi sono accorta che raccontare di un certo legume, o formaggio, o vino, o insaccato voleva dire descrivere un territorio e le persone che ci abitano, e con il lavoro plasmano il paesaggio. Il paesaggio è il punto d’incontro tra coltura e cultura. Cercavo di renderlo leggibile ai miei lettori.
Alcuni paesaggi italiani mi sono rimasti particolarmente impressi. Ve ne offro qualche esempio, scegliendo tra quelli che immagino siano meno noti a un pubblico toscano. Nel 2004, mentre lavoravo su un libro che riguardava i vini della Sicilia, mi giunse voce che sull’Etna c’era un vigneto che ogni anno era sommerso dall’acqua per diversi mesi. Chiedendo lumi a qualche agronomo siciliano esperto di altre zone dell’isola, mi ero sentita dire che una cosa del genere era impossibile, che la vite non sarebbe sopravvissuta a un’inondazione protratta. Spronata dalla curiosità, mi ci sono recata nel mese di marzo, quando le acque si stavano già ritirando. E quello che ho visto era davvero sorprendente. Un vasto lago dal quale spuntavano nodosi rami come le braccia alzate di neiadi oranti.
La contrada si chiama Gurrida ed è situata in una pianura alluvionale a circa 850 metri sopra il livello del mare nel territorio dell’antica città di Randazzo, compresa tra le pendici nord occidentali dell’Etna e quei meridionali dei Nebrodi. A quest’altitudine, di giorno le temperature estive possono raggiungere i 30-35°, mentre di notte scendono a circa 12°. Qui c’è un’azienda agricola che comprende 170 ettari, tra frutteti, pascoli e vigneto. E ogni anno, di fatto, a fine autunno, le acque piovane provenienti dalle montagne circostanti sommergono una trentina di ettari di vigna fino alla primavera successiva.
Si vede che alcune delle piante allagate sono molto vecchie. E il mistero s’infittisce nello scoprire che si tratta di una varietà insolita per l’Etna: il Grenache. La spiegazione ci riporta ai primi dell’Ottocento, quando Re Ferdinando di Napoli volle esprimere riconoscenza al vittorioso ammiraglio britannico Horatio Nelson conferendogli la Ducea di Bronte. Al novello Duca, che mai mise piede in quel vasto comprensorio etneo, parve interessante l’idea di produrvi vini per rifornire la flotta e il mercato inglesi. A questo fine incaricò un agronomo francese di nome Fabre della scelta di ubicazioni, varietà e del governo degli impianti. Fabre decise che un vitigno adatto al clima della montagna poteva essere il Grenache, già ben sperimentato nei Pirenei.
Tutto andò per il verso giusto fino ai primi del Novecento, quando l’arrivo della Filossera mise fine all’impresa vitivinicola europea per vari decenni. All’impianto di contrada Gurrida, invece, il flagello fu evitato perché l’afide parassita non sopravvive in acqua. Durante l’ultimo quarto del secolo scorso, questo vigneto, nato ad alberello ma trasformato in seguito in allevamento a spalliera, sofferse lunghi anni di abbandono. Poi, nel 1990, l’attuale proprietario prese in mano la situazione e scoprì che tutte le piante erano a piede franco: quelle più giovane erano frutto della propagazione, e quelle più vecchie risalivano addirittura all’impianto originario; ossia, avevano più di 200 anni.
Se questa è storia con la esse maiuscola, esiste perché il paesaggio è da sempre un sommo narratore. Racconta con la stessa eloquenza le grandi storie e quelle più piccole e discrete. Restiamo nell’ambito dell’Etna, e troviamo terreni vulcanici differenti, provenienti da colate laviche di diverso periodo e tipo. Mi ha sempre colpito pensare che a infliggere la prima ferita alla dura corazza lavica siano modesti licheni, seguiti dal finocchietto selvatico, capace nel tempo a spaccare la pietra. Ho ammirato la precisione dei muretti e dei terrazzamenti, costruiti con la pietra dissodata dai campi. E mi sono meravigliata davanti alle curiose strutture coniche di pietra, erette ad arte e volute, si potrebbe pensare, per qualche scopo sociale o rituale, come i nuraghi in Sardegna. Invece no. Si tratta semplicemente di una forma di accatastamento ordinato: bisogna mettere le pietre che si tolgono dai campi da qualche parte, quindi tanto vale che siano ammassate con cura. Mi pare un esempio emblematico della ricchezza dell’arte povera.
Un altro paesaggio vulcanico che ho trovato particolarmente interessante è quello dell’isola di Pantelleria. Qui, la realtà agricola è plasmata non soltanto dalla presenza di friabili terreni di origine vulcanica, perfettamente drenanti e ricchi di minerali, ma anche dalla costanza di un vento che soffia tanto forte da piegare le piante. Per coltivare lo Zibibbo, o Moscato d’Alessandria, per il famoso vino dolce, i panteschi cavano per ogni vite una conca in terra e usano un sistema di potatura tanto basso da far sì che i bordi della conca offrano il necessario riparo dal vento. Ho visto olivi sull’isola non più alti di un metro da terra, con la chioma carica di frutta. Sembravano inchinati in un atto di sudditanza verso Eolo, dio del vento. Bella e pratica è anche l’usanza di disporre l’uva raccolta per l’appassimento su stuoia adagiate per terra, lungo un muretto di pietra lavica che di notte rilascia il calore assorbito durante il giorno e così impedisce la formazione di muffe. Ma il colmo dell’arte muraria su quest’affascinante isola è sicuramente “il giardino”: ossia un muro alto anche due metri costruito intorno a un unico albero da frutta, spesso un arancio o un limone. Non solo il paesaggio agricolo è abile affabulatore. Spesso lo sono anche le zone incolte.
Nell’estremo sudest della Sicilia, in provincia di Ragusa, dove la roccia bianca calcarea affiora tra i carrubi, ci sono grandi solchi tagliati nel terreno da flussi d’acqua da millenni prosciugati. La disponibilità dell’acqua e la natura scavabile della roccia avrà persuaso i popoli antichi a insediarsi in queste zone. Se hanno adoperato delle grotte naturali per il proprio riparo, per i rituali della memoria, ossia la sepoltura dei defunti, hanno scavato tombe più articolate nelle pareti rocciose. A molti secoli di distanza, gli stessi vani funerari sono stati trasformati in laboratori per la lavorazione del vino o dell’olio, o addirittura in abitazioni. Città importanti per la loro storia architettonica più recente sono nate così: Modica in Sicilia, per esempio, ma anche Matera in Basilicata e Pitigliano in Toscana.
Da questa prospettiva, il paesaggio appare come il più importante monumento, la più eloquente espressione della storia che si possa contemplare. Dopotutto, per etimologia la parola “monumento” significa ricordare, far sapere. E allora mi chiedo: come mai assistiamo a una fase in cui il paesaggio è tanto disconosciuto, misconosciuto, o bistrattato?
Credo che le ragioni di questa poco confortante situazione siano almeno tre. In primo luogo, una popolazione sempre più urbanizzata ha perso il contatto diretto con le terre di provenienza del cibo che mangia. E’ un fenomeno strano in un paese in cui ognuno è fiero della specialità gastronomica del luogo d’origine. Si vuole mangiare pesce locale, ma si usa la spiaggia come portacenere; si parla dell’auspicabile filiera corta, ma le strade di campagna sono spesso piene di bottiglie di plastica, persino in Toscana; si partecipa a politiche edilizie sprovvedute e ci si lagna dei dissesti che ne derivano.
C’è da domandarsi se organizzazioni quali Slow Food, che tanto hanno contribuito a far conoscere e riconoscere il patrimonio enogastronomico italiano, non abbiano peccato di miopia nell’individuazione dell’ambito d’intervento: i laboratori del gusto e le degustazioni che hanno incontrato tanto successo dovevano forse essere coadiuvati da qualche forma di educazione al paesaggio.
Un secondo aspetto dell’argomento riguarda le amministrazioni locali, dove la lungimiranza non è sempre di casa. Credo che uno dei problemi di partenza sia insito nella maniera di concepire il paesaggio. Si rischia di sostituire la fotografia, specialmente quella digitale, all’osservazione, in tal modo dando l’idea che il paesaggio sia entità immutabile, da conservare come se fosse una costruzione in pietra o mattoni. E’ una tendenza diffusa. Qualche anno fa, nella mia nativa Herefordshire, l’introduzione della coltivazione della colza ha suscitato volubile indignazione: il giallo dell’infiorescenza non era un colore “nostrano”; era troppo forte, stridente, persino volgare. Poi, con il tempo, la composizione visiva creata dalle strisce di giallo in mezzo al vario verde ha attirato l’attenzione dei fotografi e l’immagine ne è diventata consueta. Al paesaggio non si può imporre la fissità, specialmente per quanto riguarda le coltivazioni, che necessariamente rispondono a esigenze di mercato. Conservare il paesaggio è essenziale; ma cercare di ingabbiarlo sarebbe un errore.
In questi mesi sto seguendo un progetto che mi porta spesso in Valpolicella nel Veneto. E’ una zona piena di storia e bellezze naturali, un’isola rara e felice in una regione che ha largamente barattato il paesaggio con l’industria. Da tempo ci sono due anime nella Valpolicella. Da una parte, c’è l’estrazione di una splendida pietra di colore rosato, e dall’altra, la viticoltura, l’olivicoltura e, seppure in lieve declino, la coltivazione delle ciliegie. Le cave sono disseminate in tutto il territorio, ma con un minimo di discrezione e senza creare uno squarcio nel paesaggio. Sembra, pertanto, una convivenza relativamente civile. Più critico pare lo sviluppo della zona pedemontana. Sei sono i Comuni del comprensorio collinare dove si pratica la viticultura di pregio. Ognuno ha voluto un proprio centro commerciale o industriale, anche se la distanza fra un comune e l’altro è veramente poca. Il risultato è una disordinata urbanizzazione che costituisce un approccio poco invitante a una zona altrimenti ricca di attrattive. Per di più, sono in programma dei lavori per aumentare superficie e produzione di un locale cementificio, da dotarsi pure di una ciminiera alta più di cento metri. E’ il classico scontro d’interessi: in questo caso, tra l’industria del cemento e dell’edilizia da una parte, e l’agricoltura di qualità e il turismo sostenibile dall’altra. Gli interessi ci sono sempre stati. E le soluzioni ragionevoli si possono trovare. Ma il comitato che si adopera per opporsi a questa sciagura trova nel disinteresse di molti cittadini lo scoglio più difficile da superare.
Il terzo aspetto dell’attuale sofferenza del paesaggio riguarda il senso di isolamento espresso da molti agricoltori, specialmente quelli più giovani. Hanno poca voce, e spesso mancano di affidabili interlocutori, al livello locale e nazionale. Eppure le nuove leve in agricoltura sono per la maggior parte istruite, computerizzate e spinte da una vera passione per quello che hanno intrapreso. Non dovrebbe essere difficile assecondare i loro progetti, creando una comunità virtuale laddove la geografia difficilmente permette il contatto diretto.
Per fortuna l’Italia può anche vantare esempi di politiche urbanistiche che hanno un impatto positivo sulla realtà agricola e la tutela del paesaggio. Uno fra tutti riguarda il mercato di Porta Palazzo a Torino, il più grande mercato all’aperto d’Europa. Copre un’area di 500.000 metri quadrati del centro storico, dove un migliaio di bancarelle offre generi alimentari freschi e altre mercanzie. Il Comune ha non solo difeso l’antico mercato da chi mirava a sostituirlo con palazzi e uffici, ma lo ha anche contornato di altri servizi per i cittadini, compresi uffici postali, e sedi dell’ASL. Perché un florido mercato all’aperto è un bene per tutti. Costituisce uno sbocco per l’agricoltura locale, offre il primo lavoro a molti cittadini immigrati, e per gli anziani del quartiere funge anche da centro sociale. E’ segno di una politica del territorio efficace la giovane bancarellista cinese che a Porta Palazzo vende verdure tipiche della gastronomia piemontese, insieme a quelle più comuni nella cucina orientale, tutte coltivate dai suoi familiari in provincia di Asti.
Non a caso, la direzione dei mercati di Torino mantiene uno scambio proficuo con i responsabili di vari importanti mercati europei: La Boqueria di Barcelona, il mercato di Lione in Francia, il Kozponti Vasarcsarnok di Budapest, il Mercato delle Spezie di Istanbul e Borough Market di Londra. Questi sono esempi di una visione urbanistica lungimirante che risalda il legame tra consumatore, ciò che mangia e il luogo di provenienza del cibo.
Allargare le conoscenze attraverso lo scambio di esperienze e vedute trova a Firenze una tradizione ben radicata. Negli anni 1788-89, un inglese di nome Arthur Young intraprese un lungo viaggio attraverso la Francia e l’Italia per documentare metodi e migliorie inerenti l’agricoltura, da egli definito “la prima delle arti”. A Firenze si congratulò per “il notevole numero di scrittori sull’argomento che si trovano in città”, e tra questi il segretario dell’Accademia dei Georgofili, Signor Tartini, il quale accompagnò l’ospite a visitare l’Orto agrario sperimentale diretto da Andrea Zucchini. Young se ne dichiarò entusiasta, trovandolo più pulito e ordinato di qualunque altro avesse visto in Italia : “La fondazione di un giardino del genere fa onore al sovrano”, dichiarò, “perché rivela un’attenzione alle cose importanti”. Auspicava, inoltre, che il Granduca concedesse al direttore dell’Orto un soggiorno in Inghilterra per allargare la propria esperienza pratica. Scambi del genere non erano nuovi. Qualche anno prima il re di Napoli aveva mandato un certo Signor Balsamo in Inghilterra per studiare l’agricoltura. Young lo commentò nei seguenti termini: “Che un professore di agricoltura, in Sicilia, venga mandato dal suo sovrano, e saggiamente, in Inghilterra per istruzione in agricoltura a me pare una pietra miliare nella storia della mente umana”.
Credo che l’encomio riguardi non tanto la scelta di destinazione quanto l’idea dello scambio. Nel suo soggiorno a Firenze, come prima a Milano e a Bologna, Young trovava nelle “conversazioni”, o incontri tra dotti e cultori della stessa materia, la discussione di vedute, esperienze e progetti che giudicava imprescindibile al progresso.
Forse le “conversazioni” fiorentine potrebbero ancora servire allo sviluppo dell’agricoltura, e quindi al benessere del paesaggio. Naturalmente, in versione adattata ai nostri tempi. Potrei immaginare una piattaforma virtuale tesa a creare comunità tra gli agricoltori, giovani e meno giovani, accomunati dal desiderio di scambio. Investo l’idea con un nome provvisorio: “AgriStorie”.
Verterebbe su una raccolta vieppiù ricca di testimonianze filmate, accessibili dal computer attraverso uno strumento tipo You Tube. Andrebbe organizzata non solo per settori, ma anche per riferimenti incrociati comuni a più settori. E siccome non è facile essere brevi e succinti, credo che ci vorrebbe un minimo di regia e di editing, con indicazioni di parametri e limiti di durata di ogni intervento. Almeno al primo livello. Per essere efficaci e attirare non solo nuove presenze ma anche visite da parte del pubblico più vasto, gli interventi dovrebbero comunicare contenuto in maniera seria, ma anche personale e divertente. Così la piattaforma creerebbe presto un proprio seguito. Dopodiché AgriStorie potrebbe anche offrire i link per vari livelli di approfondimento, sia rimandando al sito dell’azienda, sia a contributi scritti o filmati più lunghi e dettagliati. Arthur Young descrisse le “conversazioni” come “un’ottima idea”, ma confessò che preferiva lo scambio che avveniva a tavola con commensali selezionati, che era prassi comune in Inghilterra, ma più rara in Francia e in Italia. Chissà se avrebbe trovato di suo gusto un progetto tipo “AgriStorie”.
Copyright © 2000/2026
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026