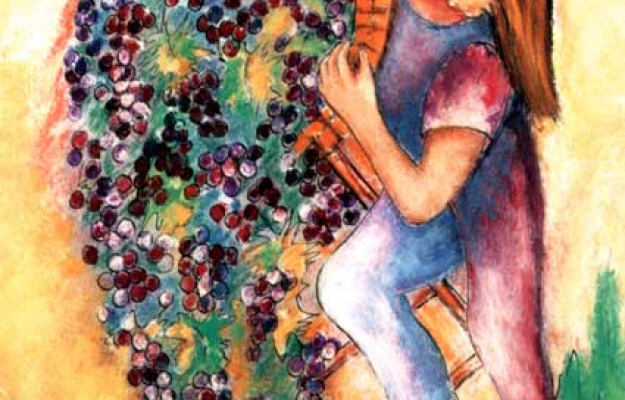Sono gli uomini che fanno grandi i vini o il vino che fa grandi gli uomini? Il quesito può sembrare paradossale, ma certo, nei secoli, quel filo che lega protagonisti del loro tempo ed enologia non è trascurabile. Storia, arti figurative, letteratura hanno costantemente avuto il vino tra i loro elementi ispiratori. Non c’è bisogno di parlare degli eccessi: troppo facile citare Baudelaire o quanti altri in una notte trascorsa con il calice in mano raccoglievano l’ispirazione della loro Musa. Più giusto occuparci del normale percorso di geni senza sregolatezze, a cui il vino contribuiva a dare una personalità meno inossidabile, più vicina all’uomo comune.
“E tu pendevi tralcio da i retici
balzi odorando florido al murmure
de’fiumi da l’alpe volgenti
ceruli in fuga spume d’argento,
quando l’aprile d’itala gloria
dal po rideva fino a lo Stelvio
e il popol latino si cinse
su l’Austria cingol di cavaliere”.
Così Carducci inizia l’ode dedicata “A una bottiglia di Valtellina del 1848”, quell’anno in cui cominciò sui campi di battaglia l’epopea che portò all’unità d’Italia. “Anno dei portenti”, dirà il poeta in uno dei suoi più famosi canti. Certo Carducci non aveva bisogno di “carburare” con un bicchiere di rosso per essere grande. Ma, pensiamoci, questo barbuto e scontroso professore toscano, terrore dell’Università di Bologna e fustigatore delle pochezze di una nazione unita da poco, ritrova i suoi “verd’anni” in un muto dialogo con un’antica bottiglia, resa ancor più magica da quella data: 1848. Il vino, sudato sui pendii che annunciano le Alpi Retiche, turbina mentre viene versato nel bicchiere e il poeta rivede in quei rossi gorghi il fumo delle fucilate, l’impeto delle cariche, il sangue che bagna i campi. Vede lo spietato generale Haynau (di lui il feldmaresciallo Radetzky diceva: “Haynau è come un buon rasoio, dopo averlo usato bisogna rimetterlo nella custodia”) far indietreggiare la sua cavalleria danubiana di fronte al coraggio di duecento volontari valtellinesi.
Ecco la fascinazione del vino, a cui nessuno (astemi a parte) resiste: “Il vino sa rivestire la più sordida stamberga di un lusso miracoloso”, scriveva Baudelaire, ma abbiamo già detto che non dobbiamo sceglierlo come spirito guida. E allora lasciamo i poeti per dedicarci a persone razionali, come il conte Camillo Benso di Cavour, complice della marchesa Giulia Falletti di Barolo nella creazione del celebre vino che continua a chiamarsi Barolo. “Vino dei re”, fu ribattezzato. Non a torto, visto che piacque anche all’ascetico re Carlo Alberto, tanto da fargli decidere, esaurite le 365 botti di cui gli aveva fatto omaggio la marchesa, di acquistare da lei la tenuta di Verduno, per non rischiare di rimanere senza.
Vino e nobiltà: la forma della coppa per lo Champagne, dicono, sia stata ispirata dal seno della marchesa di Pompadour e persino Napoleone, l’imperatore grande ma un po’ “parvenu”, con il vino aveva un rapporto d’elezione: beveva Chambertin e non se lo fece mancare anche nei momenti più difficili: nè in Russia (dove durante la ritirata ordinò venisse distribuito ai soldati più malconci), nè alla mattina di Waterloo. Intanto, durante il suo esilio all’Elba, riorganizzò la viticoltura dell’isola, entusiasmato dai bianchi del suo piccolo regno.
Ma i grandi nomi della scienza non furono da meno. Galilelo Galilei, ormai cieco, godeva nel “lasciarsi andare a qualche richiesta di Bacco”. E Galilelo, oltre a bere con gusto, fu anche vinificatore (ottimo, stando alle testimonianze del tempo) e lasciò indicazioni su come produrre buon vino. Come lui, più tardi, altri illustri scienziati si occuparono di Bacco: Kutzing e Pasteur scoprirono i segreti della fermentazione, mentre Lavoisier chiarì come l’ossigeno dell’aria fosse il fattore più importante del processo di trasformazione del mosto in vino. Il contributo degli uomini di Chiesa all’enologia fu notevolissimo. Ad esemplificarlo basta un nome: Dom Pérignon, il celebre prelato, a cui, in pratica, si deve lo Champagne. Ma sotto il profilo pubblicitario come non ricordare lo slogan “Est, Est, Est”, coniato per il vino di Montefiascone dal cameriere del vescovo di Ausburg, mandato in avanscoperta per segnare con un “Est” scritto sulla porta tutte le locande in cui il vino era davvero buono?
E l’elenco dei grandi che si occuparono in qualche modo di vino è tanto fitto da rendere impossibile omissioni. Fatta questa premessa, possiamo parlare di Emanuele Filiberto, il celeberrimo condottiero di Casa Savoia, soprannominato “Testa di ferro” per la sua determinazione, annoverandolo tra i fedelissimi del Carema. E perchè non dire del Boccaccio, che in una novella del Decamerone fa gli elogi dello Sciacchetrà, e di Gabriele D’Annunzio che, pur morigerato bevitore, parla con ammirazione dei vini delle Cinque Terre. O ancora di Ugo Foscolo, tifoso del Vermentino?
Vino e musica sono tradizionalmente buoni compagni, anche nelle massime espressioni del pentagramma. Mozart canta il Marzemino, il brindisi della verdiana “Traviata” è un riferimento assoluto, così come il vino “spumeggiante nel bicchiere scintillante” della “Cavalleria rusticana” di Mascagni. Vino che diventa “Elisir d’amore” con Donizzetti e che Rossini non cita nelle sue opere, ma di cui è appassionato cultore, in parallelo con la sua vocazione gastronomica.
E la pittura? Anche qui un solo esempio: il Pinturicchio, mentre lavorava nel duomo di Orvieto, chiedeva per contratto una disponibilità del vino che da quella città prende il nome limitata solo dalla sua capacità di berne.
Ma, per chiudere, torniamo alla serie padri della Patria e padri del vino. Ancora uno statista tra quelli che hanno legato il loro grande nome ad un grande nome dell’enologia italiana ricordiamoci di Bettino Ricasoli, il “barone di ferro”, che, governando, trovò anche il tempo di codificare il mix del Chianti: 80% di Sangiovese, 15 di Canaiolo e 5 di Malvasia.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025