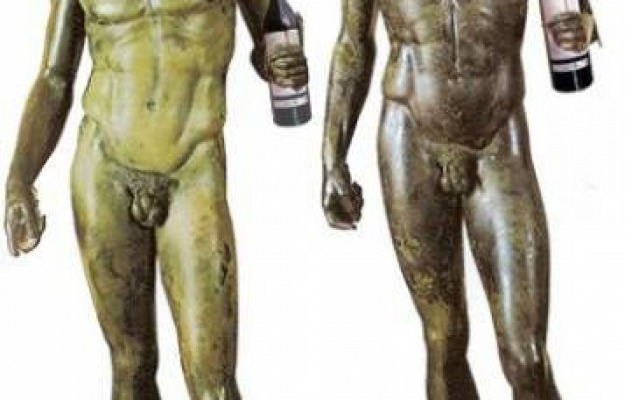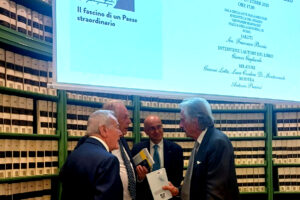È sempre stata celebre per la qualità delle sue uve e dei suoi vini, offerti perfino quale premio ai vincitori delle Olimpiadi nell’antica Grecia. Originariamente identificata con il termine Enotria “terra del vino” con cui gli antichi Greci conoscevano l’Italia. È la Calabria, una terra in cui la viticoltura da millenni è radicata nella sua stessa storia.
Purtroppo, però, di Calabria del vino si sente parlare sempre troppo poco. A torto e ragione. Se è vero, infatti, che fino a pochi anni fa si contavano sulle dita di una mano le aziende ed i vini degni di menzione, è anche vero che il patrimonio ampelografico di cui la Calabria dispone è vastissimo. Purtroppo, si tratta un patrimonio tanto ricco quanto inesplorato ed ancora poco conosciuto e valorizzato. Solo da poco, per esempio, e solo per citarne un caso tra i più eclatanti, ci si è accorti dei risultati incredibili che può dare un vitigno semisconosciuto come il Mantonico Bianco.
Molto è ancora il lavoro soprattutto di promozione che aspetta i produttori locali e, in questa direzione, l’associazione “Euvite”, che riunisce cinque aziende di diverse dimensioni, Librandi di Cirò (Crotone), Malaspina di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), Poderi Marini di San Demetrio Corone (Cosenza), Serracavallo di Bisignano (Cosenza) e Statti di Lamezia Terme (Catanzaro), pare rappresentare un’avanguardia importante. A dimostrarlo l’educational tour “nel cuore di Euvite” (14-16 giugno), che guiderà giornalisti e addetti ai lavori (riferimento: Euvite 335-6244116) in un viaggio tra le meraviglie enoiche della Calabria.
“Nell’immaginario collettivo la Calabria - sottolinea Nicodemo Librandi, presidente d’“Euvite” - non è percepita come una regione che produce vino. Si tratta di un vero e proprio paradosso. In Calabria, infatti, non solo la vite è presente da tempo immemore, ma la regione è ricca di vitigni autoctoni peculiari, studiati approfonditamente a partire dagli anni Novanta. Contiamo che tutto questo, insieme al livello qualitativo raggiunto da una buona parte dei vini regionali, emerga nel corso di questo educational tour”.
D’altra parte non bisogna mai dimenticare la storia e l’antico nome con cui era conosciuta la Calabria, esteso poi a tutta l’Italia:“Enotria”. La stessa ed attuale Cirò Marina, da cui, oggi, prende nome la più importante (almeno quanto a visibilità e fama) delle denominazioni di origine della regione, sorge nei pressi di quella che fu l’antica colonia greca di Cremissa, già allora sede di un imponente tempio dedicato a Bacco. Cremissa era a sua volta situata tra altre due città greche: Sibari e Crotone. Sibari, in particolare, era a quel tempo il fulcro del commercio del vino e pare, addirittura, che per facilitarne il carico sulle navi fossero stati costruiti dei veri e propri “enodotti”, realizzati con tubi in terracotta, dentro i quali il vino defluiva dalle colline circostanti direttamente ai punti di imbarco. Il Cirò, appunto, è proprio originario dei territori collinari di questo tratto della costa ionica che comprende Cirò, Cirò Marina, Melissa e Crucoli. Tuttora viene prodotto con quelle stesse uve che, al tempo della civiltà greca, servivano a preparare il prezioso “Cremissa”.
Questo vino veniva offerto in dono agli atleti che tornavano vittoriosi dalle Olimpiadi ed in onore di questa antica tradizione, in tempi più recenti, il Cirò è stato offerto sulle tavole di tutti gli atleti che hanno preso parte alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968, come vino ufficiale della manifestazione.
Nel recente passato la superficie coltivata a vigneto della Calabria è passata dai 50.000 ettari degli anni Cinquanta agli attuali 18.000. Ciò sia per l’abbandono spontaneo da parte dei viticoltori sia per effetto delle incentivazioni previste dai vari regolamenti della Comunità Europea.
In Calabria non esistono grandi superfici vitate, maxiaziende o cantine monumentali, le realtà produttive sono per la maggior parte di dimensioni medio-piccole. Le stesse Cantine Sociali hanno per lo più dimensione limitata. Annualmente si producono 900.000 quintali di vino, di cui l’80% rossi e 20% bianchi e esistono nel territorio 12 Doc e 13 Igt.
Sulla costa ionica e nel suo entroterra collinare sino alle prime pendici della Sila, tra Cirò e Isola di capo Rizzuto si ha la coltivazione delle uve di Gaglioppo, il vitigno alla base della produzione del celebre vino Cirò. Più a sud nei dintorni di Bianco sino alle ripide balze dell’Aspromonte viene coltivato in prevalenza il vitigno Greco. Infine nella zona di Lamezia si annovera la presenza delle tradizionali uve di Nerello Mascalese che conferiscono ai vini ivi prodotti una ben marcata tipicità.
Quella della viticultura, dunque, è ancora adesso una voce importante dell’economia locale. Negli ultimi 20 anni, però, a causa del calo delle vendite nel mercato mondiale, questa antica tradizione ha inesorabilmente subito dei duri colpi, sino ad entrare in una preoccupante fase di contraddittorietà. Se da un lato, infatti, sono emerse e si sono consolidate realtà calabresi sempre più importanti, dal Savuto al Lametino sino all’area del Cirò, dall’altro lato la realtà vitivinicola regionale ha vissuto un grave periodo di crisi, rischiando l’impoverimento generale.
Focus - Una vera e propria “reliquia” enologica: il Moscato di Saracena
Il Moscato di Saracena è un vino passito dolce, prodotto con uve Moscato Bianco, appassite ed aggiunte a un mosto cotto ottenuto da uve Guarnaccia e Malvasia Bianca. SI tratta di un’antica vinificazione in cui la concentrazione del mosto viene ottenuta tradizionalmente non con l’appassimento delle uve, ma per riscaldamento diretto del mosto, la “bollitura”, un procedimento che non trova spazio nella legislatura vigente anche dei cosiddetti “vini speciali”e che ha ostacolato il cammino di questo vino verso la denominazione d’origine. A tutelare la grandezza di questo prodotto ci ha pensato Slow Food (che a Saracena ha aperto un presidio) e la famiglia Viola, produttori tenaci che hanno mantenuto sempre viva questa particolare tradizione enologica calabrese.
Focus - I vitigni di antica coltivazione della Calabria
Greco di Bianco: E’ il vitigno tipico a bacca bianca della fascia costiera reggina sul versante ionico nel territorio del comune di Bianco, da cui prende il nome, e il comune limitrofo di Casignana, sulla Costa dei gelsomini. Il Greco di Bianco è ritenuto il vino più antico d’Italia insieme al Moscato di Siracusa. La vite dalla quale si ricava il Greco di Bianco ha origini molto remote: si ritiene che il primo tralcio sia arrivato in Calabria, già nel VII secolo a.C., quando i Greci sbarcarono presso il promontorio Zefirio (oggi Capo Bruzzano).
Montonico della Calabria: le origini di questo vitigno a bacca bianca sono tuttora sconosciute, benché sia coltivato in Calabria da tempo immemore e come altri vitigni della regione potrebbe avere origini greche. E’ presente negli areali di Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro. Non va confuso con il suo omonimo presente in molte regioni dell’Italia centrale, soprattutto sul versante adriatico, peraltro sempre meno coltivato. importanza.
Gaglioppo: Vitigno a bacca nera di probabile origine greca e diffusosi prevalentemente nelle province calabresi di Cosenza e Catanzaro, ma sotto altri sinonimi anche nelle Marche, in Umbria, Abruzzo, Campania e nella provincia di Messina. Ha molte analogie genetiche con il Frappato. I principali sinonimi sono: Galloppo, Gaioppo, Gaglioppa nera, Gaglioppo nero, Galloppolo, Magliocco tondo (che non va confuso con il Magliocco ovale), Maghioccu nero, Mantonico nero, Aglianico di Cassano, Arvino, Galloffa, Lacrima di Cosenza, Lacrima nera, Uva Navarra. In Calabria è il vitigno rosso più coltivato, specialmente sulle colline tra il litorale e la Sila.
Pecorello Bianco: Vera e propria reliquia, questo vitigno a bacca bianca è sporadicamente presente in alcuni vigneti della zona del Savuto, dove viene impropriamente confuso con il Pecorino, vitigno notevolmente diffuso nel Centro Italia, a causa di alcune somiglianze morfologiche con esso.
Guarnaccia: il Guarnaccia è un vitigno a bacca rossa di cui non si ha nessuna notizia certa, con un nome che fornisce più confusione che certezze, visto che porta a pensare ad un sottotipo della Grenache francese. Ma nessun test del Dna ha confermato questa ipotesi e anche le somiglianze non sembrano talmente coincidenti da far presupporre questa origine. Nessun documento storico riesce a chiarire la provenienza della Guarnaccia, e si può anche ritenere che come molti vitigni specie nel meridione d’Italia possa essere una delle tante uve importate dalla Grecia al tempo della colonizzazione ellenica nel VII secolo a. C.
Greco Nero: il Greco Nero fa parte della numerosa famiglia dei vitigni cosiddetti “Greci”, la cui origine e diffusione, per quanto incerta, è ad essi comune in quanto tutti sembrano derivare dai vitigni importati dai coloni ellenici, fondatori della Magna Grecia. Il Greco Nero è coltivato prevalentemente in Calabria, nelle provincie di Catanzaro e Crotone, dove è conosciuto come Grecu Niuru o e Maglioccone (nella zona di Bivongi). Era erroneamente ritenuto sinonimo di Marcigliana o Marsigliana coltivato nella provincia di Catanzaro, ed è stato confuso anche con l’Aleatico e il Verdicchio nero.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025