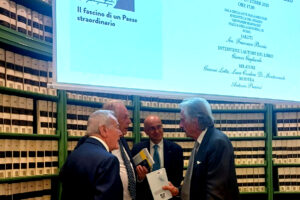Tra pianure, colline e montagne, ha una superficie di 1.098 kmq, il 30% circa iscritto alla zona di produzione a denominazione di origine, con 13.600 ettari a vigneto (il 13% dell’intera area), di cui quasi l’80% produce uva Doc; è la terza area europea per il Pinot Nero per estensione vitata, dopo la Borgogna e la Champagne, citata per queste sue caratteristiche già da greci e romani, ricca di risorse storiche, artistiche, paesaggistiche e di una buona cucina (88 i ristoranti presenti nelle principali guide di settore): ecco l’Oltrepò Pavese fotografato dallo studio Città del Vino/Censis Servizi sulle “Opportunità di sviluppo del settore enoturistico nell’Oltrepò Pavese”. Territorio che, emerge dallo studio, ha la “stoffa del campione” ed i numeri dei grandi terroir meta di enoturismo in Italia, ma dove, dei 27 produttori, per una produzione di 12.486.000 bottiglie, oggetto dell’indagine (presenti sulla guida del Gambero Rosso, utilizzata come riferimento), solo il 27% ha avviato campagne di promozione - per problemi di budget nella maggioranza dei casi (47%), mentre, da parte loro i Comuni utilizzano soprattutto le risorse di bilancio (73,3%) - con il risultato che il 66% dei visitatori è “di casa” ed arriva dalla Lombardia, grazie al “passaparola” (34%), per acquistare vino in azienda (27%) e trascorrendo, dunque, sul territorio, un solo giorno nell’84% dei casi.
Secondo lo studio Città del Vino/Censis Servizi - che ogni anno monitorano lo stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia attraverso l’“Osservatorio sul Turismo del Vino in Italia”, nell’ultima edizione del quale la provincia di Pavia è alla posizione n. 13 nel ranking enogastronomico italiano - l’Oltrepò Pavese ha dunque gli ingredienti per “confezionare” una buona offerta enoturistica, ma occorre puntare di più sul rafforzamento della matrice identitaria per aumentare l’appeal di questa storica area vitivinicola.
Il sistema produttivo pavese punta prevalentemente sul prodotto e non sulla sua filiera e questo fa sì che l’Oltrepò sia ancora visto come un territorio in cui si produce vino (con quantità e qualità notevoli) ma che non attrae un turismo esigente, se si escludono i “gitanti della domenica”: i dati sui flussi di provenienza ed i tempi medi di permanenza confermano, infatti, una tendenza al “mordi e fuggi” per lo più di visitatori delle altre province lombarde, Milano su tutte. La mancanza di una forte matrice identitaria (a partire dal vino e poi lungo le articolazioni dell’offerta turistica e gastronomica) si frappone ancora come un ostacolo molto insidioso tra le potenzialità del territorio e le sue aspirazioni a farsi meta di punta per chi si muove alla ricerca di buon vino, di cantine, enoteche e poi ancora di storie, emozioni, suggestioni, accoglienza, esperienze. Manca inoltre, secondo lo studio, e non è fattore secondario, un vero e proprio polo di attrazione turistica, un magnete in grado di esercitare una forte richiamo, necessario (al netto di pochissime mete celebri) a qualsiasi territorio che intenda puntare sull’enoturismo, in un ottica - ormai largamente sperimentata dai cultori del marketing a cominciare dalla Napa Valley - dell’“how to do today”.
“L’allocazione delle aziende vitivinicole nelle graduatorie nazionali, redatte sulla base delle posizioni assunte nelle principali guide enologiche, dimostra il grande incremento qualitativo dei vini qui prodotti, assurti in alcuni casi a livelli spendibili nel panorama internazionale - sottolinea Alberto Vercesi, docente di Viticoltura Università Cattolica di Piacenza, coordinatore regionale della Lombardia delle Città del Vino - purtroppo la zona soffre la mancanza più grave, forse “madre” degli altri aspetti problematici, nella difficoltà di un reale e convinto accordo fra gli attori, soprattutto le aziende vitivinicole, che non sono ancora riusciti a definire una chiara strategia su “cosa e come puntare”. Questo però è un momento importante, perché se, da un lato, è necessario “mettere bene il territorio in etichetta” evitando per quanto possibile di operare vendite di fatto anonime e agendo su poche varietà di vini sui quali concentrare le azioni promozionali, dall’altro la valorizzazione del territorio con un’attenta politica enoturistica potrebbe essere il modo per promuoverlo, di far sapere che è un “territorio con l’accento” come qualcuno, ricoprendo un termine proposto nel recente passato, commenta Vercesi.
Del resto, nonostante la pesante congiuntura economica l’enoturismo italiano (e non solo) sembra poter offrire ancora delle buone occasioni di sviluppo territoriale, ma solo se le scelte strategiche saranno condivise da tutti gli attori del sistema (amministratori pubblici, produttori, soggetti del terziario, ecc.) e rese funzionali in relazione a target turistici e modelli da perseguire chiari e sostenibili.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025