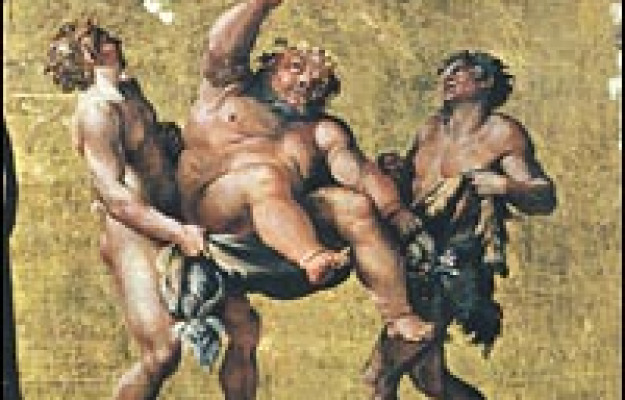La relazione tra arte ed ebbrezza è nota da sempre, tanto che la figura dello scrittore ispirato dal vino è ormai un luogo comune e quasi banale. Mancava però un’analisi seria ed approfondita sul ruolo svolto dalla bevanda cara a Bacco nella vita e nelle opere degli scrittori moderni: Pietro Gibellini, docente di letteratura italiana all'Università di Venezia e uno dei massimi studiosi del nostro Paese, è andato a curiosare nei libri e nella biografia dei più importanti autori del Settecento ed Ottocento. Il risultato è “Il calamaio di Dioniso” (Garzanti, 29.000 lire: un libro che WineNews consiglia come regalo da fare a tutti gli appassionati di vino), un viaggio lungo due secoli di letteratura seguendo il filo rosso del vino: i toni volutamente leggeri e la ricchezza di citazioni ne fanno un’antologia davvero originale. Gibellini ha fatto alcune scoperte interessanti, cogliendo la natura ambigua del vino nell’immaginario di scrittori famosi ed autori minori: ora nettare divino ora liquore satanico, capace di consolare dal dolore e dalle angosce ma anche di scatenare torbide passioni, considerato una via di fuga dal mondo ma anche un mezzo per godere appieno l’esistenza. Gibellini ricostruisce sia il rapporto che gli scrittori avevano con il vino nella vita quotidiana, sia la sua presenza nelle loro opere, da un punto di vista concreto e simbolico. L'atteggiamento cambia da epoca ad epoca, e non mancano le sorprese. Si inizia con il Parini, che nei vini pregiati graditi al “giovin signore” del poema satirico “Il Giorno” vede l'emblema del vizio e del privilegio. Bordeaux e Chianti, Xerès e Tokaj: bottiglie di lusso che l’autore condanna per il piacere smodato che suscitano, ma tra le righe si legge anche una sottile fascinazione. Con gli Illuministi si passa alla contrapposizione caffè-osteria: Goldoni ed i fratelli Verri al vino preferiscono il caffè, come luogo oltre che come bevanda capace di stimolare la ragione senza offuscarla. Ci si ritrova all’osteria con i brindisi di Porta e Belli, che in questi ritrovi popolari e fumosi sbeffeggiano il Palazzo, facendo di ogni brindisi un “componimento” politico.
Si approda a Leopardi, e si scopre che proprio lui, moralista cantore dell’infelicità, non era affatto astemio (apprezzava in particolare i vini delle Marche), ma anzi dotato di una forte vena dionisiaca. Leopardi leva il bicchiere contro la triste ragione, affermando che il vino acuisce la lucidità della mente, e quando produce sopore ha il pregio di allontanare dall’uomo la coscienza della propria “finitezza”. Il Manzoni narra della crescita morale di Renzo nei “Promessi Sposi” attraverso la sua liberazione dagli eccessi del bere, e Verga ci presenta il vino da una parte come ben di Dio dei poveri (pane e vino hanno un’importanza vitale per gli umili eroi dei “Malavoglia”) ma anche come paradiso artificiale e trappola senza via d'uscita. Carducci, che sceglieva Chianti e Valtellina, considera il vino una schietta e salutare risorsa: dal bicchiere colmo attinge vigore fisico e sdegno civile, e nel suo brindisi è racchiuso “amor di patria” e “amor di grappolo”. Carducci fa del vino un uso politico, ma lo considera anche bevanda che riscalda l’amore, attenua la malinconia dell’autunno, rallegra la vita che se ne va. Un rapporto più controverso con Bacco ce l’ha Giovanni Pascoli: si dice che la sua cantina fosse ben fornita e molto frequentata, ma nelle sue opere si parla perlopiù di viti, grappoli e gemme, senza entrare nel merito dell’atto stesso del bere. Ci si chiede allora se in lui non vi sia la volontà, conscia o inconscia, di nascondere un vizio. Ma la sorpresa più grande la riserva Gabriele D’Annunzio, che della ricerca del piacere aveva fatto la sua filosofia di vita: proprio lui si rivela completamente astemio. Certo i vizi non gli mancavano, ma l’alcool non era tra questi. Ai personaggi eleganti e mondani de “Il Piacere” fa bere champagne, tè e cognac (forse considerati più raffinati del vino), e quando fa riferimento nelle sue poesie alla bevanda di Bacco sembra in realtà alludere ad altri piaceri sensuali. Insomma, D’Annunzio si inebriava senz’alcool, e pare che l’unica volta in cui si decise a bere del Bordeaux lo abbia fatto solo dietro consiglio del medico…
Eleonora Ciolfi
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025