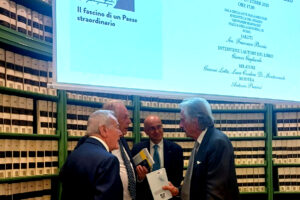Mai come in questo periodo storico, forse, le dinamiche economiche stanno mettendo il vino italiano di fronte alla necessità di una riflessione profonda sui propri punti di forza e di debolezza, per valorizzare gli uni, correggere gli altri e capire meglio cosa fare in futuro. Noi abbiamo chiesto di analizzarli a chi, nella doppia veste di docente di Economia e gestione delle imprese dell’Università di Foggia e di imprenditore del vino di successo, conosce a fondo la materia: è Piero Mastroberardino, ex presdiente di Federvini (Confindustria), alla guida della omonima cantina campana, ad Atripalda (Avellino) tra le realtà più importanti del Sud Italia e non solo.
Da imprenditore e docente di economia, quali sono secondo lei in questa fase storica i punti di forza e quelli di debolezza del sistema vino italiano?
“Tra i punti di forza, in prima linea porrei sempre il potenziale distintivo dei terroir che compongono il mosaico dell’Italia del vino, in uno con la importante avanzata dei vitigni tradizionali, unici e irripetibili in contesti ambientali diversi. Da questi scaturiscono spiccata personalità e carattere dei vini, nonché storie da raccontare, di grande fascino per il pubblico dei consumatori. Ma bisogna essere attenti a preservare questi elementi, poiché la loro difendibilità discende dalla competitività in senso più ampio del nostro sistema di offerta, la cui organizzazione e struttura di filiera è molto complessa e delicata da governare. Punterei poi sul notevole standard qualitativo maturato dalle produzioni italiane nei diversi segmenti nel corso degli anni. La nostra offerta negli ultimi decenni è riuscita a collocarsi in modo coerente nei diversi segmenti, centrando le aspettative di rapporto prezzo/qualità dei consumatori. Ma anche in questo caso non si può prescindere dal problema di una lenta, graduale erosione del grado di competitività dell’offerta per effetto dei radicali cambiamenti in atto in questi ultimi anni.
Tra i punti di debolezza, invece, in primo luogo citerei l’eccessivo peso burocratico che accompagna da troppo tempo il nostro settore. Conseguono costi elevati di funzionamento della filiera, che impattano sugli equilibri economici e sulla competitività dell’offerta italiana sui mercati del mondo. Questo problema tende ad accentuarsi per effetto della grave congiuntura economica, che sta provocando una forte spinta verso la razionalizzazione estrema dei processi d’acquisto e di consumo. La componente emozionale si assottiglia e si registra un tendenziale “downgrading” dei prezzi di riferimento dei classici segmenti di mercato. In un simile scenario i sistemi di offerta più flessibili sono in grado di fornire risposte più rapide ed efficaci, di recuperare risorse e reimmetterle sui mercati. Il nostro Paese non è tra quelli: la filiera è piuttosto ingessata e lenta ad adottare contromisure. E non sempre è semplice posizionare prodotti in segmenti più elevati, nell’intento di recuperare il differenziale di risorse che questo trend assorbe. Un altro limite strutturale - spiega Mastroberardino - concerne la scarsa visione prospettica di sistema, dovuta a una voce troppo marginale lasciata alle imprese del vino nel dibattito settoriale. Per dirla in soldoni, un po’ come nel calcio, di vino nel nostro Paese parlano tutti, e si esprimono ovviamente non in veste di amatori, ma da titolati commissari tecnici. Eppure sono pochi, tra quelli che ne parlano tanto, coloro che conoscono e si confrontano quotidianamente con i problemi concreti del vino. E ancora, tra le dolenti note, non si può trascurare la storica assenza della mano istituzionale sul piano della promozione. Quando risorse vi sono state allocate, l’efficacia della spesa è stata purtroppo insufficiente. E spesso si è assistito a scaramucce tra diverse componenti istituzionali, impegnate a rivendicare il primato nel ruolo di stratega della comunicazione, trascurando le imprese presenti su quei mercati, con le quali quei progetti il più delle volte non sono stati condivisi in fase progettuale. È un problema annoso, che relega il nostro sistema di offerta troppo spesso a un ruolo di follower rispetto a sistemi-paese in cui pubblico e privato sviluppano rilevanti sinergie nell’impiego delle risorse. L’Italia del vino, per la sua storia, le radici culturali, ma anche per la grande modernità stilistica dei prodotti, non lo merita. Nonostante tutto questo, il settore mostra ancora una notevole solidità e capacità di resistenza ai rigori di questa congiuntura. Il business del vino ha resistito fino ad ora meglio di altri settori alle tensioni economico-finanziarie. Si dimostra solido e credibile, nonostante tutto. Ed è per questo che non bisogna eccedere nel ritenere che tutto sia sostenibile”.
Il comparto del vino è quello che pesa di più sul bilancio attivo della bilancia commerciale agroalimentare italiana. Segno che in qualche modo il settore continua a marciare meglio di altri. Il mondo della finanza lo capisce? C’è un miglioramento nel rapporto con il credito rispetto agli ultimi anni o no?
“Il mondo del vino non è molto interessante per quello della finanza, almeno in una prospettiva equity, per alcune fondamentali ragioni: la eccessiva frammentazione dell’offerta e il connesso problema dimensionale delle imprese; la difficoltà di costituire significative concentrazioni di offerta mantenendo elevata l’immagine di marca, con effetti di erosione di valore e rischi di defocalizzazione del posizionamento; il peso degli investimenti agricoli, che incide sui rendimenti economici; la connessa rigidità strutturale delle aziende: poiché i brand ad immagine di più elevata qualità non possono prescindere dalla cura in via diretta delle fasi a monte della filiera, queste scelte impattano sulla struttura economico-patrimoniale, elevando la soglia di rigidità dei bilanci, il che in periodi di consumi rarefatti certo non aiuta. Le esperienze di questi ultimi anni hanno prodotto una varietà di effetti, che meriterebbero diversa attenzione per poter imbastire un approccio finanziario di carattere più strutturale. Riflessione più ampia interessa il ricorso agli strumenti creditizi più tradizionali. Qui la finanza si trova di fronte tutti i fattori di criticità che caratterizzano il sistema imprenditoriale italiano: polverizzazione, problemi di capitalizzazione e di liquidabilità degli asset, tensioni gestionali tipiche del family business, solo per citarne alcuni. E allora anche su questo versante c’è da procedere con cautela. Tuttavia in questa fase storica la spiccata propensione all’export ha costituito un importante baluardo che ha contribuito a far assorbire meglio che in altri settori la violenta crisi economica. Questo ha in parte attenuato le criticità sopra accennate, nei rapporti col sistema del credito”.
L’export sembra ormai una strada obbligata. Ma non è pericolosa la rassegnazione sul declino del mercato italiano che, comunque, rimane ancora il mercato n. 1 per il nostro vino?
“È sicuramente pericolosa. Il mercato italiano non può essere abbandonato al declino, anche perché la concentrazione di eno-appassionati e degustatori esperti è ormai così elevata da richiedere massima considerazione. Il nostro Paese è in una transizione pesante, ma il vino di pregio conserverà il suo spazio. La struttura dei consumi va modificandosi, e così i luoghi e le occasioni. Stiamo affrontando un problema di segmentazione e riposizionamento della nostra stessa offerta entro i nostri confini e, considerati i volumi interni di consumo, è questa forse la sfida più impegnativa”.
Se Lei oggi, con un tocco di bacchetta magica, potesse fare una riforma radicale per il vino italiano, quale sarebbe?
“L’alleggerimento radicale degli aspetti burocratici e la ricanalizzazione di tutte le risorse risparmiate sul versante pubblico e privato nella promozione del sistema vino italiano nel mondo. Con grande senso di orgoglio per gli straordinari valori che il nostro mondo è in grado di esprimere. E senza lasciarsi abbindolare dalla solita, vecchia, strumentale caccia alle streghe ...”
In tanti parlano di una riscossa del vino del Sud Italia, e Mastroberardino è sicuramente uno dei nomi più importanti di questo successo. Ma quale è il segreto non solo della sua cantina, ma della crescita della vitivinicoltura del meridione?
“Sono vini molto veri, sinceri e schietti, e così devono riuscire ad esprimersi. Si beve la terra, e l’aria. Si respirano gli umori e i caratteri della nostra gente. Qualche giorno fa riflettevo sul fatto che il nostro Radici Taurasi ormai da oltre un decennio continua, senza interruzione, a raccogliere i più alti riconoscimenti della critica. E mi piace pensare che non sia soltanto un caso”.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025