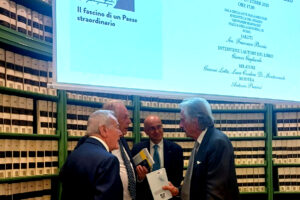A dettare un radicale cambiamento nella coltivazione della vite, pressoché uguale a se stessa almeno da un millennio, fu la fillossera. Un insetto spietato, originario del Nord America, che arrivato in Europa nella seconda metà dell’Ottocento, attaccò le radici delle viti europee, portando in breve tempo alla morte di quasi tutto il patrimonio viticolo del continente, allora, allevato a piede franco. E se il disastro della fillossera impose un così decisivo cambio di prospettiva alla viticoltura europea, con l’introduzione della vite americana (immune alla fillossera) come apparato radicale del nesto fruttifero, dal Cabernet Sauvignon al Sangiovese, segnando definitivamente la fine dell’esistenza autonoma della vite europea, ancora dalle radici della vite, dal suo portainnesto, potrebbe avviarsi un’altra rivoluzione epocale nella viticoltura europea e non solo.
Ne è convinto il professore di viticoltura Attilio Scienza, dell’Università di Milano, coordinatore del progetto “Ager Serres” (http://users.unimi.it/serres/dca---unito-.html), che vede coinvolte l’Università di Torino, la Cattolica di Piacenza e il Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano Veneto: “si tratta di un progetto triennale che, grazie alla moderna biologia molecolare, fornirà le indicazioni sui cosiddetti marcatori molecolari dei portinnesti in grado di accelerare i risultati degli incroci, così da abbreviare di molto la costituzione di individui adatti alla moltiplicazione ed in più permettendo progressivamente di raccogliere in un unico portinnesto tutti quegli elementi in grado di fronteggiare le varie sollecitazioni ambientali e chimiche a cui è soggetto l’apparato radicale di una vite”.
Un tema quello dello studio sui portinnesti, purtroppo sostanzialmente trascurato, ma che riveste un’importanza fondamentale, visto che “il cervello di una vite, dove avvengono tutte le regolazioni del suo funzionamento fisiologico complessivo - sottolinea Scienza - è proprio l’apparato radicale. In questo senso, il nostro è un progetto unico al mondo, perché siamo i soli che abbiamo rivolto la nostra attenzione verso questa parte della vite “misteriosa”, prima di tutto perché si trova in un ambiente non visibile”.
Dopo che l’Europa viticola fu quasi completamente devastata dalla fillossera, la soluzione del portainnesto su cui mettere il nesto fruttifero diventò l’unica strada per cercare di mantenere in vita la viticoltura europea. Venne svolto un grande lavoro in pochi anni, grosso modo dalla fine dell’Ottocento agli inizi del Novecento, che si concentrò proprio sull’apparato radicale della vite. Ma, “risolta la calamità più grave attraverso l’introduzione del portainnesto in viticoltura - prosegue il Scienza - la viticoltura europea aveva praticamente scongiurato il pericolo più grande e, ad eccezione di alcuni incroci, Paulsen, Ruggeri, Richter, che portarono all’applicazione di portinnesti, per esempio, più resistenti alla siccità, il lavoro di ricerca su questo essenziale elemento della vite fu interrotto, per riprendere, ma solo sporadicamente, negli anni Cinquanta del Novecento a Bordeaux, con nuovi portinnesti quali Fercal e Gravesac”.
Tuttavia, la scossa generata dalla fillossera aveva creato un notevole patrimonio di conoscenze e di portinnesti, almeno alcune centinaia, con caratteristiche diverse e attitudini diverse ma che continua a non poter essere sfruttato adeguatamente “visto che 4 portinnesti, 5bb, So4, 140 Ruggeri e 110 Pualsen, formano il 90% dei portinnesti più usati al mondo - spiega Scienza - generando una carenza di opzioni che non ha aiutato uno sviluppo qualitativo ancora più importante”.
Nel frattempo la viticoltura ha conquistato altre zone di produzione, dall’Australia al Cile, portando nuove problematiche anche per i portinnesti, visto che spesso i terreni di quelle zone sono diversissimi da quelli europei, per composizione chimica e interazione climatica. E proprio il clima, con i suoi cambiamenti, ha portato drammaticamente alla ribalta ulteriori criticità, prima fra tutti la resistenza alla siccità dei protinnesti. E sotto questo impulso si è avviato “Ager Serres” che sta omologando quattro nuovi portainnesto , “serie M”, grazie alle moderne tecniche di biologia molecolare, particolarmente validi per fronteggiare lo stress idrico. Ma questo progetto non si limita soltanto a questo - prosegue il professor Scienza - perché nella ricerca è compreso l’obbiettivo di trovare i marcatori molecolari, cioè i tratti di Dna responsabili delle resistenze e delle tolleranze alle varie criticità ambientali e chimiche, siccità, salinità del terreno e così via, individuando i soggetti più adatti alla propagazione in tempi molto più rapidi di quelli permessi dalle tradizionali tecniche di incrocio. Il che - continua Scienza - permetterà uno schema di miglioramento genetico della “piramidizzazione” dei portinnesti, con l’obbiettivo finale di portare in un solo individuo tutti gli elementi di resistenza ambientale e chimica, utilizzando nell’incrocio diversi genitori, ciascuno dei quali in possesso di un fattore particolare di resistenza. Creando alla fine - conclude Scienza - un “portainnesto universale”, cioè un solo individuo in grado di resistere a tutte le criticità da quelle chimiche dei terreni a quelle climatiche, in prima battuta , la siccità”.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025