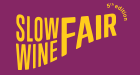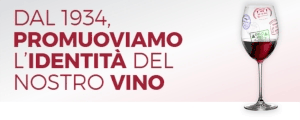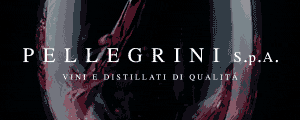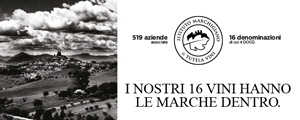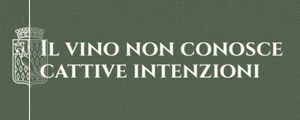L’agricoltura e la cultura contadina da sempre trovano il loro posto nelle opere dei grandi artisti, che le immortalano su tela a testimonianza del passato su cui si regge il nostro presente. A distanza di anni, strumenti e oggetti d’uso quotidiano acquistano un significato profondo e inedito, riempiendosi di una magia del tutto nuova che ci porta a riscoprire la bellezza nascosta della civiltà materiale di una volta. Un esempio è rappresentato dai cesti di rami intrecciati, leggeri e resistenti, utilizzati quotidianamente per la raccolta dell’uva durante la vendemmia o per il trasporto dei viveri nei campi (ma non solo), protagonisti nelle opere di grandi maestri, tra cui Caravaggio, Vincenzo Campi e Renato Guttuso (nonostante in passato bellezza e raffinatezza avessero minore rilievo rispetto all’efficacia degli oggetti) come racconta la mostra “Il cesto in cornice. L’Arte della cesteria nell’Alte Valle Staffora” a Brallo di Pregola, a Pavia (ex scuole, visitabile fino al 31 di agosto). Lo scopo della mostra, organizzata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese e quella della Città Metropolitana di Milano) in collaborazione con l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura è parte di un progetto più ampio che mira a valorizzare e salvare l’arte cestiera e, con essa, la vasta gamma di tecniche che vengono tramandate per via orale di generazione in generazione.
I cesti esposti “escono” dai dipinti, riprodotti fedelmente in ogni loro particolare e, per l’occasione, si fanno testimoni della dura vita di fatica, passata ad inseguire l’autosufficienza dai nostri predecessori in un’era nuova, fatta di preoccupazioni profondamente diverse: tra agricoltura biologica, nomadismo digitale e smart working. Che si tratti delle grandi gerle che si trasportavano sulla schiena e che si riempivano, in periodo di vendemmia, di acini di uva, oppure di fieno a nutrimento delle stalle, o di quelli realizzati per la soma, più piccoli che, indossati a tracolla, permettevano di trasportare strumenti di varia natura, fili da cucito o tabacco, od anche di quelli utilizzati per l’essiccazione di frutti, bacche ed erbe, comunque, è il quotidiano che si fa arte. Tra i tantissimi esempi, è il caso anche de “Le Spigolatrici” di Jean-François Millet, nel quale è raffigurata una tipica scena agreste nella Francia di metà Ottocento, o dei moltissimi esempi di “quadri-trappola”, tra tavole imbandite e pietrificate nel tempo e “colazioni eterne”, del maestro Daniel Spoerri, scomparso a fine 2024, e visibili nel suo giardino a Seggiano.
L’arte, l’agricoltura ed i frutti del suo lavoro, quindi, tornano ancora una volta protagonisti, solidificando il rapporto tra coltura e cultura che abbiamo trattato più volte anche su WineNews: dall’ampia presenza del vino in letteratura, per esempio, a partire da autori classici sino ad arrivare a quelli più contemporanei, fino alla presenza della vita agreste in forme d’arte “più giovani” come la street art con i murales degli artisti Atterrop e Yash in Puglia, insomma, sono innumerevoli le testimonianze di come sia possibile emozionarsi e stupirsi guardando, attraverso lo sguardo sapiente ed il savoir faire degli artisti, la straordinaria quotidianità del campo, del vino e della tavola da una nuova prospettiva.
Una posizione che trova d’accordo anche il World Heritage Committee dell’Onu che, nel 2019, ha iscritto le Colline di Conegliano Valdobbiadene nell’elenco dei beni del Patrimonio dell’Umanità. Un territorio ed un'opera d'arte, quindi, grazie all’operato degli artisti: vignaioli, enologi e contadini, che, con cura, amore e rispetto del territorio, quotidianamente hanno lavorato e lavorano disegnando la meraviglia di questo straordinario paesaggio culturale evolutivo, il cui risultato visibile, cioè, è dato dall’interazione uomo-ambiente, vitale ed in continua evoluzione (natura che condivide con gli altri 9 territori del vino iscritti nella sua stessa categoria di “paesaggio culturale”, ovvero: Alto Douro e Pico Island in Portogallo, Tokaj in Ungheria, Lavaux in Svizzera, Langhe Roero e Monferrato in Italia, la Champagne, la Borgogna e Saint-Émilion in Francia e Wachau in Austria). E trasformando la tradizione del territorio “in un paradigma di qualità e bellezza - ha commentato l’assessore veneto all’agricoltura, Federico Caner, in occasione della candidatura delle Colline del Prosecco a Città Italiana del Vino 2026 - in un luogo che è simbolo mondiale di qualità e bellezza ed in cui la cultura del vino si intreccia con la storia, l’arte, il paesaggio ed i viticoltori”: custodi del saper fare del territorio.
Copyright © 2000/2026
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026