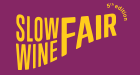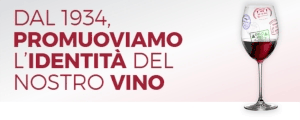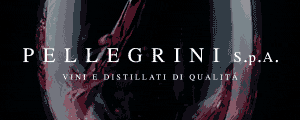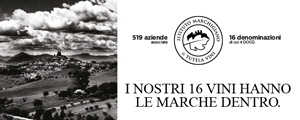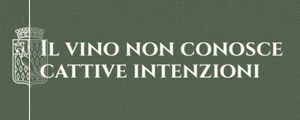“La “Giornata dei Defunti”, il 2 novembre, nella tradizione italiana, segue un doppio binario: da un lato la visita ai cimiteri, l’accensione di lumini, la preghiera; dall’altro, un insieme ricco di usanze alimentari che rivelano il rapporto complesso e ritualizzato tra vivi e morti. Il cibo non è solo nutrimento: è ponte, segno, memoria, perché notoriamente a tavola le distanze si annullano”. Parole del professor Gianni Moriani, storico della cucina e del paesaggio agrario italiani, con il quale ci confrontiamo spesso sul valore e la bellezza dei territori del vino e del cibo italiani, e del quale riceviamo e volentieri pubblichiamo l’intervento “A tavola, memoria e simboli, nel giorno dei morti” (nella foto, il “Törggelen”, tradizione culinaria e festiva autunnale dell’Alto Adige, nata in Valle Isarco, che si celebra degustando il vino nuovo e le caldarroste, con i piatti tradizionali, in un’atmosfera contadina e immersi nella bellezza dello spettacolo del foliage, che già il professor Moriani ci aveva descritto, ndr).
“Nel corso della notte tra l’1 e il 2 novembre, secondo molte tradizioni popolari, le anime dei defunti ritornano nella casa dei vivi. Si imbandisce la tavola o si lascia un posto aggiuntivo; si lascia acqua fresca o un vaso per il ritorno. Mangiare e bere allora diventano atti simbolici: offrire un bicchiere di vino, un piatto caldo, un dolce, significa accogliere, riconoscere. In alcune regioni il cibo preparato per i morti viene anche consumato dai vivi.
La varietà regionale è ampia, ma si osservano alcuni tratti comuni: l’uso dell’autunno (castagne, zucca, frutta secca), l’uso di dolci semplici, e l’uso di ingredienti della “cucina povera” come legumi: fave secche, ceci. Ad esempio in Liguria si preparava lo “zemin di ceci e bietole”, oppure fave secche; in Lombardia e nelle zone contadine il dolce chiamato Pan dei Morti - a base di biscotti secchi, frutta secca, cacao, spezie - era messo sul davanzale con un vaso d’acqua per le anime. I dolci tipici comprendono: le Fave dei Morti (nell’Italia Nord-orientale: sono biscotti/morbidini colorati) e le Ossa dei Morti (in Sicilia e altrove: sono biscotti dalla forma di ossa). Il bere entra anch’esso nel rituale: un bicchiere di vino fuori dalla porta o accanto alla tavola serviva come offerta alle anime in visita.
Le pratiche alimentari nel giorno dei morti costituiscono un vero e proprio rituale di mediazione tra vivi e defunti. Vi sono in esse almeno tre aspetti significativi. Recupero del legame: il cibo funge da medium relazionale. Imbandire la tavola, lasciare un posto in più od offrire un piatto significa riconoscere che la morte non ha annullato il rapporto. Il rito alimentare consente un colloquio simbolico con chi non c’è più. Valenza esistenziale e morale: nelle società contadine, la condivisione con i poveri era diffusamente parte della tradizione. Il cibo per i morti si estendeva anche al sostegno ai vivi. Questo fa emergere la dimensione sociale del rito: ricordare i defunti implica prendersi cura dei vivi e del legame comunitario. Simbolismo nutrizionale e stagionale: i legumi secchi, la frutta secca, la zucca, i dessert semplici rispondono a due esigenze: da un lato l’economia della “cucina povera”, dall’altro un richiamo all’autunno e al passaggio (dal vivo al morto, dal raccolto alla terra). Così, vino, acqua e dolciumi diventano segni di ospitalità per le anime vaganti.
Con la modernizzazione, molte di queste usanze si sono attenuate o trasformate. Il ruolo simbolico rimane, ma la ritualità si fa più privata o commerciale: i dolci dei morti sono oggi presenti in pasticceria ed è quasi del tutto sparita la tavola preparata per gli spiriti. Inoltre, l’irruzione di festività allogene (come Halloween) ha fatto sì che alcune tradizioni originarie vengano messe in disparte o reinterpretate. Sta però emergendo una sensibilità nuova che riscopre le pratiche tradizionali come ricerca di senso e costruzione/ricostruzione di comunità”.
Copyright © 2000/2026
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026