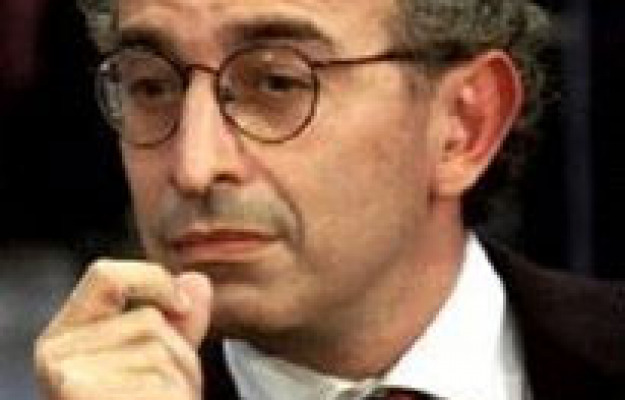Il Consorzio per la tutela del Vino Doc Rosso Canosa, in Puglia, da qualche anno, pubblica un piccolo ma interessante libretto di Meditazioni, per celebrare il nuovo anno. Quest’anno il presidente Nicola Rossi ha chiesto di scrivere le “riflessioni sul vino e sul suo mondo”, ad una dei più bravi, autorevoli e brillanti giornalisti d’Italia, Gad Lerner. Ricordi personali ma anche una lucida analisi del mondo del vino italiano, attraversano le parole di Gad Lerner, che da curioso e attento osservatore dei mutamenti della società disegna uno spregiudicato affresco di un mondo in evoluzione.
La redazione di WineNews ha chiesto il permesso al presidente del Consorzio per la tutela del Vino Doc Rosso Canosa(www.canosadoc.it, tel. 0883/661410), Nicola Rossi, per la pubblicazione (negli anni passati, gli scritti sono stati degli economisti Pier Carlo Padoan e Vittorio Grilli):
“… Quando la sera, in cascina, decidiamo di assaggiare una bottiglia interessante, i figli tutto attorno al tavolone cominciano a farci il verso. Mimano il roteare del calice con la mano, uno comincia a storcere il naso denunciando puzze deplorevoli, l’altro scimmiotta giudizi su tannini e acidità, e ancora c’è chi sobbalza di finto entusiasmo oppure recrimina: “perbacco, la solita marmellata!”. Ho dunque ben presente quanto si possa scivolare nel ridicolo a praticare il vino in società nel 2006, senza neppure bisogno della formidabile e benemerita caricatura del sommelier resa celebre da Antonio Albanese. I figli sfottono, ma poi assaggiano, eccome se assaggiano. Perché alla fine se ne accorgono pure loro di come nel bicchiere evolvano l’odore e il sapore: scoprono, in piccolo, il gioco della trasformazione misteriosa che non a caso sospinge l’uomo da millenni a una relazione liturgica con il vino, l’unica sostanza vegetale che lo inebria, lo stordisce, ne modifica percezioni e comportamenti fino a disporlo in relazione con la trascendenza. Il vino è proibito nell’Islam perché lì la relazione col divino è innanzitutto rigida osservanza di quanto trasmesso a senso unico, dall’alto in basso. Con Dio un musulmano non ci discute, né tanto meno ci litiga. La sobrietà dunque è requisito necessario alla sottomissione. Noi che invece con Dio ci dialoghiamo, e purtroppo ci scontriamo da millenni, difficilmente troveremmo il coraggio di mirare così in alto se restassimo perennemente sobri … Ma non vi tedierò con un excursus storico-religioso peraltro lungi dalla mia portata. Mi accontento di fissare questo concetto di “trasformazione misteriosa” alla base del nostro rapporto con il vino fin dalla più tenera infanzia. C’è, infatti, un elemento magico che fin dal principio ci induce a considerarlo distinto e a sé stante fra le sostanze, direi prima del pane e prima dell’oro: il passaggio della fermentazione, il carducciano “ribollir dei tini”, e poi ancora le successive evoluzioni dal grappolo alla bottiglia in cui però non dovrebbero mai annullarsi le caratteristiche uniche di ciascun territorio. La capacità di operare quella trasformazione misteriosa restando però se stesso, irreplicabile nel suo vincolo territoriale, è quanto siamo portati ad ammirare nel vino. Ed è la ragione per cui oggi mi godo, da benestante, il privilegio di assaggiare pure bottiglie importanti: in quanto già le inseguivo da povero in canna. Voglio dire che pur non essendo un vero intenditore - in una degustazione al buio potrei fare figuracce terribili - fin da giovane ho portato per il vino il rispetto che gli è dovuto in quanto creatura del territorio. E dunque oggi considero una fortuna l’aver dovuto inseguire con fatica economica le bottiglie che valevano la pena, disertando l’orgia dei pintoni al metanolo che pure affliggevano molte nostre serate in compagnia sui Navigli milanesi, per non parlare del bianco dei Castelli inflittoci nelle osterie romane di San Lorenzo all’epoca delle prime riunioni politiche nazionali. Già all’epoca, diciamoci la verità, sentivi subito la differenza con un nebbiolo o un dolcetto piemontesi, sia pure in damigiana, e pure un passaggio in Toscana restituiva immediatamente esperienze superiori. Insomma, in giro c’era del vino decente perfino negli anni settanta della nostra indigente gioventù, e pure allora s’evidenziava un discrimine naturale con coloro - ne incontro purtroppo ancor oggi - che lodavano la bella barbera frizzante, il grignolino leggero leggero, per non parlare del lambrusco gelato. Roba da farti accapponare la pelle, un po’ come gli antenati dei buoni vini pugliesi contemporanei: certi rosati che tracannavamo incoscienti da Strippoli, di fianco all’Università Statale di Milano, insieme ai suoi squisiti panzerotti bollenti. Non era difficile praticare un minimo di discernimento tra quel che ingurgitavi per mera necessità alcolica e il vino come prodotto di una civiltà territoriale. Bastavano un paio di viaggi in Langa guidati dalla sinistra torinese che lì conservava le sue paterne memorie partigiane. E se ancora potevi permetterti solo pochi assaggi del barolo di Bartolo Mascarello (lui lo sapeva, ma gradiva ugualmente le nostre visite e allora tirava su dalla cantina bottiglie vecchie straordinarie) ti accontentavi di comperargli un cartone di freisa o di dolcetto. Dopo di che passavi da Canale d’Alba dove il dolcetto sfuso di Gallino reggeva il confronto con tutto il vino di Milano. Ci andai la prima volta grazie a Pietro Marcenaro, mentre devo a Carlin Petrini e a Franco Carlini la conoscenza dell’indimenticabile Bartolo Mascarello. La conoscenza di quelle vigne, e di quanto misteriosa fosse la loro trasformazione in bottiglie profumate di terra, ci avrebbe insegnato ad accostarci con umiltà a un mondo all’epoca per niente di moda: ricordo quanto faceva chic bere Mateus, ahimè un vinello portoghese dalla bottiglia rotonda che sapeva d’acqua minerale. Solo oggi mi sono riaccostato con un minimo di fiducia a certi ottimi “tinti” della regione di Oporto, tanto ne rimasi traumatizzato. C’è voluta, trent’anni dopo, la scoperta di quale eccellenza sappia esprimere l’intera penisola iberica nel campo dei vini. Mentre la Francia, ovviamente, era un mito già allora. Non dirò che organizzassimo degli appositi viaggi enogastronomici, mica potevamo permetterceli. E, però, oltralpe s’affinava un sano spirito selettivo: meglio saltare quattro pranzi – sostituendoli peraltro con baguettes e formaggi straordinari – ma, una tantum, varcare la soglia di un vero grande ristorante. E’ stato, poi, sempre il mio criterio ispiratore. Meglio una notte in un hotel de charme che una settimana in pensione. Meglio una cena sublime all’anno che l’abbonamento in pizzeria. E in quella cena sublime, che è esplorazione, scoperta, trova il suo sbocco naturale la celebrazione del vino. Ricordo ancora il tremore con cui consultai la prima volta a Vézelay, in Borgogna, una lista nella quale diverse bottiglie costavano quanto il mio reddito annuale. Ma si poteva benissimo reggere il bluff, assaggiare il pinot nero più buono del mondo, e uscire a testa alta da quel luogo di iniziazione. Dopo di che il tempo sarebbe venuto anche per gli esercizi più rilassati e appetitosi. Come ad esempio la degustazione di una signora bottiglia senza intorno l’ambaradan di una gastronomia complessa: con un uovo, un’insalatina tenera, il pane giusto … Ora sarà più chiaro perché i nostri figli abbiano diritto a sfotterci quando cediamo ai vezzi dell’intenditore di vino, ma nello stesso tempo siano già preda di curiosità enologica. Non c’è niente di peggio, per il vino, di questa moda impasticciata, fatta di un gergo improbabile per cui - a ondate - profumo equivale a legno ma poi guai se usi la barrique e allora solo botte grande, no anzi meglio ancora l’acciaio. Perché alla fine di questi vini densi, stracarichi - non a caso i figli ci imitano quando imprechiamo contro una “marmellata” - riusciamo solo a riconoscere sempre lo stesso profumo. Io da questo decennale tragitto tra produttori e bottiglie amatissimi, ne ho tratto una sola definitiva consapevolezza: se il vino implica liturgia nell’accompagnarci a trascendere, ebbene, riconosciamo con umiltà di fronte ai suoi rari sacerdoti sapienti che la sua trasformazione resta un’arte difficilissima. Non è vero che se c’hai la terra buona e ci metti i soldi e assumi l’enologo giusto il prodotto è garantito. Fare il vino normale è costoso ma facile, fare il vino buono implica una scelta d’impegno a tempo pieno vita natural durante. Il contrario di un hobby alla moda. Eppure ci sono cascato. Una delle ragioni per cui i figli allo sfottò fanno seguire la curiosità è la vigna che hanno visto crescere sul bricco esposto sud-sud lì, subito a ridosso della cascina, nel Monferrato casalese. E figuratevi che potremmo usufruire della Doc d’Asti, ma invece vogliamo dimostrare che le nostre colline non hanno niente da invidiare a quelle dei nostri gloriosi cugini “langhetti”. Metà barbera e - non ridete - metà nebbiolo. Com’è possibile che io abbia ceduto, nonostante tutte le raccomandazioni che mi facevo da solo: rispetto troppo il vino per pretendere di essere capace di farlo; non c’è niente di più burino del benestante, magari con la faccia televisiva, che pianta la vigna come status symbol … Lo so, è tutto vero, ma io cinque anni fa ho conosciuto Fabrizio Iuli. E questa, vi assicuro, è un’ottima giustificazione. Uno che questa nostra terra calcarea la sente pulsare fin da quando trasmette i suoi sali minerali alla barbatella, e poi ha il coraggio di staccare grappoli finché ne resta uno solo a prendersi tutto il sole decisivo di settembre. Qui mi fermo in una descrizione che potrebbe suonare bassamente pubblicitaria e comunque in conflitto d’interessi con le motivazioni di questo scritto. Nell’aver osato il passaggio proibito da degustatore appassionato a piccolo produttore associato, invoco le attenuanti dell’essermi ritrovato vicino di casa e ammiratore delle vigne vecchie di un personaggio del vino come per fortuna ce ne sono ancora. Di quelli che hanno girato il mondo e dunque non è per ignoranza se tornano al loro territorio e lo interpretano perché lo conoscono attraverso le generazioni. Di quelli che godono il privilegio di una vigna piantata dal nonno (sapranno approfittarne i miei nipoti?), e dunque il vino lo creano lì in vigna, filare per filare, senza puntare sui successivi arrangiamenti di cantina, anche se ciò significa continuare a farne poche migliaia di bottiglie. Voglio dire che in tutta l’Italia ci sono personaggi così, testimoni del passaggio generazionale, portatori dell’unica cultura in grado di modernizzare con civiltà la loro terra. Io porto loro il rispetto dovuto agli artisti, in genere taciturni e scontrosi, che se li vuoi conoscere devi andare tu a casa loro e mostrargli che capisci la loro appartatezza. Quando in città stapperai per cena a casa tua una di queste bottiglie, non cercare neppure di spiegare agli amici da dove arriva quel profumo e quella leggerezza e quella semplicità. Cosa vuoi che capiscano, così per sentito dire … Trascenderanno felici e incoscienti. Tu riderai sotto i baffi”.
Gad Lerner
Il ritratto - Chi è Gad Lerner
Gad Lerner comincia la sua attività giornalistica nel 1976 nel quotidiano “Lotta continua”, per passare poi al “Lavoro” di Genova ed al “Manifesto”. Nel 1983 entra nella redazione de “L’Espresso” di cui diventa inviato. Fra il 1990 ed il 1993 conduce, per Rai Tre programmi come “Passo falso”, “Profondo Nord” e “Milano, Italia”. Dal 1993 al 1996 è vicedirettore de “La Stampa”. Tornato in Rai, conduce il programma “Pinocchio” e dirige il Tg1 per soli tre mesi nel corso del 2000. Attualmente è inviato editorialista de “La Repubblica” e conduttore per La7 del programma televisivo di approfondimento “L’Infedele”. Ha scritto, fra l’altro, “Operai” (1988), “Crociate. Il millennio dell’odio” (2000), “La concentrazione del potere” (2002), “Tu sei un bastardo” (2005).
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025