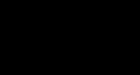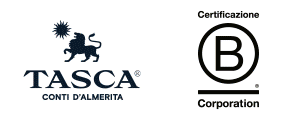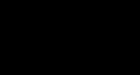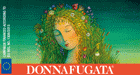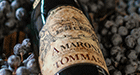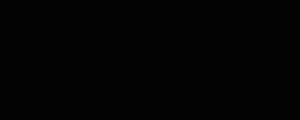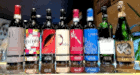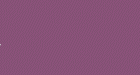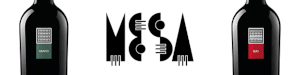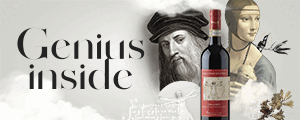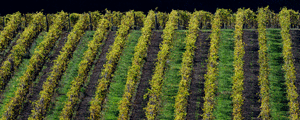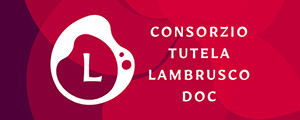Sapore di vino ... Botanici. Archeologi e genetisti riscrivono la storia della viticultura. Ma anche il futuro del vino italiano ha un gusto antico... “Ho capito che per fare il vino bisogna studiare storia, non agronomia” dice Josko Gravner accompagnandoci a visitare la sua vigna al di là del confine, in Slovenia. Tre ettari piantati a Ribolla gialla lungo il fianco di una collina su cui si affaccia la vecchia casa di famiglia, antica di 300 anni, ora abitata solo durante la vendemmia. Josko è un uomo di frontiera. E non soltanto perché le sue vigne sono sia nel Collio goriziano, dove vive, che in quello sloveno, divise da un confine che soltanto oggi si supera facilmente; ma perché nel suo campo è stato sempre un pioniere. Lo è stato trent’anni fa, quando la produzione vinicola italiana non brillava certo per qualità, ma solo per quantità, e lui cominciava già a imbottigliare quei vini bianchi ricchi, strutturati, complessi, fatti per durare nel tempo, che nessuno qui da noi aveva visto mai. Vini, i suoi, creati con metodi allora rivoluzionari - presse pneumatiche, fermentazione in vasche d’acciaio, controllo delle temperature, affinamento in barrique (la piccola botte di rovere nuova da 225 litri) - mentre eravamo ancora abituati a vinelli leggeri, da bere gelati, d’estate, per dissetarci.
Gravner è stato tra i primi a introdurre in Italia l’uso di queste tecnologie che andavano diffondendosi nel mondo a macchia di leopardo - in California, Australia, Nuova Zelanda, Cile, Sudafrica - e che avrebbero dato vita nel nostro paese ai vini che avrebbero guidato la rinascita della nostra produzione, non più solo votata alla quantità ma alla qualità: i “supertuscans’, i barolo diventati morbidi come velluto, i grandi vini firmati da star dell’enologia nostrana come Riccardo Cotarella e Giacomo Tachis.
I vitigni tradizionali venivano affiancati o soppiantati da altri - Chardonnay, Merlot, Shiraz, Cabernet Sauvignon - che garantivano vini potenti ma equilibrati, complessi, ricchi di sentori, moderni, decisamente internazionali. “Hollywoodiani” come li ha ribattezzati di recente Alessandro Baricco. Impossibili da non amare. Dal 1986 - annus horribilis del vino nel nostro paese, l’anno dello scandalo del metanolo - a oggi sono trascorsi vent’anni rivoluzionari dal punto di vista dell’evoluzione del gusto. Ovunque sono spuntati wine bar, corsi di degustazione, nuovi vitigni, produttori giovani, audaci e innovativi. Tutto è cambiato.
È cambiato però anche lo schivo, laconico, e sempre controcorrente, Josko Gravner. “Non riuscivo più a bere il mio vino. Non mi piaceva”, racconta seduto attorno al tavolo della casa antica, riparata dal caldo di fine luglio da mura spesse un metro. “Nel 1987 sono andato in California, e ho capito tutto quello che non dovevo più fare. Ripensavo a quello che mi diceva mio padre, poco vino, ma buono’. Dovevo cancellare tutto, ricominciare da capo, dalle origini”.
E Josko torna indietro, nel tempo e nello spazio. Studia storia antica, e si avventura in Georgia, nel lontano Caucaso, dove ancora qualcuno sa fare delle anfore di terracotta alte due metri e mezzo come si facevano 5000 anni fa. I più antichi contenitori del vino. Sparisce dalla circolazione, e comincia a sperimentare, lui che Luigi Veronelli ha chiamato “il primo vignaiolo del mondo”. Mette l’uva, diraspata, a macerare per mesi sulle bucce in quelle anfore bellissime alte due metri e mezzo, rivestite di cera d’api e sepolte nel terreno. Anche fra i tanti che lo avevano osannato come maestro, subendone quel carisma alimentato da una riservatezza al limite della misantropia, inizia a girare la voce: “Gravner è impazzito, si è messo a fare il vino nelle anfore”.
Eppure è stato uno studioso, Attilio Scienza, a mettere la pulce nell’orecchio di Josko raccontandogli di quelle anfore caucasiche. Scienza, docente di Viticoltura all’Università di Milano, ha ripercorso al contrario il millenario cammino della vite da Oriente a Occidente. Ha partecipato a una spedizione che ha attraversato Grecia, Balcani e, appunto, il Caucaso, sulle tracce degli antenati primigeni della vite domestica. Da anni cerca di ricostruirne l’origine e la diffusione, utilizzando metodi presi in prestito dall’antropologia, raccogliendo attorno a sé e facendo incontrare esperti di discipline diverse, come linguistica, archeologia, genetica, e legando il tutto con la teoria dei centri culturali. “Lo studio della coltura della vite è tutta una questione antropologica, non biologica”, spiega Scienza. “La teoria dei centri vede la diffusione della cultura umana attraverso un percorso fatto di cerchi: da quello originario ne nascono altri, come a creare una costellazione, e ognuno dei centri, come cerchi nell’acqua, incontra e interagisce con l’altro, creando ogni volta una nuova cultura. Fin dal principio, la domesticazione della vite è stata intrecciata a tradizioni, usi, costumi. Studiare la vite coltivata significa perciò capire la storia dell’uomo dal neolitico in poi, e di come ha colonizzato il territorio portando con sé le esperienze e le conoscenze necessarie a dar vita a nuove società”.
Mettendo assieme le recenti scoperte archeologiche con le possibilità offerte dalla biologia molecolare, si è ottenuto un approccio del tutto nuovo alla ricerca delle origini e della diffusione della vite: uno dei temi più affascinanti ma anche più controversi e dibattuti dell’enologia, su cui sono stati sparsi fiumi d’inchiostro in cui riecheggiano storia, testimonianze archeologiche e gli innumerevoli miti del mondo antico.
“Si è pensato a lungo, ad esempio, che vi fosse stato un unico centro originario di domesticazione della vite, e che esso fosse appunto situato nell’area della Mezzaluna Fertile e del Caucaso”, continua Scienza. “Ora sappiamo che non è così. Quella del Caucaso è stata una zona di domesticazione primaria della vite, ma ve ne furono molte altre secondarie. E ciò ci è stato confermato analizzando il DNA delle viti raccolte in tutte le aree di diffusione della pianta: infatti, via via che ci si allontanava dal centro di domesticazione primario, la variabilità genetica, anziché diminuire, aumentava. Il che vuol dire che quella vite, resa domestica in Oriente grazie alle particolari condizioni climatiche crea tesi fra le glaciazioni, e al particolare ambiente “tecnologico” che aveva trovato in Caucaso, viaggiando aveva poi incontrato altre viti, selvatiche o paradomesticate, ogni volta implementandosi, arricchendosi. E arrivando fino alle circa 10 mila varietà presenti oggi in Europa, anche se, di queste, soltanto un migliaio sono quelle effettivamente coltivate”.
Se tutto è riconducibile all’antropologia, anche lo studio del DNA della vite segue la stessa metodologia applicata allo studio della diffusione delle popolazioni umane. “Noi partiamo dalla considerazione che il genere Vitis abbia avuto origine nelle zone più settentrionali dell’emisfero boreale”, spiega il biologo molecolare Massimo Labra nel suo laboratorio all’Università milanese della Bicocca. “In seguito, si sarebbe spostato verso latitudini più calde, soprattutto durante le ere glaciali, per sfuggire all’avanzata dei ghiacci. Questa migrazione, frammentata, avrebbe portato alla diffusione della sola specie Vitis vinifera nell’attuale regione europea, e di conseguenza, della Vitis vinifera sylvestris (la vite selvatica, progenitrice degli attuali vitigni coltivati) in un areale molto vasto, che comprende non solo la zona di domesticazione primaria, ma tutti i paesi affacciati sul Mediterraneo”, continua Labra.
“La vite selvatica (Vitis vinifera L. sylvestris) e la vite domestica, o coltivata ( Vitis vinifera L. sativa) sono due sottospecie dalle caratteristiche molto diverse. Ad esempio, la prima preferisce luoghi vicino all’acqua; la seconda, i terreni asciutti. Ma soprattutto, le distingue il modo di riprodursi: la vite coltivata ha fiori ermafroditi, può cioè autofecondarsi senza bisogno quindi di piante di sesso opposto per produrre frutti, e perciò è più produttiva”.
Ed è per questo che è stata selezionata dall’uomo, secondo fonti archeobotaniche, già 8000 anni prima di Cristo, nella regione tra Caucaso e Iran. Ma la grande variabilità genetica riscontrata fa pensare, come sostiene Scienza, che ci siano stati altri centri di domesticazione oltre quello della Transcaucasia; anche in Italia?
“In Italia”, risponde Labra, “abbiamo raccolto campioni di vite da popolazioni presenti in Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria, ma soprattutto Sardegna, dove abbiamo riscontrato una certa somiglianza tra i campioni di vite selvatica e due vitigni coltivati tradizionalmente nella zona di Nuoro: il che fa pensare che si tratti di due casi di domesticazione locale. Il confronto tra viti selvatiche e viti coltivate è importante anche per chiarire l’origine dei vitigni locali: oggi si parla molto di vitigni autoctoni, ma dal nostro punto di vista, non possiamo considerare autoctoni quei vitigni di cui non riscontriamo parentele genetiche nell’area di interesse”.
Storicamente, le regioni del Mediterraneo occidentale, come appunto la Sardegna, sono sempre state considerate destinazioni finali di un patrimonio vinicolo portato via via dal conquistatore di turno: Fenici, Romani, o spagnoli. “Eppure”, sottolinea Attilio Scienza, “la prima civiltà dell’Europa occidentale capace di tessere traffici e rapporti con le diverse aree del Mediterraneo - e che quindi, potrebbe anche aver avuto un ruolo nel domesticare e diffondere la vite - è stata quella nuragica”. Un’ipotesi confermata dal ritrovamento, in diversi siti archeologici sardi, di semi di vite risalenti a un periodo antecedente l’arrivo dei Fenici. Nel sito di Borore, in particolare, lo stesso seme è presente per ben 1500 anni, dal 2000 al 500 a.C. Il che spinge alcuni paleobotanici a sostenere che i Fenici potrebbero aver introdotto nuove varietà di vite “orientale” senza però sostituire quelle locali. Altre, suggestive ipotesi, ci giungono anche dalla mitologia. “Esiodo parla del rapimento di Dioniso da parte dei pirati tirreni”, continua Scienza. “Ma il termine tirreno proviene dal greco tyrsis, torre. E l’unica civiltà che innalza torri, fra l’Età del Bronzo e l’Età del Ferro, è quella nuragica. Non solo. Basandosi sulle spiccate affinità linguistiche, le notizie fornite da autori classici, e i molti reperti ‘sardi’ rinvenuti nelle tombe etrusche, alcuni esperti, a partire da Massimo Pittau dell’Università di Sassari, hanno rivelato lo strettissimo legame esistente fra i Sardi e gli etruschi, che secondo alcuni studiosi ebbero proprio origine da un popolo proveniente dal mare; chissà, magari i Sardi stessi”.
Che gli Etruschi conoscessero la vite e il vino già prima dell’arrivo dei Greci, al contrario di quanto si è a lungo pensato, per i ricercatori del progetto “Vinum” è ormai una certezza. Il progetto, promosso dall’Università di Siena e dall’Associazione nazionale Città del Vino, sta indagando sulle origini della viticultura nell’antica Etruria.
“Abbiamo iniziato raccogliendo campioni di vite silvestre in prossimità dei siti archeologici etruschi”, racconta l’archeologo Andrea Zifferero, condirettore con Andrea Ciacci del progetto. “Il nostro presupposto di partenza era che la vite cresciuta vicino all’uomo potesse conservare più facilmente tracce di domesticazione”. I campioni prelevati erano comunque di viti selvatiche. “Sì, ma la nostra speranza era che si trattasse di vite regredita allo stato selvatico dopo essere stata abbandonata per secoli. E i risultati ci hanno dato ragione. Non è usuale per noi archeologi lavorare fianco a fianco con i genetisti”, ammette Zifferero, “ma in questo caso l’approccio multi disciplinare è determinante. Abbiamo trovato delle lambruscaie - ovvero delle piante di vite arrampicate, come liane, su alberi - che recavano chiaramente nei loro geni tracce di domesticazione”.
La lambruscaia è la tipica coltura etrusca: furono i Greci a introdurre la coltivazione detta a “palo secco”, assieme a nuove tecniche di coltivazione, altri vitigni e la cultura del convivio. Il filare sarebbe invece un’invenzione dei Romani. “Ma le lambruscaie non sono scomparse”, sottolinea Andrea Ciacci: “ancora oggi ci sono contadini che ricavano vino da viti arrampicate sugli alberi. E presto anche noi tenteremo di ricostruire un vigneto etrusco e di sperimentare le fasi della vinificazione di quell’antica popolazione”. Dei bei filari di vite di impianto romano sono visibili oggi, ben vivi e vegeti, all’interno dell’area archeologica di Pompei: sono il frutto di un esperimento condotto da qualche anno a questa parte dalla locale Soprintendenza Archeologica per studiare la viticoltura al tempo dei Romani. “Ci sono tanti miti da sfatare, come quello dei Romani gran bevitori”, racconta la biologa ambientale Annamaria Ciarallo. “In realtà, gran parte della produzione vinicola era usata a scopo medicinale - vino era usato per macerare le erbe officinali, o, in forma di aceto o di mosto, per conservare i cibi. Ne abbiamo la riprova dalla letteratura classica e dalla grande quantità di contenitori in vetro che abbiamo ritrovato”.
I filari invece nascono dallo studio del terreno dell’area archeologica. “Abbiamo individuato zone adibite a vigna nell’antichità, e lì abbiamo trovato le orme delle viti che vi erano a dimora”, spiega Ciarallo. “Abbiamo prodotto dei calchi in gesso, e confrontandoli con le viti rappresentate nell’iconografia pompeiana (lo studio è di Mario Fregoni) abbiamo cercato i vitigni che più potevano avvicinarsi a quelli del tempo - piedirosso e scianscinoso - e li abbiamo ripiantati nelle stesse aree”.
L’uva prodotta è stata poi vinificata dall’azienda Mastroberardino, che versa parte del ricavato delle vendite del vino prodotto alla Soprintendenza, la quale ha potuto ad esempio, con quei fondi, restaurare la cella vinaria del Foro Boario. “Non abbiamo provato a vinificare in antico, ma abbiamo fatto degli esperimenti sul livello di ossigenazione. Del resto, è probabile che il vino dei Romani fosse un’autentica porcheria”, scherza Ciarallo: “Veniva fermentato in anfore rivestite di pece, in cui spesso finivano, storditi dai vapori della fermentazione, animali di passaggio. Si immagina cosa doveva venir fuori?”.
Qual’è il senso di tutte queste ricerche? Ricostruire il nostro passato, restituire al vino una verità storica finalmente completa? Certo, ma non solo. “Riuscire a mappare i vitigni antichi, i vitigni autoctoni del nostro paese, significa recuperare un patrimonio che può rivelarsi oggi particolarmente prezioso”, sottolinea Paolo Benvenuti, direttore dell’associazione Città del Vino. “Di fronte a un mercato sempre più omologato, proporre vini diversi, unici, che non assomigliano a nessun altro può essere una carta vincente anche da un punto di vista commerciale”.
Riscoprire le caratteristiche del territorio, produrre un vino rispettoso della natura, in armonia con l’ambiente, sono concetti che sembrano lentamente farsi strada fra i produttori italiani. “Realizzare vino biologico, o biodinamico, di alta qualità, magari da vitigni autoctoni, è certamente più difficile, ma non impossibile”, afferma Gigi Piumatti, responsabile enologico di Slow Food. “Sono realtà che si vanno sempre più diffondendo nel nostro paese, e che noi stiamo seguendo con grande attenzione”.
Anche se incombono nuove minacce - come quella di consentire l’uso dei trucioli per invecchiare il vino, come vorrebbe l’Unione Europea - il periodo del metanolo sembra ormai un ricordo. “Negli ultimi anni sono entrati in produzione centinaia di nuovi vigneti, le buone etichette si sono moltiplicate ovunque: fare una guida dei vini diventa sempre più difficile”, dice Fabio Rizzari, curatore con Ernesto Gentili della guida Vini d’Italia dell’Espresso. “Anche il mercato mondiale lo dice chiaramente: quella che continua ad aumentare è la domanda dei vini di alta e altissima qualità. Che per noi può significare soprattutto originalità. Non si tratta di dover scegliere aprioristicamente tra vini ‘moderni’ o vini ‘tradizionali’. Ma dopo anni di vini tutti uguali - molto concentrati, fruttati, colorati, legnosi - stanno finalmente emergendo prodotti molto caratterizzati, impossibili da confondere fra loro, e nello stesso tempo di rara piacevolezza”. No, non era impazzito Josko Gravner quando aveva deciso di tornare alle origini. E se ne è avuta la prova al Vinitaly - forse la più importante fiera italiana del settore - del 2003, dove assieme allo scomparso Luigi Veronelli (l’uomo che forse ha inventato la cultura enologica in Italia) fece assaggiare in anteprima i suoi primi vini in anfora, accompagnando le sue bottiglie con le solite scarne, ma essenziali parole: “L’uomo nel 2000 non ha più niente da imparare, perché chi ha lavorato la terra prima ha già inventato tutto… In futuro, come già sto facendo, passeremo tutti i miei vini nelle anfore, come 5000 anni fa… Dobbiamo solo avere la forza di guardare indietro e riprendere quello che i nostri vecchi ci hanno lasciato”. Sembra facile, detto così, e lui continua a ripeterlo, “bisogna far le cose in modo semplice”, sempre più convinto, anche oggi che, come aveva promesso, tutti i suoi vini, prima di riposare in botte passano per l’anfora, che è “un grande amplificatore, sia dei pregi sia dei difetti”. Ne ha molte ormai nella sua cantina, e altre stanno per arrivare. Ma non c’è traccia di rivalsa nella sua voce quando dice: “Sono in tanti oggi a provare a fare il vino così. Anche quelli che mi prendevano in giro”. Un po’ alla volta, sta dismettendo dalle sue terre i vitigni “estranei” per far posto all’amata Ribolla, che cresce in quelle terre da mille anni, o al bosco, “perché la vigna ha bisogno del bosco, non di essere irrigata”, spiega uscendo dalla sua casa secolare. Fuori, le mura sono punteggiate di nidi di uccelli a cui ha affidato la difesa della sua vigna dagli insetti, anziché farlo fare ai pesticidi.
Quella del vino è una storia infinita, di cui certo non è stata ancora scritta l’ultima pagina, e che forse non si scriverà mai, almeno finché esisterà l’uomo. Ma oggi a Josko bere il suo vino piace, e tanto basta. (da National Geographic di settembre)
Autore: Stefania Martorelli
Copyright © 2000/2024
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2024