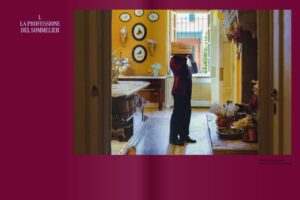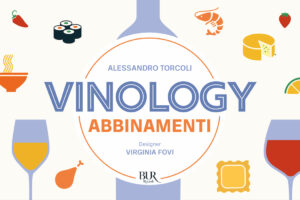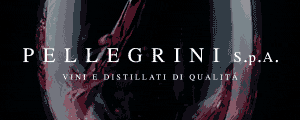Il clima, specie nel recente passato, ha dato segnali decisamente inequivocabili del suo cambiamento, con evidenti ricadute sulle caratteristiche principali di molti dei vini più importanti del mondo. Il dibattito è aperto e probabilmente rappresenta uno dei temi fondamentali della vitivinicoltura del futuro. Ma se guardiamo alla storia della viticoltura e dell’enologia il clima ha già scritto un capitolo importante “orientando” in modo incisivo alcuni dei vini più celebri al mondo. È il caso dello Champagne che, secondo l’affascinante ricostruzione del professor Attilio Scienza, ordinario di viticoltura all’Università di Milano, è quello che siamo abituati a bere anche, e forse soprattutto, grazie ai mutamenti climatici che hanno segnato la sua storia fin dalle origini.
Nella Champagne fino alla fine del XVII secolo si producevano vini rossi fermi, peraltro modesti, ottenuti da Pinot Noir. L’Europa stava attraversando l’ultima e più acuta fase della cosiddetta “piccola glaciazione”, che perdurava da circa due secoli. Nel 1709, infatti, ci fu “la più grande gelata che si ricordi - spiega Scienza - con conseguenze catastrofiche per tutta la viticoltura europea e quindi la Champagne, che occupa il limite più settentrionale della zona dove è possibile coltivare la vite, subì in modo molto negativo gli effetti del clima di allora, e quindi dovette trovare una soluzione. La Champagne, allora, grazie al miglioramento delle tecniche di pressatura, iniziò la produzione dei vini bianchi da uve rosse (“blanchiment”)”.
Intanto, nel 1694 il termine “mousseux” (spumante) era entrato ufficialmente nel dizionario dell’Accademia di Francia e, nel 1728, un regio decreto della corte di Versailles autorizzava la vendita del vino in bottiglia, senza la quale il successo dello Champagne sarebbe restato una chimera. Nel 1735, il pittore francese François de Troy dipingeva il quadro “Le Déjeuner d’Huitre” (il pranzo delle ostriche), che raffigurava, per la prima volta, un tappo che vola e, accanto ai molluschi, alcune bottiglie di Champagne, anticipando uno degli abbinamenti più classici di tutta l’enogastronomia. Nel 1759, ma qui il racconto sfuma nella leggenda, alla corte di Luigi XV veniva modellata sul seno di Madame Pompadour la coppa per lo Champagne, che oggi sarebbe adatta alla degustazione di un vino dolce come l’Asti Spumante. E in effetti, allora, lo Champagne era un vino dolce, anzi in certi casi dolcissimo, da fine pasto.
Ma accanto all’andamento climatico un altro elemento che dette l’avvio alla produzione di uno dei vini più famosi al mondo fu il ruolo dell’Inghilterra, quasi uno scherzo della storia, dati i rapporti a dir poco inquieti fra la Francia e il Regno Unito. “Senza l’Inghilterra non ci sarebbe lo Champagne - continua il professore dell’Università di Milano - non solo per il fatto che il Regno Unito rappresentava, insieme all’Olanda, il paese più forte per il commercio dei vini dolci, l’unico capace di far concorrenza ai mercanti veneziani di vini dolci provenienti dal Mediterraneo, ma anche perché proprio in Inghilterra, nel 1662, il dottor Merrett propose per primo il metodo della rifermentazione in bottiglia con l’aggiunta di zucchero alla Royal Society. Parallelamente, siamo nel bel mezzo della rivoluzione cromwelliana, i francesi costretti a tornare in patria, cominciare a produrre un vino ottenuto con una rifermentazione in bottiglia nei dintorni di Parigi”.
Ma il clima si è limitato soltanto a far produrre nella Champagne un vino bianco? “Il clima ha agito in profondità anche nelle metodologie produttive dello Champagne - aggiunge Scienza - Tra la fine del XVII fino a tutto il XVIII secolo le condizioni climatiche per produrre un vino fermo e secco nella Champagne non c’erano. Arrivano nella Champagne nuove varietà a bacca bianca, perché quelle a bacca rossa non avrebbero mai prodotto vini decenti, il Gouais, il vitigno che ha dato i natali allo Chardonnay, e lo stesso Chardonnay. Ma per fare del vino in linea con i gusti di allora che privilegiavano la dolcezza, era necessario “dosare” il vino, metterci in sostanza dello zucchero. Così comincia anche la pratica del “dosage”, che diventa successivamente un elemento distintivo dello Champagne. Ma, fin dalla seconda metà del XIX secolo, tutti sono stati concordi nell’affermare che con il miglioramento del clima e quindi con annate più favorevoli, il “dosage” non sarebbe servito più. Ed oggi, più che mai, stiamo avvicinandosi proprio a quella condizione, grazie ad un altro cambiamento climatico in cui le temperature medie nella Champagne si stanno innalzando, e quindi andremo verso condizioni in cui a vincere sarà il dosaggio zero”.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025