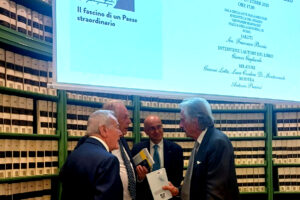Quattro tappe, dal Medioevo ai giorni nostri, per raccontare la storia d’Italia attraverso la sua cucina, vero tratto culturale capace di legare e tenere insieme secoli di storia, tra ricettari,antichi manoscritti, filmati, cartoline, manifesti, ed un allestimento capace di rivoluzionare il Vittoriano di Roma. È “Verso il 2015. Culturacibo - Un’identità italiana”, la mostra che, da qualche giorno al 7 aprile, celebra il connubio tra cultura e cibo, approfondendo il tema dell’alimentazione e le sue numerose sfaccettature, promossa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in partnership con l’Expo 2015, che ha come slogan proprio “Nutrire il pianeta, energia per la vita”.
La regia è di uno dei massimi esperti del settore, Massimo Montanari, docente di Storia medievale e Storia dell’Alimentazione all’Università degli Studi di Bologna che, a “Il Messaggerro”, ha raccontato come il cibo in quanto elemento identitario sia “alla base della riflessione che ha dato origine all’esposizione: l’Italia non si è costruita tanto attraverso il meccanismo istituzionale, quanto attraverso la formazione di un tessuto non omologato fatto di arte, musica, storia e tradizioni.
Non ultima la cucina. Tentando di ricostruire il senso storico di ciò che significa la cultura del cibo in Italia dal Medioevo in poi abbiamo articolato il percorso intorno al cibo come valore culturale su territorio, mercato, cucina e tavola, in un continuo rimando dal passato al presente”.
Info: www.expo2015.org/eventi/verso-il-2015-culturacibo-un-identita-italiana
Focus - La mostra: “Verso il 2015. Culturacibo - Un’identità italiana”
Molto più che nelle vicende politiche e istituzionali, l’identità italiana si è costruita entro uno spazio culturale che nel corso dei secoli ha cementato il tessuto della nazione. Una rete di scambio e di condivisione, un “linguaggio comune” fatto di saperi, pratiche, abitudini, gusti ha tenuto insieme territori geograficamente e storicamente diversi, eppure riconoscibili - e senz’altro riconosciuti, all’interno e al di fuori dell’Italia - come parti di un unico paese. Ben lungi dall’essere una semplice “espressione geografica”, come la definì il principe di Metternich, l’Italia prese forma come espressione culturale, prima di diventare in epoca a noi vicina anche un’espressione politica. Di questa “espressione culturale” - per lungo tempo limitata a una ristretta élite sociale, poi allargatasi a fasce più ampie della popolazione - il cibo è sempre stato un protagonista di primo piano.
La mostra Culturacibo delinea quattro tappe essenziali nel percorso alimentare: produzione, distribuzione, trasformazione, consumo. Si prende avvio dal territorio, dalla molteplicità dei paesaggi plasmati dalla natura e dal lavoro dell’uomo; si prosegue tra i mercati che mettono in connessione i territori e le risorse; si giunge alla cucina, dove il cibo finalmente prende forma; ci si siede infine a tavola, a celebrare il rito collettivo della sopravvivenza e del piacere.
Punti fermi di ogni quadro sono la dimensione culturale delle azioni che accompagnano il cibo dalla terra alla tavola, e la natura storica (in continuo divenire) delle tradizioni che via via si definiscono in questo percorso.
Le sezioni della mostra
1. Territorio
La produzione del cibo e la costruzione del paesaggio agrario
All’inizio c’è il territorio, lo spazio fisico in cui gli uomini si trovano a vivere. Il territorio con le sue “vocazioni”, come spesso siamo soliti chiamarle. Ma queste “vocazioni” sono solo possibilità, che spetta agli uomini mettere in valore, anche forzando il territorio a produrre cose che “naturalmente” in quel luogo non esisterebbero: piante e animali venuti da lontano, introdotti talvolta per caso, talvolta inseguendo un progetto.
L’Italia ha una geografia estremamente complessa, fatta di micro-ambienti e micro-climi che cambiano nel giro di pochi chilometri. Altrettanto complessa è la sua storia, che ha visto incrociarsi e sovrapporsi tanti popoli, tante dominazioni, tante culture. Tutto ciò non è avvenuto senza drammi, conflitti, contrasti. Ma sul piano culturale ha arricchito il paese di una varietà produttiva e culturale senza pari. Geografia e storia hanno congiurato per fare del paese Italia un laboratorio di biodiversità unico al mondo.
2. Mercato
Scambio e circolazione di prodotti e di saperi
L’incredibile varietà del paesaggio italiano e delle realtà produttive a cui esso ha dato origine non è mai stata una realtà autoreferenziale. Il localismo, carattere dominante della storia italiana, non è rimasto chiuso in se stesso ma si è definito attraverso lo scambio: i due fenomeni (radicamento territoriale ed “esportazione” del territorio) sono andati di pari passo. La circolazione dei prodotti sui mercati rurali e cittadini ha diffuso la loro conoscenza al di là dei luoghi d’origine; la circolazione degli uomini ha contribuito a diffondere gusti e pratiche alimentari; la circolazione dei saperi, attraverso gli scritti, le parole e i gesti, ha diffuso idee, gusti, modi di fare. In questo modo si è creata, a poco a poco, una cultura italiana del cibo.
3. Cucina
Saperi e pratiche di preparazione del cibo
Trasformare i prodotti in un cibo da mangiare è operazione che ogni società definisce secondo scelte e modalità proprie, che cambiano nel tempo e nello spazio. Anche in questo caso, la vivacità della cultura italiana trae alimento dalla frammentazione geografica e storica del paese: il Medioevo comunale avvia una stagione di municipalismi gastronomici che costituiscono un aspetto tra i più interessanti della cucina italiana. Dai primi ricettari medievali ai fasti del Rinascimento, quando l’Italia fu leader riconosciuta della gastronomia europea; dagli sviluppi sei-settecenteschi alla “sintesi” di Pellegrino Artusi, che a fine Ottocento fissò il paradigma della cucina italiana moderna; da questo sostrato storico fino agli odierni successi della ristorazione italiana nel mondo, il valore aggiunto di questa cucina è sempre stato quello della varietà, della differenza, del “locale” eretto a sistema.
4. Tavola
Il cibo consumato e condiviso
Il percorso del cibo sta per compiersi, è il momento di sedersi a mangiare (sempre che non preferiamo farlo in piedi). È il momento in cui le relazioni tra gli individui, e i loro ruoli all’interno del gruppo, trovano il massimo di espressione. La tavola, immagine della società, è il luogo privilegiato per manifestare e “raccontare” queste relazioni e questi ruoli. Il cibo, ormai definito nei suoi aspetti nutrizionali, gastronomici, dietetici, si fa vero linguaggio, strumento efficace di comunicazione.
La tavola è “apparecchiata” come un teatro, definisce la comunità e le sue gerarchie, le appartenenze e le estraneità, le amicizie e le inimicizie (è il luogo del piacere e della gioia, ma anche della solitudine e del tradimento). Gli aspetti materiali della scena conviviale, il tovagliato, le posate, i bicchieri, i vassoi, così come i cerimoniali di servizio, hanno una natura strumentale e al tempo stesso simbolica. I modi di stare a tavola definiscono spazi sociali e culturali.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025