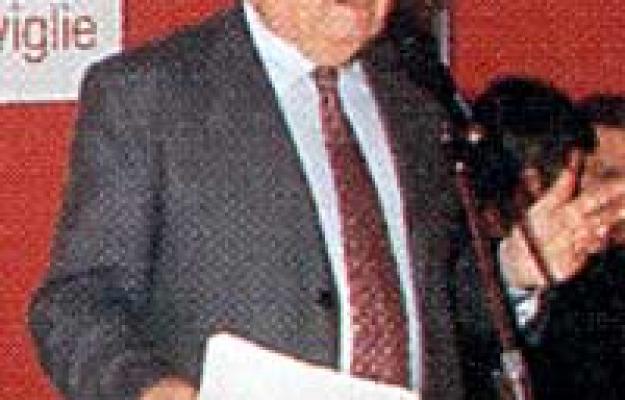L'enologia italiana sta vivendo un momento felice. I nostri vini all'estero conquistano quote di mercato importanti e soprattutto, negli ultimi anni, c'è stata una crescita d'immagine dovuta alla qualità che i produttori hanno perseguito con costanza e determinazione negli ultimi decenni. Abbiamo intervistato, l'enologo Giacomo Tachis, che tutto il mondo ci invidia per le sue doti professionali, uno dei protagonisti indiscussi nel mondo del vino degli ultimi trent'anni. A lui abbiamo chiesto, cosa vede nel bicchiere, al di là del colore rosso rubino dei vini più famosi da lui inventati.
Dottor Tachis, qual è il ruolo dell'enologo oggi?
Finalmente, dopo anni, di percorsi paralleli l'enologia ha sposato la viticoltura. Mi spiego meglio. L'enologo per decenni è stato lo stregone e il viticoltore era il modesto agricoltore che produceva l'uva. Il suo ruolo finiva un metro dopo la vigna. L'enologo non può disconoscere la viticoltura, il suo ruolo si valorizza soltanto se sa perfezionare e trasformare ciò che ha fatto il viticoltore. Queste due figure devono viaggiare in sintonia, solo dalla collaborazione e fusione tra viticoltura ed enologia ci sarà una crescita nel mondo del vino.
Lei, che ha saputo precorrere i tempi del nuovo rinascimento del vino italiano, cosa vede nel futuro della viticoltura italiana?
Il futuro dell'enologia italiana è in vini di tipicità mediterranea, e molto meno in vini d'imitazione delle altre nazioni produttrici. L'enologia e la vitienologia del futuro, partendo sino da oggi è mediterranea, anche regioni tradizionali, devono avvicinarsi al profilo di un vino che abbia la sua tipicità nel corredo organolettico, ma allo stesso tempo, nella gentilezza della sua struttura.
Quali sono oggi i vini che meglio interpretano questa filosofia?
Sono i vini moderni, quelli che sono stati prodotti in quest'ultimo decennio. Anche i disciplinari si stanno orientando verso questa tipologia, vedi quello del Chianti, che permette di asportare le uve bianche o quello del Brunello di Montalcino, con la diminuizione del periodo d'invecchiamento.
I "supertuscans", dei quali lei è padrino, hanno influenzato questo cambiamento?
Si, certo, hanno contribuito a modificare i vini d'oggi e a renderli più moderni, soprattutto hanno fatto capire che si possono fare degli ottimi vini anche uscendo dai canoni tradizionali di produzione. Sono stati dei punti di riferimento che hanno permesso uno sviluppo delle tipologie più aggiornate per il mercato internazionale.
Oggi cosa sta accadendo ?
Una grande potenzialità c'è nella viticoltura del Sud, anche se la mentalità dei produttori deve ancora modificarsi, nel vigneto si possono fare grandi passi avanti. Fino ad oggi è stato puntato tutto sulla quantità. Ma molti produttori stanno già investendo e sono interessati all'opinione dell'intenditore e del consumatore. Nel Mezzogiorno, grazie al clima, i processi fisiologici della vite sono accelerati e quindi i vini del mezzogiorno sono più pronti all'evoluzione. Oggi anche i pubblici amministratori, che poca attenzione hanno riservato a questa produzione, stanno cercando di recuperare i tempi, puntando sulla qualità.
Come guarda il mondo la nostra viticoltura?
Con moltissimo interesse. D'altro canto il Mediterraneo è il bacino della storia e della cultura del passato, è qui che la vite ha avuto la sua culla e tutti i vini del Mediterraneo stanno suscitando curiosità.
I consumatori italiani hanno sempre guardato i vini francesi con mistificazione, oggi questa sudditanza si percepisce anche nei confronti di paesi emergenti come Australia e California. Come spiega questo sentire e cosa fanno i produttori per combattere questo "complesso d'inferiorità"?
In Francia hanno avuto una sensibilità maggiore sia sui sistemi d'allevamento della vite, sul lavoro in cantina e, soprattutto, hanno da sempre saputo commercializzare i loro prodotti in modo eccelso. Noi dobbiamo fare riferimento all'Europa e guardarci anche dalla concorrenza dei paesi extracomunitari. I produttori stranieri, australiani, sudafricani, californiani, puntano a fare i vini all'europea anche se per loro fortuna potrebbero farne a meno in quanto hanno clima favorevoli ed hanno scelto il meglio di quello che la storia ha seminato nei secoli. Noi siamo figli di un'eccessiva tradizione, l'uomo è libero solo quando non ha vincoli e obblighi.
I vini che lei ha fatto sono nati da questa libertà di pensiero?
All'inizio queste nascite sono state sofferte e, questa evoluzione, in Italia è stata all'inizio guardata con sospetto. Oggi non è più così.
Quali saranno i vini del terzo Millennio?
Quelli del Sud. Con l'aiuto della tecnica avranno un grande sviluppo, riusciremo a fare dei vini più disponibili al palato, complessi sicuramente, ma più rotondi. Saranno avvantaggiati i vini delle isole e delle coste, come l'alta e bassa Maremma in Toscana e del Mezzogiorno. Oggi non si parla più di vino 'salmastro', come dicevano i nostri nonni, ma il mare e la luminosità danno, alla vite, una grande capacità di esprimersi con composti aromatici, con tannini dolci con sostanze estrattive, e saranno più disponibili al palato del consumatore. Purtroppo la comunicazione accelera tutte le mode, le rende suddite di essa, ma per un certo periodo almeno, si andrà verso questo profilo qualitativo del vino e quindi se i produttori, specialmente del mezzogiorno, delle isole e della costiera toscana, ma anche all'interno, si perfezioneranno su questo, avranno sicuramente un grande successo. Dai produttori d'Oltralpe dobbiamo solo imparare l'arte della commercializzazione e della presentazione dei vini.
Si sente parlare tanto di Sangiovese, di Ansonica, ma c'è un vitigno del futuro?
No, ogni zona esprime qualcosa di personale, quindi il vitigno del Duemila sarà migliore, quando sarà coltivato puntando sulla qualità e non sulla quantità come è stato fatto per troppi secoli, in quanto non dobbiamo dimenticarci che il vino è stato un alimento di primaria importanza nell'alimentazione delle classi meno abbienti del passato. Il Sangiovese, secondo me, deve ancora esprimere il suo grande e nuovo volto organolettico, siamo sulla buona strada perché le selezioni clonali, la cultura e la coltura della pianta saranno perfezionate e la qualità diventerà superiore.
Quanta importanza hanno le Doc nello sviluppo della viticoltura italiana?
Sono una carta d'identità del quale il produttore non può farne a meno, perché al consumatore del mondo dà sicurezza.
A proposito della Doc toscana, pensa sarà positiva o trova che creerà confusione nel consumatore?
Non vorrei essere nei panni dell'assessore all'agricoltura! Ma a parte le battute, è un problema molto complesso che dovrà ancora essere perfezionato. Vedo una Doc toscana ad una sola condizione, che ci siano delle precisazioni ben chiare, bisogna fare in modo che le sottozone non subiscano svantaggi.
Recentemente è scoppiata una polemica circa la dicitura da apporre in etichetta che riporta "nuoce gravemente alla salute". Quale è la sua opinione?
Mi sembra ridicolo. Ogni eccesso è nocivo alla salute. Questo episodio mi riporta alla mente quella legge che istituì il re Numa, nella quale prevedeva il diritto al bacio sulla bocca della donna (ius osculi) per verificare se aveva bevuto vino in quanto alle donne era interdetto.
Quale consiglio si sente di dare ad un ristoratore per approntare la sua cantina?
Prima di tutto devono acculturarsi, loro e i collaboratori su quella che è la realtà enologica attuale, perché si stente ancora parlare con troppa superficialità, seconda cosa devono essere selettivi nei vini della loro cantina, ad un punto tale da identificare non quello che è in commercio oggi o quello che fa moda, ma il vero valore organolettico del vino e questo è possibile solo dopo molte verifiche, proprio sulla conoscenza organolettica. Affinché arrivi sul tavolo il vino giusto occorre più professionalità. In Francia anche il più piccolo ristoratore sa presentare il suo vino con competenza.
In una battuta, può riassumere i concetti per capire quale è il vino giusto da mettere in cantina?
Conoscere, leggere, cercare, imparare.
Si è mai sentito defraudato della sua competenza quando vede proporre senza professionalità e conoscenza uno dei suoi vini?
Capita di tutto, pensi che una volta un mio parente ha tagliato il Sassicaia con l'acqua! Quindi, occorre lavorare molto anche sulla comunicazione e sulla conoscenza.
Quale è il ruolo della stampa in questa evoluzione?
E' importante fare informazione, ma la stampa deve evitare di dare giudizi severi perché neanche l'enologo deve ergersi a giudice, tuttavia ribadisco che la stampa ha un ruolo fondamentale sia a livello informativo che culturale.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025