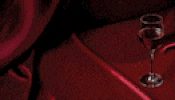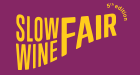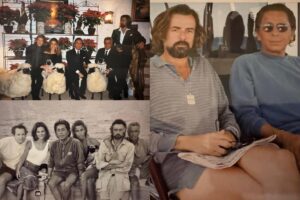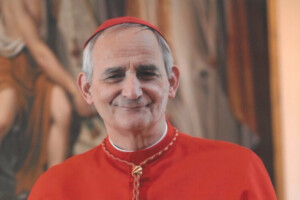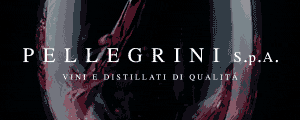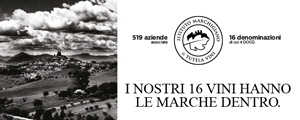Se la strategia per superare i numerosi cambiamenti che stanno investendo il settore vino è l’adattamento, il Consorzio di tutela del Pinot Grigio delle Venezie ha intrapreso - da tempo - una strada decisa: da un lato, la sperimentazione sull’“effetto che fa” il blend Pinot Grigio - varietà resistenti (Piwi) al 10%, in vista e oltre il superamento del loro divieto nelle denominazioni nel Testo Unico; dall’altro, la ricerca in vigneto e in cantina, applicando protocolli specifici, per produrre un Pinot Grigio a bassa gradazione naturale, partendo dalla vigna. Il tutto nell’ambito del progetto di ricerca, promosso dal Consorzio e condiviso con il Crea-Ve Università di Padova, Veneto Agricoltura, Fondazione Edmund Mach e Vcr Research Center. Questa la traiettoria che traccia il futuro del Pinot Grigio delle Venezie - tra cambiamento climatico, ancoraggio al territorio e all’identità del prodotto, innovazione - dettagliata nel Congresso del Consorzio Doc delle Venezie, a Trento, nei giorni scorsi. Una traiettoria che ha un peso importante considerando che il Pinot Grigio delle Venezie è una delle realtà più ampie d’Europa - con 27.000 ettari vitati e 1,7 milioni di ettolitri imbottigliati nel 2024 - ed un modello di integrazione interregionale che unisce Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento.
“Per interpretare il nostro futuro, tra cambiamento climatico, sensibilità della società civile verso la sostenibilità ambientale, esigenze dei consumatori e nuove sensibilità delle giovani generazioni - ha sottolineato Luca Rigotti, presidente del Consorzio di tutela del Pinot Grigio delle Venezie - da tempo stiamo perseguendo un cambio di paradigma nell’approccio produttivo con l’introduzione di vitigni resistenti e la produzione di vini a basso grado naturale e non di dealcolati. Aspetti importanti per consolidare la reputazione e accrescere la notorietà della nostra do che hanno importanti risvolti economici e sociali”. La scelta di produrre una tipologia di Pinot Grigio delle Venezie naturalmente a basso grado - a 9 gradi alcol, ottenuto senza dealcolazione, ma agendo in vigneto e in cantina - è frutto al contempo della volontà di preservarne la tipicità e di andare incontro alle tendenze di consumo. Tuttavia, oltre alla messa a punto della tecnica produttiva, questa tipologia deve fare i conti con quanto previsto dall’Ue e, anche dai regolamenti delle bevande.
“Nel pacchetto vino approvato dal Parlamento europeo, il vino a basso grado naturale non è “previsto”- ha approfondito, con Winenews, Stefano Sequino, direttore del Consorzio di tutela del Pinot Grigio delle Venezie - quindi non ha una sua distintività, mentre i vini ottenuti per dealcolazione totale o parziale possono riportare in etichetta la definizione di “analcolico” o “a ridotto contenuto alcol”. Si tratta di un paradosso che si traduce in uno svantaggio competitivo rispetto ai dealcolati da correggere al più presto nella prossima Pac, altrimenti rischiamo di avere un quadro normativo parziale, incompleto e difficoltà anche da un punto di vista commerciale. Stessi rischi corriamo a causa delle bevande analcoliche che contengono un vino varietale dealcolato come ingrediente e possono riportarlo in etichetta. In Italia questo non è possibile grazie al divieto inserito nel Testo Unico, divieto che dobbiamo riuscire a inserire anche a livello europeo”. Se oggi l’affiancamento al Pinot Grigio dei vitigni Piwi, resistenti ottenuti da incroci interspecifici, è una strada tecnicamente percorribile, un domani, non molto prossimo, potrebbe esserci la possibilità di inserire tra i vitigni complementari anche resistenti ottenuti da Tea (Tecniche di Evoluzione Assistita) su cui - come ha illustrato Riccardo Velasco, direttore Crea-Ve, “ci sono prospettive molto interessanti, che riguardano non solo resistenze a malattie, ma anche alle situazioni estreme poste dal cambiamento climatico”.
La ricerca pubblica tutta sta lavorando, con il coordinamento del Crea, come ha spiegato la dg Crea Maria Chiara Zaganelli, rafforzando “gli studi genetici sulle varietà resistenti e le sperimentazioni enologiche, compresi i vini a basso grado senza dealcolazione”. Tuttavia diversamente che per altri vitigni, come ad esempio Glera, Nebbiolo e Sangiovese, la prospettiva delle Tea (Tecniche di Evoluzione Assistita) è negata al Pinot Grigio dalla sua origine - è stato originato da una mutazione genetica del Pinot Nero ed è “poco stabile”- e questo rende ancor più importante per la denominazione delle Venezie l’introduzione degli incroci resistenti. Alla prova del calice, nel blind taste proposto dal Consorzi - che peraltro è stato e sarà proposto alla filiera in numerosi appuntamenti - i blend di Pinot Grigio delle Venezie e vini di diversi vitigni Piwi (al 10%) sono risultati davvero soddisfacenti, in alcuni casi aggiungendo aspetti intriganti al vino da vitigno in purezza. E considerando che si trattava di microvinificazioni si può immaginare che i risultati di vinificazioni normali possano essere anche migliori. Sull’introduzione dei Piwi anche nelle denominazioni, Marco Stefanini, ricercatore della Fondazione Edmund Mach e presidente dell’Associazione Piwi Italia, ha sottolineato come l’inserimento di varietà migliorative sia un adeguamento in termini di sostenibilità e di arricchimento del prodotto e come l’evoluzione della viticoltura sia sempre passata per l’innovazione genetica. “Si pensi ai molti vitigni derivati da incroci - ha detto - che hanno superato i “genitori”, come ad esempio lo Chardonnay, incrocio naturale tra Pinot Nero e Gouais Blanc”.
“Gli ibridi interspecifici sono la nuova frontiera per la sostenibilità viticola - ha concordato Michele Zanardo (presidente Comitato Nazionale Vini) - e non c’è alcuna preclusione sul loro possibile inserimento nelle denominazioni (attualmente non permesso del Testo Unico, ndr) da parte del Comitato. Certamente è necessario dimostrare il rispetto dell’identità dei vini sperimentalmente e ritengo che il 10% sia un limite teso a preservarla”. In ogni caso, il riscaldamento globale impatta sulla composizione delle uve esattamente nella direzione opposta al richiesto “alleggerimento” dell’alcolicità dei vini. Il cambiamento climatico è una realtà, come ha dimostrato, dati alla mano, Dino Zardi dell’Università di Trento, che tra l’altro ha evidenziato l’accelerazione dell’aumento delle temperature e della CO₂ negli ultimi quarant’anni, che continuerà, senza interventi globali incisivi, anche nelle aree di produzione del Pinot Grigio delle Venezie, come confermato dalle proiezioni delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente di Veneto e Friuli Venezia Giulia. E, peraltro, come ha osservato Luigi Bavaresco (Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza), “il Pinot Grigio è una varietà precoce che predilige i climi freschi e, quindi, un aumento delle temperature e la crescente domanda di vini a bassa gradazione alcolica potrebbero metterne a rischio qualità e mercato”.
In questo quadro i vini sperimentali Pinot Grigio delle Venezie a basso grado naturale - ottenuti applicando specifici protocolli in vigneto e cantina - sono risultati all’assaggio già di buon livello seppure migliorabili per quanto riguarda l’acidità che risulta un poco “tagliente”, e sicuramente superiori alla cieca rispetto ai dealcolati. Il protocollo agronomico ha previsto il confronto tra 6 cloni, defogliazioni spinte sulla parte superiore della chioma dall’invaiatura, applicazioni di caolino ad ogni pioggia e una programmazione della vendemmia a 16 gradi Brix (una misura, semplificando, della concentrazione di zuccheri, ndr). “Le prove e le degustazioni - ha illustrato Paolo Sivilotti (Università di Udine) - dimostrano che, nella ricerca agronomica, ci sono ancora margini importanti di miglioramento, sia sul fronte del basso grado naturale sia sull’impiego delle varietà resistenti. Il nostro compito è continuare a mettere a disposizione “pillole” di conoscenza che permetteranno ai viticoltori di utilizzare un protocollo consolidato per la produzione di vini di qualità a basso grado naturale”. In cantina sono stati sperimentati anche lieviti non saccaromyces e le prove hanno smentito alcune conoscenze su questi lieviti, aprendo anche prospettive di utilizzo diverso da quanto immaginato finora. “La dealcolazione - ha aggiunto Simone Vincenzi (Università di Padova) - è uno strumento utile soprattutto per quella parte di mercato che richiede prodotti completamente analcolici. Qui, invece, parliamo di basso grado naturale obiettivo che si può raggiungere in vigneto e in cantina, attraverso pratiche enologiche mirate. È un cambio di prospettiva importante: se per anni la viticoltura ha lavorato per aumentare il grado alcolico oggi, con le stesse competenze, dobbiamo imparare a fare il contrario”.
Copyright © 2000/2026
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026