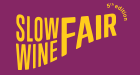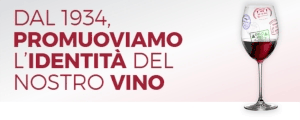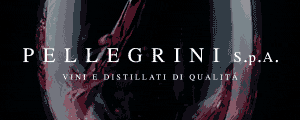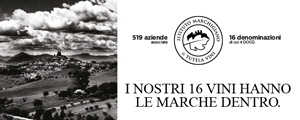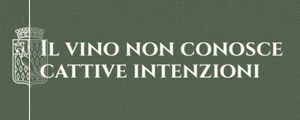Vino & polemiche - Leviamo il tappo ai divieti. Le proposte di Gianni Zonin per battere la concorrenza. Dai trucioli di legno all’impiego di acqua e zucchero: il più grande produttore italiano preme per introdurre pratiche di cantina che consentono di arginare l’avanzata di Australia, Usa e Sud America ... “Meno vincoli normativi. E’ l’unica soluzione per consentire al “made in Italy” vitivinicolo di vincere nella competizione con i Paesi emergenti. Serve un atteggiamento più laico nei confronti delle tecniche di produzione”. Gianni Zonin è il più grande produttore italiano di vino. Il suo gruppo conta 11 tenute e oltre 1.800 ettari di vigneti. Una fucina verde da cui escono ogni anno più di 20 milioni di bottiglie. Zonin è anche uno degli uomini più potenti in questo settore. O almeno questo è il modo che gli è stato attribuito dalla speciale classifica elaborata dal magazine on line “WineNews”, che ha ricostruito una sorta di mappa del “potere” del mondo vitivinicolo. Il nome dell’imprenditore è in cima alla piramide dei personaggi che “orientano le scelte politiche del mondo del vino”.
E’ anche per questo che le sue idee sulla necessità di rivedere il complesso normativo che a livello comunitario governa la produzione del vino sono destinate a far discutere. Tanto più perché proprio in questi giorni, a Bruxelles, si sta discutendo se ammettere o meno nuove pratiche per la produzione dell’euro-vino. Tra le “aperture” ci sono la legalizzazione dell’aggiunta di trucioli di legno nel mosto per ottenere l’effetto barrique, gli zuccheraggi (si aggiunge zucchero per dare maggiore tenore alcolico a uve a bassa gradazione) e l’impiego dell’acqua (per diluire prodotti troppo concentrati o per rendere più corposo un prodotto molto acquoso). Inutile dire che in Italia c’è stata una levata di scudi unanime. O quasi.
Tra le voci fuori dal coro proprio quella del cavalier Gianni Zonin, che tra l’altro ha visto calare il fatturato della sua attività da 80 a 75 milioni di euro, dal 2003 a oggi. “Non possiamo autoflagellarci in nome di un purismo inutile” è la sua tesi.
Non ci sono altre vie per vincere la sfida della globalizzazione?
Certo, si potrebbe armonizzare la legislazione del resto del mondo a quella europea con l’imposizione di regole comuni per tutti gli operatori del settore. Una bella provocazione, ma si può certo imporre a Paesi terzi di accettare le norme Ue …
Infatti, per questo dico che bisogna prendere atto dello squilibrio competitivo esistente. In Australia, come negli Usa e in tutto il Sud America sono consentite pratiche di cantina da noi severamente vietate. Non ci sono vincoli alla messa a dimora di nuovi vigneti. La produzione è regolata esclusivamente dal mercato.
Quindi via libera ai trucioli di vino?
Non capisco perché se un vino lo metto a invecchiare dentro una botte di legno non succede nulla e se invece uno dei trucioli con precisi accorgimenti tecnici che non vanno a danneggiare il prodotto finale, scoppia il finimondo. Se una pratica non altera il vino allora dovrebbe essere consentite. Il mio è un atteggiamento laico. Ma Bruxelles potrebbe fare altro.
Cosa?
L’Unione Europea, per sopperire alla penalizzazione del sistema vitivinicolo europeo dovuta al peso dei tanti lacci e laccioli, potrebbe finanziare il 50% delle spese necessarie al reimpianto dei vigneti. E’ un problema molto sentito. In Italia ci sono almeno 500 mila ettari che devono essere rinnovati. La spesa è enorme: servono 25 miliardi.
Anche vigneti Zonin?
Sì. A oggi abbiamo rinnovato circa 60% dei nostri vigneti. Resta ancora un 40% su cui bisognerà intervenire in futuro.
Vi spaventa l’arrivo della Cina nel novero dei concorrenti internazionali?
La Cina, per il momento, è un bluff. I dati sulla crescita della produzione di vino sono falsati dal fatto che lì chiamano vino qualsiasi bevanda ottenuta da un mosto di frutta. La Cina è più interessante come mercato per il nostro export. Mentre il concorrente più terribile è l’Australia nel 1973 produceva 700 mila bottiglie, oggi è arrivata a 20 milioni.
Ma l’estero può essere anche una meta per investimenti: voi siete presenti negli Usa …
Sì, abbiamo una tenuta di oltre 400 ettari in Virginia, con 80 ettari di vigna dove produciamo circa 800 mila bottiglie l’anno destinate soprattutto al mercato Usa. E’ una piccola attività che cresce costantemente e nel 2005 ha registrato un fatturato di circa 6 milioni.
Com’è la vita dei produttori in America?
Poche regole, rispettate da tutti. E vince solo chi è più bravo.
Le posizioni dei vitivinicoltori di piccole dimensioni. Ma il valore è la nostra sola arma. Dal Piemonte alla Toscana, la concorrenza verso il basso è un’ipotesi che nessuno vuole prendere in considerazione. Perché è meglio andare avanti con prezzi un po’ più alti, assicurando ai consumatori la certezza della qualità …
Dalle grandi botti di legno sgorga Barolo. Quest’anno si vende sfuso, perché il prodotto non sarebbe all’altezza del marchio. Succede a Castiglione Falletto nell’azienda Scavino (poco più di un milione di fatturato, nel 2005). Quattro generazioni dedicate alla produzione dei grandi rosso delle Langhe. “In un’annata normale” racconta Enrica Scavino, prossima erede dell’azienda di famiglia (fondata nel 1921), “produciamo tra le 80 e le 90 mila bottiglie. Ma quest’anno imbottiglieremo l’annata 2002. Una stagione segnata dalla grandine. Per cui ci limiteremo a 5 mila bottiglie. Il resto, anche se conferme al disciplinare, lo venderemo al litro”. 15, 20 euro la damigiana, anziché 67 a bottiglia. E’ così che la Scavino ha costruito la sua fama. “I grandi produttori si riconoscono in questi momenti”.
Perché tra chi vende qualità e i consumatori c’è una sorta di patto tacito: i primi si impegnano a garantire un prodotto eccellente e i secondi accettano di pagarlo un po’ di più. “La concorrenza delle produzioni australiane o cilene non ci tocca” aggiunge. “I loro vini derivano da vitigni internazionali sempre uguali a se stessi, noi vendiamo un prodotto unico”.
Un possibile sdoganamento delle nuove tecniche produttive interessa poco chi produce a marchio (doc e docg). Primo perché è vincolato dai disciplinari, secondo perché i piccoli produttori non possono ambire a competere con gli industriali del settore, italiani o stranieri che siano. “Non possiamo neanche pensare di fare concorrenza verso il basso” dice con il suo verace accento toscano Andrea Mantengoli, proprietario assieme al fratello e al padre della Serena di Montalcino (9 ettari di vigna e 15 mila bottiglie di Brunello l’anno). Nonostante un giro d’affari limitato ancora a 260mila euro, “ogni anno ne spendiamo 30 mila per acquistare legno nuovo (botti e barrique). Inoltre, abbiamo investito 1 milione per una nuova creatura, con spazi più ampi per la conservazione dei legni, lo stoccaggio delle uve e imbottigliamento con un controllo costante della temperatura e dell’umidità.
“Noi possiamo dire di aver vinto la sfida del mercato” sottolinea mentre passeggia tra i filari “quando il consumatore riconosce il valore di ciò che gli proponiamo”.
Resta il fatto che la domanda interna, così come le esportazioni, crescono a ritmi contenuti (nell’ordine del + 1,2% e +1,4% nel 2005) e non è facile ritagliarsi una fetta di mercato. “In Italia si contano migliaia di buoni prodotti” osserva Giovanni Pagnoni, presidente della Barone Pizzini, azienda franciacortina, “ma per farcela servono un marchio e visibilità”.
La Barone Pizzini, nel 2005, è riuscita a fatica a ripetere i buoni risultati dell’anno prima: ha venduto circa 370mila bottiglie di Franciacorta biologico, registrando un fatturato di 3 milioni. “Abbiamo dovuto investire molto in comunicazione e marketing per ripetere quei numeri”. Tanto più che tra i concorrenti non ci sono solo i produttori italiani, ma anche i colossi stranieri “che propongono vini di facile approccio e hanno una capacità commerciale enorme”. Per questo la Barone Pizzini si è messa alla testa di un consorzio (Symposium) che raggruppa 50 piccole aziende italiane e propone a ristoranti e albergatori un’offerta completa di vini autoctoni caratterizzati da un buon rapporto qualità/prezzo. “I clienti ci pagano il vino solo al riordino e noi li supportiamo nella creazione della cantina, dando consigli anche sul posizionamento del prezzo. Se da un lato è vero che i piccoli possono competere soltanto con la qualità, dall’altro “è fondamentale che affrontino il mercato non restando isolati”. Cooperazione e sistema, conclude Pagnoni, “sono i veri ingredienti per la competitività”.
Autore: Nicola di Molfetta
Copyright © 2000/2026
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026