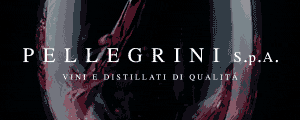De Amicis e Giacosa, dialogo sull’ebbrezza ... Lo scrittore ed il drammaturgo, compagni di bevute, furono protagonisti di un singolare convegno sugli effetti del vino... Il 15 aprile 1880 Edmondo De Amicis alla Società Filotecnica di Torino conclude con il suo intervento un ciclo di undici conferenze sul vino. Prima di lui, tra gli altri hanno parlato scienziati come Lessema, Bizzozero e Lombroso, scrittori come Giacosa e Graf. Letteratura e scienza, leggerezza e serietà in connubio. C’è chi affronta il problema della “filossera” che minaccia i vigneti piemontesi chi parla del beneficio alla circolazione del sangue che può dare un bere moderato e chi invece, cupo, ricorda i danni sociali dell’ubriachezza.
Spetta proprio a De Amicis, che volle e organizzò questo ciclo di incontri, e all’amico Giuseppe Giacosa (compagno di banchetti e bevute) portare freschezza in un consesso in prevalenza serio. Edmondo discute degli “effetti psicologici” del vino, Pin (Giacosa) parla dei “poeti del vino”. Le due conferenze si possono leggere oggi in due bei libretti, curati da Maria Luisa Alberico per la collana “Torino, capitale del vino” di Donnedizioni, e suggerire un dialogo immaginario fra i due amici.
Giacosa (bevitore sobrio) va sicuro, il vino fa bene alla poesia perché può essere un “medium” d’ispirazione: “Tutto ciò che è capace di commuovere fortemente l’anima umana... deve apparire come un bene, se non in se stesso, almeno in rapporto alla poesia”. E parte con una serie di citazioni che prende le mosse da Anacreonte il quale ha il dono di saper unire Bacco e Amore: “Bacco lo fa seguace d’amore, Amore lo fa ardere di sete”. De Amicis (bevitore spesso smodato) lo contraddice. Per lui il vino non è affatto il “cavallo del poeta”: può diventare, è vero, “l’uragano dell’ispirazione”.
In quanto all’amore, il vino per Edmondo può anche creare effetti ridicoli, quando non disastrosi. Chi beve e va in ebbrezza può cambiare “discorso cento volte”, ma ritorna “ostinatamente a quel dolce argomento”; “un fruscio di una veste” lo “scuote come una musica”, il suo “occhio nuota nella dolcezza”, la sua “bocca piglia degli atteggiamenti vezzosi da putti d’oleografia” e il suo “linguaggio è tutto intonazioni languide, reticenze vanitose e piccoli motti a doppio senso, di cui sorridono strizzando gli occhi con una compiacenza profonda”. Conclusione: “Non c’è nulla di più comico che il veder spuntare a poco a poco, per effetto del vino, qualche volta sotto l’apparenza d’un uomo abitualmente austero, questa piccola effige nascosta di don Giovanni ringalluzzito, che s’era lontanissimi dal sospettare”.
In questa precisione figurativa c’è il sospetto di un autoritratto. Così come da un’esperienza personale sembra nascere la riflessione sul “vino cattivo” che conclude il discorso. Edmondo scava a fondo sul potere distruttore del vizio del bere. Lo definisce un vero e proprio (colpevole) tradimento di quel “sangue della terra” che è donato dalla natura all’uomo. È tanto minuzioso nel descrivere cause ed effetti dell’ubriachezza triste da far pensare che parli di qualcosa non ancora per lui del tutto archiviato. De Amicis è un moralista per professione: farà del perbenismo una bandiera letteraria da sventolare. Giacosa è più gioioso e bonario, decisamente più indulgente.
Salva quei poeti che hanno bevuto troppo vino e per questo sono morti: “un poeta ci afferra, si impadronisce del nostro senso artistico, a scapito del morale, ci costringe a un’ammirazione calda,
spensierata, ci eccita e ci sfibra, ci infonde la deliziosa mollezza dei suoi costumi e del suo ciclo, e tutto ciò semplicemente, quasi candidamente”. Ma a gioco, all’improvviso, può capovolgersi. Chi ama bere e magari prendersi di tanto in tanto una sbornia, ma non è un degustatore di vini. Non può comprendere così la raffinatezza del Bacco in Toscana di Francesco Redi, che è un “buon assaggiatore”, un “esperto a far confronti”, anzi un “erudito a raccontare la storia di ogni diverso prodotto”, ma che “sembra rimanere del tutto estraneo a quel che dice”; quasi fosse soltanto un “sommelier” e non un “poeta”.
E invece ascoltate Edmondo, quando descrive i degustatori di professione: “Bevono con gli occhi chiusi e dividono in due operazioni rigorosamente distinte l’assaggiamento e la deglutizione... rivoltano il vino colla lingua, lo fanno scorrere lungo le gote... e non si deridono che a stento a lasciarlo colare nella gola, dopo di che stanno ancora raccolti un momento per assaporare la voluttà dell’ultimo effluvio”. Capacità d’osservazione o esperienza personale di un bevitore quasi di professione?
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025