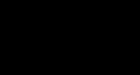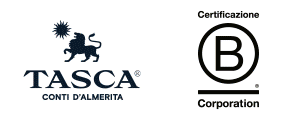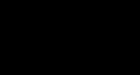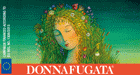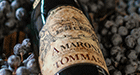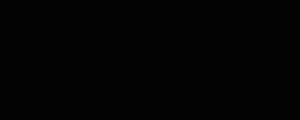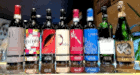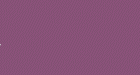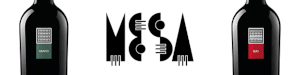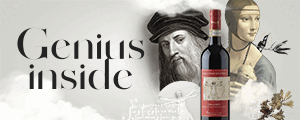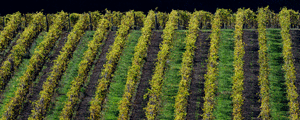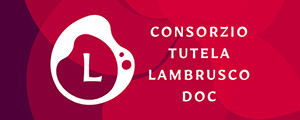A me mi piace - Botta e risposta sul globale con gusto ... Con il suo articolo «Ma la colpa non è
dell’Hamburger», Davide Paolini è tornato sull’argomento
dei prodotti tipici,
lamentando che da qualche
tempo sono innumerevoli i paladini
del cibo legato al "territorio",
dei prodotti "autoctoni",
del ritorno al passato, ma
che questi stessi paladini,
stando ai dati delle rilevazioni
dei principali istituti, al momento
dell’acquisto rivolgono
la propria attenzione verso
prodotti differenti, innovativi
e moderni. Non è vero, dunque,
che la "maggioranza rumorosa"
(come l’ha brillantemente
definita Paolini) ritenga
che questi ultimi prodotti
debbano andare al macero.
Non avrebbe senso abbandonare
la strada della tradizione
e del tipico, che ha fatto
del nostro Paese un punto di
riferimento internazionale.
Mi piacerebbe però non dover
più leggere ingiustificati
attacchi alle industrie alimentari
del nostro Paese. L’industria
italiana è prodotti tradizionali,
è prodotti moderni, è
prodotti a denominazione tutelata,
è prodotti biologici. Il
70% della nostra produzione
agricola viene trasformata dalla
nostra industria ed è ovvio
che questa industria, accusata
di produrre alimenti senza storia
e senza geografia e di appiattire
i gusti degli italiani,
ha invece saputo e sa comprendere
le vere esigenze dei
consumatori. Perché, dunque,
continuare ad affermare che
solo i prodotti alimentari ottenuti
con materie prime locali
sono di qualità e degni di attenzione?
Che senso ha e a
chi serve continuare ad attaccare
le materie prime degli
altri Paesi?
Ai produttori di materie prime?
No di certo. Solo una
sana competizione con la concorrenza
porta le imprese a
migliorare e a cercare nuove
soluzioni per vincere e affermarsi.
Qualunque monopolio
od oligopolio tende ad appiattire
la qualità.
Alle industrie di trasformazione?
Neanche. L’industria
deve potersi rifornire di materie
prime di qualità e deve
poter scegliere dove reperirle
al miglior prezzo possibile.
Restringere il campo di azione
limita le possibilità di scelta
e comporta un aumento dei
costi che la rende meno competitiva.
Ai consumatori? Neppure.
L’apertura dei mercati ha permesso
di scegliere tra una
grande gamma di prodotti e il
libero mercato consente significativi
risparmi.
Questa guerra alla globalizzazione
del gusto porta a grotteschi
paradossi. Il latte prodotto
sulle splendide colline
bavaresi o sulle montagne del
Tirolo austriaco è buono se
utilizzato per produrre i locali
formaggi Dop, ma diventa cattivo
se un’azienda italiana decide
di portarlo in Italia per
produrre mozzarella o latte
alimentare. Oppure il latte in
polvere, usato per produrre ottimi
prodotti come cioccolato,
budini, creme e dessert, è
vittima di attacchi terribili perché
colpevole di coprire truffe
internazionali sulle quote
latte, di compromettere la qualità
dei prodotti lattiero caseari
italiani. Questo atteggiamento
inutilmente allarmistico
porterà la gente ad avere
paura di cosa mangia, quando
è noto a tutti che i prodotti
alimentari oggi in commercio
sono — tutti — di gran lunga
migliori, più sani, più sicuri,
più buoni di quelli che nei
secoli scorsi i nostri avi o già
i nostri genitori spesso erano
costretti a mangiare.
Da qualche tempo, però, abbiamo
la sensazione che qualcosa
stia cambiando. Forse, a
furia di ripetere che non si
vive di solo territorio, che
non si può basare un intero
settore dell’economia su politiche
protezionistiche, che
l’immagine delle nostre imprese
nel mondo non può più
limitarsi a riproporre vecchi
stereotipi, qualcosa sta cambiando.
Dobbiamo continuare
a lavorare, quindi, per sensibilizzare
chi ci governa sui temi
dell’internazionalizzazione
delle imprese italiane: per
esportare non solo i nostri prodotti
alimentari, ma anche le
nostre idee, i nostri modelli
produttivi e la nostra mentalità
imprenditoriale.
Adriano Hribal, consigliere delegato
di Assolatte
Confesso di essere "talebano"
nel sostegno al triangolo ciboterritorio-
identità, ma non di
essere così cieco da negare la funzione
dell’industria alimentare. C’è un
mercato fondamentale dell’alimentazione,
ma esiste un mercato "secondario"
della gola. Il primo è fatto dai
grandi numeri, l’altro è quello che
viene chiamato con una goffa definizione
"nicchia". Non solo nego che i
prodotti "seriali" debbano andare al
macero, ma poche settimane fa ho
sostenuto addirittura che è importante
intervenire, con l’invenzione di nuove
soluzioni, a combatterne lo spreco.
Ciò che non capisco è invece la
rincorsa dell’industria per acchiappare
chi "va’ dove lo porta la gola", cioè
quel consumatore del mercato secondario,
viaggiatore del weekend a caccia
di formaggi e altro, con l’invenzione
di marchi, linee, prodotti "scopiazzati"
dalla realtà artigianale dei territori.
Le imitazioni mostrano, ahimè,
carenza di idee e progetti. Pur in un
momento nel quale la "minoranza silenziosa"
(i cercatori del gusto) dei
consumatori guida il trend, è sempre
la maggioranza rumorosa a decidere i
numeri del consumo, forte del fatto
che l’età media si è notevolmente alzata,
grazie anche a una migliore alimentazione.
Quindi le "umane sorti e
progressive" sono ancora in mano ai
produttori di Quattro salti in padella,
That’s amore, Bel Paese eccetera.
Nessuno mette in dubbio la qualità
del latte della Baviera, il grano del
Canada, le olive turche, greche o algerine.
Lo scandalo è quando nei prodotti
non viene dichiarata la provenienza
di quegli ingredienti. È proprio
di questi giorni il caso di un’industria
olearia italiana, sebbene proprietà
di una multinazionale americana,
che inviava alla vendita olio italiano,
frutto di materia prima in larga
maggioranza estera. Un vero e proprio
united oil of the world.
Ben vengano formaggi con latte
tedesco o francese, oli con olive greche
o spagnole, salumi con maiali
danesi, ma ci vuole chiarezza nel dichiarare:
tecnica di lavorazione made
in Italy, provenienza della materia
prima da altro Paese (magari migliore
della nostra o sostitutiva perché da
noi scarseggia o non esiste, come nel
caso di caffè e cioccolato).
Allo stesso tempo è giusto che siano
penalizzati quei prodotti tipici fotocopiati,
cioè spacciati dai "Vu’ magnà",
con denominazioni di grande
successo (lardo di Colonnata, formaggio
di fossa, aceto balsamico) ma ottenuti
fuori dell’area d’origine storicatradizionale.
È un grave errore fare
la guerra ai prodotti tradizionali, perché
questi nostri giacimenti gastronomici
non mettono in alcun pericolo,
data la loro dimensione, il mercato
dell’alimentazione per chi produce su
grande scala, ma soprattutto perché
sono una vera e propria arma di penetrazione
dei mercati esteri. Il gourmet
americano, francese, tedesco non ricorda
quasi mai i marchi italiani (forse
solo quelli di pasta), ma sempre di
più conosce la mozzarella di bufala
campana, l’aceto balsamico tradizionale
di Modena, il parmigiano reggiano,
l’olio d’oliva extra vergine toscano
o umbro, il prosciutto di Parma. È
attraverso questi "beni culturali" che
il made in Italy può penetrare sempre
più nelle tavole del mondo. Come nella
moda: sono stati gli artigiani-stilisti
a far conoscere la produzione del
Paese, successo sfruttato, poi splendidamente,
dall’industria. (arretrato de "Il Sole 24 Ore" del 16 marzo 2003)
Davide Paolini
Copyright © 2000/2024
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2024