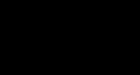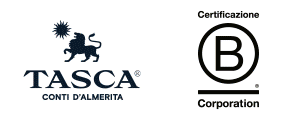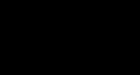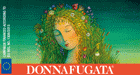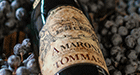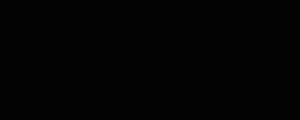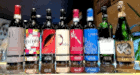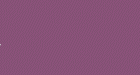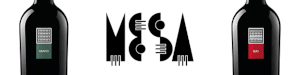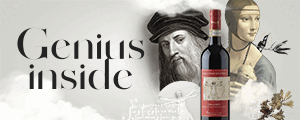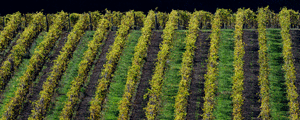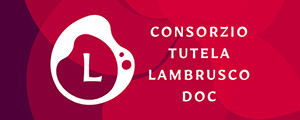Il Chianti è più toscano se lo fa uno straniero. Vengono dal nord Europa ma persino da Stati Uniti e Australia. Sbarcano in Italia con un chiodo fisso: quel Doc unico al mondo. E oggi lavorano come enologi nelle maggiori case produttrici. Effetto della globalizzazione? Sì, ma la bottiglia ci guadagna … Greve in Chianti. E poi che ne sanno, loro, di come si fa il Chianti?. Certo, a berlo sono capaci: bella forza. Sono anche capaci di comprarsi a suon di dollari le ville, i terreni, le case coloniche, come fanno ormai da cinquant’anni, trasformando questo pezzo d’Italia benedetto dal Signore nell’ibrido divenuto famoso col nome di Chiantishire. Sono capaci di comprarsi le vigne e le aziende. Ma è davvero difficile immaginare che possano capire qualcosa dell’alchimia per cui il Sangiovese di queste colline matura fermenta e invecchia fino a diventare uno dei vini più famosi del mondo. Che diavolo sapranno mai, di questo miracolo, yankees e inglesi, australiani, filandosi e svizzeri? Sapranno al massimo come si fa la birra.
Invece no. Justin Budd è australiano di Melbourne. Sean O’Callaghan è un mezzo irlandese nato a Cylon. Tim manning è inglese. Alyson Morgan è californiana di Mendocino. E come loro ce ne sono sempre di più. Arrivano con le idee chiare, la laurea in enologia in tasca, qualche anno già speso in giro per il mondo a coltivare Cabernet o Pinot Nero, ma con in testa una fissa: il Chianti e il suo vino. Un’uva severa e difficile: «Col Sangiovese non si scherza» dice O’Callaghan. «Se ha troppo sole, se ne ha troppo poco, se la pianta è troppo carica o troppo leggera … Ma proprio per questo quando arrivano in fondo è una vittoria». Lavorano per chi capita: piccoli produttori italiani di qualità o multinazionali del vino sbarcante in Toscana. Assimilano tutto, ma non si adeguano. Il vino per loro non è retaggio secolare. E’ una faccenda nuova, è una tecnica che si evolve e muta senza timori reverenziali.
Attraversare il Chianti alla ricerca degli enologi venuti da lontano costituisce un viaggio in più tappe, che parte da Greve e arriva fino alla provincia di Siena. Ma è anche un viaggio dentro un mondo radicalmente diverso di rapportarsi con il vino. La banale questione del tappo riassume bene questa mancanza di rispetto per le tradizioni. Nelle occasioni istituzionali, la legione straniera del Sangiovese si guarda bene dal mettere in discussione il tappo di sughero. Ma uno per uno, faccia a faccia, dopo due bicchieri di quello buono, vanno giù senza diplomazia. E giurano che quel cilindro di legno ha i giorni contati, ed è un bene che sia così. «Io sono convinto che un vino destinato ad essere bevuto nel giro di tre o quattro anni non perda assolutamente nulla se viene chiuso con un tappo di silicone» sostiene Bubb. «Anzi, credo che ci guadagni in freschezza, in pulizia. Questa bottiglia viene dall’Australia, è uno Shiraz Platinum, costa 80 euro. Ed è chiusa col tappo a vite. Da noi è normale». E io credo che presto e sarà così anche qui in Europa» aggiunge O’Callaghan. «Certo, convincere cantine come Chateaux Margaux ad abbandonare il sughero sarà difficile. Ma alla fine il sughero resterà solo nella fascia più alta e solo per una questione di immagine».
Alcuni sono qua da tempo, e parlano un bizzarro argot che mescola italiano, toscanismi e inglese. Altri sono sbarcati da poco, ma si muovono con dimestichezza nelle vigne e tra le botti. «Il Chianti è straordinario perché ogni collina ha il suo clima e fa un’uva diversa» spiega Alyson Morgan.
Non faticano a trovare lavoro. Perché, come per altri mestieri, la concorrenza italiana latita. «Inoltre questa è una zona a tradizione mezzadrie, dove solo le ultime generazioni hanno smesso di lavorare sotto padrone. E ai giovani lavorare per le aziende vinicole sembra di tornare indietro» racconta Antonio Cavallini, nella cui tenuta di Montefiridolfi lavora Tim Manning.
Una manciata di chilometri più in là, Ivano Reali governa con piglio da manager la tenuta di Gabbiano, finita qualche anno fa nel portafoglio del colosso austral-americano Beringer. Il 95 per cento del Chianti che si fa nella sua tenuta finisce sul mercato Usa: «Ma non è per questo che mi piace lavorare con ragazzi stranieri» dice Reali. «C’è una differenza di disponibilità, mi capita di passare di qua la domenica mattina e trovare Justin che è nella vigna o in cantina a lavorare di sua iniziativa. E poi, se uno vien fin dall’Australia è perché è pieno di curiosità, di voglia di imparare, non è convito di sapere già tutto». Qualcuno è arrivato per stare due mesi e non si è più mosso. Racconta Sean O’Callaghan: «Io sono qui da tredici anni. Tredici vendemmie: ognuna diversa dall’altra, quella più calda, quella più fredda, quella più piovosa. Il vino queste cose le racconta, e quando stappo una vecchia bottiglia il suo sapore mi racconta il tempo di quell’estate. La mia cantina è il mio diario».
In Sicilia intanto sbarcano i più bei nomi del Nord
Da Zonin a Missoni e Gancia, tutti pazzi per il Nero d’Avola. Si parla il dialetto veneto da qualche anno nella campagne siciliane. I grandi viticoltori del nordest hanno acquistato centinaia di ettari nell’isola per produrre vini di grande pregio, di buona gradazione e, soprattutto, a costi vantaggiosi. Una scelta competitiva che sta mettendo in seria difficoltà i produttori siciliani (il 70 per cento del vino che viene ancora venduto sfuso). Il primo a sbarcare è stato Gianni Zonin. A Riesi, non lontano da Caltanisetta, ha comprato il feudo dei principi di Butera, 250 ettari di vigneti e uliveti per 50 miliardi delle vecchie lire: ogni anno produce un milione di bottiglie di Nero d’Avola, un business che sfiora i cinque milioni di euro. «oggi viene premiata l’azienda che lavora meglio e che produce vini secondo le richieste dei consumatori» dice Zonin. Stessa filosofia per il gruppo trentino MezzaCorona, che in piena Valle del Belice, a Sambuca di Sicilia, ha reimpiantato 280 ettari di vigneti nel Feudo Arancio. Un «mal d’isola» che ha contagiato anche le griffe della moda, come Paolo Marzotto (vigneti di Gela, Piana degli Albanesi e Pachino, coltivati a Merlot, Nero d’Avola e Bordeaux) e Giampiero Jelmini (fratello di Rosita Missoni, che ha fondato la società di Baglio delle Cicale nella zona di Campobello di Mazzara). Sono arrivati anche i piemontesi: a Trapani la famiglia Gancia ha acquistato 50 ettari. Il business c’è: vini di buona qualità anche a meno di 4 euro al litro per sfidare la concorrenza dei vini argentini, cileni, sudafricani, neozelandesi sui mercati internazionali. Ma per i piccoli viticoltori siciliani è una mazzata. «Il prezzo dell’uva è crollato a causa della saturazione del mercato» spiega Vincenzo Micheli, uno dei soci della Cantina Colle Acre di Palazzolo Acreide, nella Val di Noto. «Abbiamo le botti stracolme di vino di ottima qualità. Ma non possiamo competere con i prezzi “colonizzatori” del Nord».
Copyright © 2000/2024
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2024