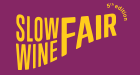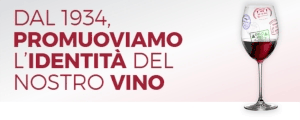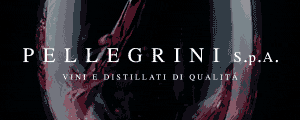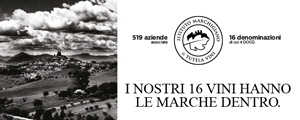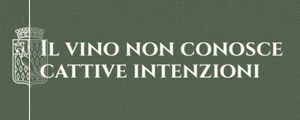Da un calo fino al 70% di grano in alcune aree del Mezzogiorno al rischio di un raccolto dimezzato delle olive in Puglia, la prima regione in Italia per produzione di olio di oliva. Ed ancora, il 95% del miele che se ne va in Sicilia, con posti di lavoro andati persi - la stima è di 33.000 nel primo trimestre dell’anno - e animali che soffrono per la mancanza di foraggio. E, ovviamente, il rischio che le campagne si svuotino perché improduttive. La siccità sta generando una serie di problematiche ad uno dei settori trainanti dell’economia italiana con i casi più drammatici che si concentrano nel Sud della Penisola.
Le riserve idriche sono in carenza, la mancanza di piogge che ha caratterizzato queste zone si è fatta sentire incidendo sulle produzioni. “Quanto si sta registrando in Sicilia, ma che progressivamente sta risalendo dal Meridione all’Italia centrale, ha caratteristiche peggiori delle scorse, grandi siccità del Nord, ma sta incontrando una minore attenzione dell’opinione pubblica: mai era successo di dover abbattere capi animali per l’impossibilità di alimentarli e dissetarli. Purtroppo ci stiamo assuefacendo alla cultura del disastro”. Queste le parole di Francesco Vincenzi, presidente Anbi, l’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue. In Sicilia i problemi dei bacini idrici hanno il loro peso. Secondo quanto pubblicato dall’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia al 27 maggio, riporta l’Anbi, dei 288,95 milioni di metri cubi allora trattenuti dalle 29 dighe dell’Isola, l’acqua realmente disponibile nei bacini (dalla capacità già ridotta dall’incuria per la grande presenza di sedime sui fondali) era poco più della metà (154,23 milioni di metri cubi), dovendo sottrarre, ad esempio, i volumi destinati alla sopravvivenza dell’ittiofauna, quelli di sicurezza dell’invaso e quelli destinati ad un’accelerata evaporazione. Massimo Gargano, dg Anbi ha parlato di “un allarme rosso per la grande aridità, anticipatrice della desertificazione, su oltre il 50% dei territori in Sicilia, Puglia e Basilicata, cui aggiungere zone costiere di Calabria e Sardegna, nonché zone localizzate lungo la dorsale appenninica e la fascia adriatica”. La gravità della situazione idrica nell’Italia Centro-meridionale sarà al centro, tra l’altro, dell’appuntamento del 25 giugno a Roma in occasione della presentazione dell’Assemblea Anbi.
Il problema, quindi, non è solo al Sud Italia, ma anche in altre regioni, soprattutto del Centro. In Umbria continua, infatti, a ridursi l’altezza idrometrica del Lago Trasimeno, il più esteso dell’Italia centrale, che ora è 15 centimetri sotto il livello minimo vitale, 25 centimetri più basso dell’anno scorso e 82 centimetri sotto la media storica; nel Lazio, il fiume Tevere è a poco più del 55% della portata media del periodo; in Abruzzo le altezze idrometriche dei fiumi Sangro nell’aquilano, Orta nel pescarese e Vomano nel teramano sono già in linea con quelle, che si registravano in pieno agosto 2023 e le riserve idriche sono ai minimi; in Basilicata (dove c’è chi rinuncia alla trebbiatura, ndr) gli invasi ormai trattengono meno di 300 milioni di metri cubi d’acqua, il 40% della capacità totale, e in una settimana hanno rilasciato oltre 9 milioni di metri cubi ed il deficit con il 2023 si è ampliato di ulteriori 17 milioni di metri cubi; in Puglia, nel confronto con l’anno scorso, è disponibile meno della metà delle riserve d’acqua: dagli invasi fuoriescono circa 1,4 milioni di metri cubi al giorno ed è prevedibile che la situazione si aggraverà con l’annunciata impennata delle temperature. Questi sono solo alcune situazioni delicate riportate nel report dell’Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche che ricalca la situazione delle settimane più recenti.
Coldiretti, sulla base dei dati Istat relativi all’occupazione nel primo trimestre 2024, ha sottolineato che la siccità ha bruciato 33.000 posti di lavoro nei campi del Sud, tra Sicilia e Puglia, con il caldo record e la mancanza di pioggia che hanno impedito le principali operazioni colturali. Per la Community Valore Acqua per l’Italia di The European House - Ambrosetti, l’Italia è il quarto Paese dell’Unione Europea per stress idrico, con un indice di 3,3 su 5. Solo Belgio (4,4), Grecia (4,3) e Spagna (3,9) presentano valori peggiori. E intanto sono già 12 le regioni italiane ad elevato stress idrico: Basilicata, Calabria, Sicilia, Puglia sono le più esposte, daavanti a Campania, Lazio, Marche e Umbria, Toscana, Molise, Sardegna e Abruzzo. Dunque serve agire per salvare il salvabile e pensare al futuro. Si è parlato di opere, investimenti finanziari e legislativi infrastrutturali per un valore totale pari a 17,6 miliardi annui per i prossimi dieci anni per poter tutelare la risorsa idrica Italiana e la salvaguardia del territorio: questo uno dei tanti temi del Rapporto Nazionale “Water Intelligence” dell’Osservatorio Proger presentato in collaborazione con l’associazione italiadecide, in questi giorni, nella Sala Serpieri di Confagricoltura a Roma. Il costo della siccità morde e morderà ancora di più in futuro: si calcolano oltre 30 miliardi di euro complessivi negli ultimi vent’anni per gli esborsi pubblici legati a stati di emergenza e ristori alle categorie colpite. La siccità, nella sola agricoltura, ha fatto perdere lo 0,10% del Pil. “Il cambiamento climatico - ha commentato il presidente Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - incide su più fronti: sta stravolgendo i ritmi della coltivazione, rendendo necessaria una ridefinizione della mappa del cibo a livello globale, ma causa anche effetti importanti sulle coltivazioni, con eccesso o penuria di acqua e conseguenti ricadute sulla produzione e sulla filiera, fino a incidere sui prezzi finali al consumatore. La gestione dell’acqua è pertanto un tema nevralgico per le imprese agricole. In questo senso vengono in aiuto le nuove tecnologie, la scienza e la ricerca, ad esempio attraverso le tecniche di evoluzione assistita per rendere le piante resistenti agli effetti del cambiamento climatico: su questo dobbiamo investire, affinché non manchi mai il cibo dalla natura”. Per Marco Lombardi, ad Proger e presidente Osservatorio, “oltre il 60% della rete idrica ha più di 30 anni, il 25% più di 50 anni: su 34,2 miliardi di m3 prelevati ne arrivano a destinazione solo 26,6 (77%). La nostra rete perde 7,6 miliardi di metri cubi all’anno (23%). Forti piogge al nord ed estrema siccità al sud, la situazione attuale riflette perfettamente l’emergenza e soprattutto la carenza di infrastrutture e di progettazione. In Italia l’acqua non manca ma non arriva a destinazione perché la rete idrica infrastrutturale non è adeguata e si sono accumulate carenze di investimenti in tecnologia applicata ai servizi idrici. C’è tantissimo “know-how” ma pochissima cultura: la cultura si riflette nei comportamenti, nelle scelte consapevoli e nelle azioni quotidiane, nella politica di un Paese. Serve una gestione più sostenibile anche grazie alle reti neurali e l’Artificial intelligence, attraverso consumi inferiori e meno sprechi. Questa carenza dovrebbe figurare tra le massime priorità sia della politica, sia delle imprese. Necessitiamo di una sensibilità sociale nei confronti delle risorse idriche, manca la visione, non si può intervenire sull’emergenza bisogna pianificare un piano strutturale a 10 anni per tutelare questa preziosa risorsa”.
La proposta del rapporto Water Intelligence, parla di 13,8 miliardi che dovrebbero andare alla gestione dell’acqua: tra cui 7 miliardi per il servizio idrico integrato; 1,8 miliardi per 20 nuove dighe; 5.000 piccoli e medi invasi; 1 miliardo per il disinterramento delle dighe; 1 miliardo per l’aumento della produzione idroelettrica. E poi 3,85 miliardi agli interventi contro il dissesto idrogeologico: 2,5 miliardi per le misure per la difesa del territorio, 1,5 miliardi per rafforzare tecnologie, monitoraggi e ricerca. Water intelligence si pone come spunto di riflessione sull’assoluta necessità di un “Piano nazionale integrato per la sicurezza idrica e idrogeologica”, tema questo su cui Proger, società di ingegneria multidisciplinare, è impegnata da anni per la divulgazione e diffusione di una cultura del settore.
Copyright © 2000/2026
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026