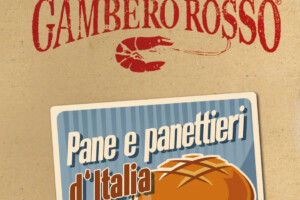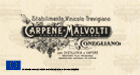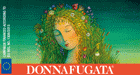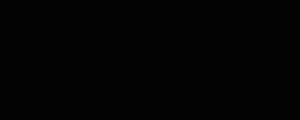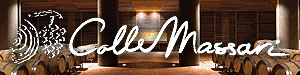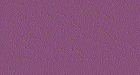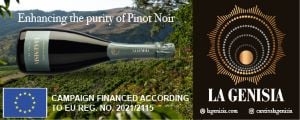Nonostante la specie umana sia biologicamente onnivora, gli individui non mangiano tutto, ma scelgono cosa mangiare. Da cosa deriva, quindi, la scelta di mangiare solo o prevalentemente vegetali? Queste preferenze sono determinate dalla cultura, che tuttavia cambia nello spazio e nel tempo, seguendo principi economici, simbolici, ideologici, etici, filosofici e religiosi. Massimo Montanari, professore emerito dell’Università di Bologna, dove ha fondato e dirige il Master “Storia e cultura dell’alimentazione”, il 26 maggio rifletterà sulla storia del vegetarianismo nell’incontro “Senza carne. Perché abbiamo imparato a essere (anche) vegetariani?”, all’interno dei “Dialoghi di Pistoia”, il festival di antropologia del contemporaneo ideato e diretto da Giulia Cogoli (24-26 maggio). “Siamo ciò che mangiamo? Nutrire il corpo e la mente” è il tema che guida le riflessioni dei relatori che approfondiranno la relazione tra gli esseri umani e il cibo, indagando le modalità con cui, nel tempo, ogni società costruisce e trasforma la propria idea di gusto condiviso. Oltre a Montanari, interverrà anche Luisa Stagi, docente presso l’Università di Genova, sul tema “Food porn e dieta. La nuova comunicazione del cibo”, trattando dell’ossessione per la cucina e per l’estetica degli alimenti, fenomeno sempre più diffuso nella nostra società, nonostante la maggior parte delle persone sia costantemente a dieta.
Montanari ha anticipato alcuni contenuti del suo intervento su “Il Sole 24 Ore”, spiegando come il vegetarianismo abbia avuto dapprima motivazioni religiose, poi salutistiche e infine, ai nostri giorni, anche ambientaliste.
Citando il “paradosso dell’onnivoro” (a cui è intitolato un libro di Claude Fischler), Montanari scrive che “l’uomo può mangiare di tutto e perciò non mangia tutto, ma (appunto) sceglie. Sempre che uno stato di necessità - limitatezza di risorse, povertà, evento eccezionale, ecc - non limiti o addirittura cancelli la libertà di scegliere. Se ci chiediamo il perché della scelta vegetariana - scrive Montanari - ci imbattiamo in motivazioni complesse, che facilmente si intrecciano e si confondono. In ogni caso si tratta di motivazioni culturali, anche quando amano dirsi “naturali” o “originarie”.
Per esempio, certi monaci o asceti medievali rappresentavano la dieta vegetariana come una sorta di ritorno al Paradiso terrestre, quando gli uomini, ancora puri e incorrotti, vivevano di sole erbe e frutti. Così racconta la Bibbia, e storie analoghe si leggono nella mitologia classica dell’Età dell’oro, quando gli uomini erano felicemente vegetariani e non conoscevano la violenza.
Ecco il punto: la violenza. Alla base della scelta vegetariana c’è il rifiuto della violenza. Ma ciò presuppone un’idea della vita che tenga insieme gli esseri viventi senza gerarchie. Gli uomini devono essere pensati come animali tra gli altri.
Le tradizioni di pensiero che presuppongono una barriera, una distanza invalicabile fra uomini e animali non favoriscono la scelta vegetariana. L’imbarazzo, il disagio (che comunque esiste) del mettere a morte un essere vivente in tal caso si risolve in modo diverso. Tutte le culture antiche di area mediterranea sacralizzarono l’uccisione dell’animale attraverso il rito del sacrificio, che de-colpevolizza la violenza del gesto.Cosi nella tradizione ebraica. Cosi nel mondo greco e romano, dove la pratica del sacrificio era il perno di una religione pubblica dai forti connotati politici. Rifiutarla, come fecero alcuni filosofi, fu anche un modo per estraniarsi dalle logiche del potere e dalle convenzioni sociali. In un mondo in cui il pensiero dominante dava per scontato che la vita degli animali non vale quanto la vita degli uomini - su questo concordavano Aristotele e la Bibbia - la scelta vegetariana era fuori corrente, decisamente eccentrica”.
“Eppure un pensiero animalista - scrive Montanari - percorre tutta la cultura antica. La tradizione greca insiste sul nome di Pitagora: nessun suo scritto è rimasto, ma a lui si riferiscono autori di secoli successivi, come Plutarco o Porfirio, quale primo assertore di un regime vegetariano fondato sul rispetto degli animali. “Dieta pitagorica” o “vitto pitagorico” si chiamerà ancora in età moderna.
L’opzione animalista, fondata sul rispetto della vita universale che percorre l’universo, compare in modo più coerente e sistematico - e socialmente diffuso - nelle filosofie e religioni orientali, talvolta legata al principio della metempsicosi, il fluire della vita da un essere all’altro, uomini e altri animali indifferentemente. Già nel primo millennio a.C. essa definisce la tradizione indiana, sia nella versione rigorosamente inflessibile del giainismo, sia in quella più morbida del buddismo. In ogni caso è questa idea a sostenere la maggior parte delle scelte vegetariane in età antica. In ambito cristiano cambia la prospettiva. L’animalismo non è ammesso (come spiega bene Agostino, il comandamento divino di “non uccidere” riguarda solo gli umani) e la scelta di non mangiare carne si giustifica con considerazioni diverse, focalizzate sul soggetto e non sull’oggetto, sul mangiante e non sul mangiato. Rinunciare alla carne non è un modo per rispettare gli animali bensì per fare penitenza, per mortificare il corpo rinunciando al piacere del cibo. Precisi obblighi alimentari scandiscono l’anno liturgico, imponendo il “mangiare magro” in certi giorni della settimana o periodi dell’anno. I monaci, che alla carne rinunciano con maggiore sistematicità, elaborano anche l’idea che, in fin dei conti, la dieta vegetale sia più salubre per il corpo.
Il tema della salute trova particolare enfasi in età moderna, a mano a mano che si affievolisce la tensione filosofica e/o religiosa di quella scelta - che però non è mai venuta meno. L’utilità o necessità di un “vitto pitagorico” fu sostenuta da numerosi medici, come l’inglese George Cheyne o l’italiano Antonio Cocchi: più recentemente ha dato vita a un vero boom salutistico, con relativo business.
Intanto è apparso, dapprima occasionalmente poi in modo più impetuoso, un terzo genere di motivazione: l’ambientalismo. Sconosciuta nel mondo antico e fin quasi ai giorni nostri, l’idea che prediligere il cibo vegetale sia un modo per contribuire alla difesa o al recupero degli equilibri territoriali e climatici si è fatta strada parallelamente alla consapevolezza che l’azione dell’uomo è decisiva per il futuro del pianeta. A questo punto la scelta assume una prospettiva globale: non è più solo a favore della vita animale o del benessere umano; è per la sopravvivenza del nostro mondo e di coloro che lo abitano. Ormai uscito dalla dimensione eccentrica che per secoli lo aveva caratterizzato, il pensiero vegetariano ha assunto una posizione culturalmente centrale” conclude Montanari.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025