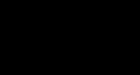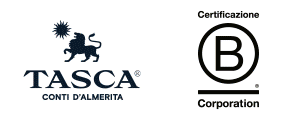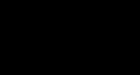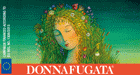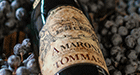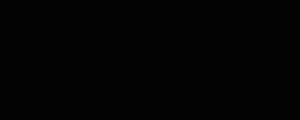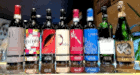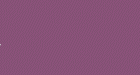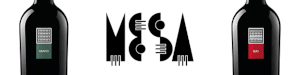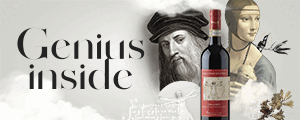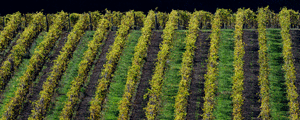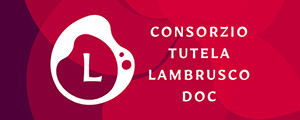Economia - Lo “sboom” del vino italiano. Abbasso i calici, c’è poco da brindare. L’export in calo. La concorrenza di Australia e Cile. E i prezzi alti, l’euro forte, la “sindrome del pinot grigio”… Così, quello che fino a poco tempo fa era un gioiello del made in Italy sta diventando un caso di studio per capirne i problemi. E cercare di risolverli ... “Guardi, nel mondo del vino la sbornia è finita. Non è mia: il copyright è di un amico produttore. Però rende l’idea”. Chissà se solo un anno fa Gianni Zonin, uno dei signori delle vigne italiane (12 tenute, un’ottantina di milioni di fatturato), immaginava che avrebbe dovuto usare battute del genere, per raccontare cosa succede nelle cantine italiane. Eppure il controfenomeno è lì, anche se finora se n’è parlato poco: meno brindisi, calici in basso, moda sbiadita. In una parola, sboom. Nel 2003 l’export si è avvitato: meno 16,6% in volume, meno 5% in valore. Due milioni di ettolitri evaporati, tra rossi (-21,6%) e bianchi (-14%). E con picchi da brividi, tipo il “25” in Germania, che finiscono per cancellare la tenuta nei mercati più stabili (Stati Uniti e Gran Bretagna) e la crescita bollente in posti come la Russia (+54%), dove esportiamo ancora troppo poco. Metterci pure il calo dei consumi interni (da 862 a 857 milioni di litri, dai Ismea-Nielsen), più pesante per Doc e Docg (meno 6%), e la limatura dei prezzi spuntati da certi SuperTuscans nelle aste internazionali (oggi si battono anche al 20% in meno), e il risultato è semplice: crisi, appunto. In un settore che vale 8 miliardi e mezzo, mica spiccioli.
Meglio parlarne, allora. E non solo perché tra qualche giorno apre Vinitaly, la grande fiera di settore (Verona 1/5 aprile) che tra breve sarà affiancata da un altro salone per addetti ai lavori (MiWine, Milano, 14/16 giugno), doppia occasione per un’autoanalisi di gruppo. Nello sboom del vino c’è di più. Anzi, a guardare bene il bicchiere in controluce ci si trovano dentro, concentrati, molti dei malanni del made in Italy di oggi. Al punto che passarli in rassegna è come fare un ripasso veloce di tante analisi lette in questi mesi a proposito del declino, industriale e no.
Partiamo dal nanismo, tara genetica delle imprese nostrane. Nel vino è distillato fino all’essenza. Le aziende che producono uva sono 800.000. L’ampiezza media delle tenute un ettaro e qualcosa. Briciole, in confronto a multinazionali quotate in Borsa come l’americana Mondavi o l’australiana Hardy. Certo, il modello semiartigianale dà l’idea di prodotti più raffinati. E in parte è vero. Poi, però, scopri che Paesi come l’Australia o la Nuova Zelanda, dove tre o quattro aziende controllano i due terzi della produzione, ci hanno scalzato dal podio delle vendite in Gran Bretagna e minacciano di farlo negli Usa. Mentre le bottiglie di major globali, come la californiana Gallo o la cilena Tarapacà, ormai sono presenze fisse pure sugli scaffali italiani. Tradotto in strategie industriali vuol dire economie di scala, marketing massiccio, mega accordi con distributori. Mercato, insomma. “Prenda l’Australia, l’esempio principe”, spiega Ezio Rivella, enologo storico e presidente dell’Unione Italiana Vini: “Lì negli anni Ottanta non si produceva una sola bottiglia di qualità. Oggi, invece, esportano l’80 per cento del prodotto”. Merito di vini di buon livello, basati su vitigni comuni (Chardonnay, Cabernet e Shiraz) e abbordabili per tutti i gusti. “Ma anche in un modello di business concentrato in poche mani, che parte dal mercato e organizza la produzione di conseguenza”. Prego? “Gli australiani si presentano agli importatori e chiedono: di che vino avete bisogno e a che prezzo? Si mettono d’accordo, e due anni dopo eccoli con una valanga di bottiglie. Noi, invece, siamo lì a trastullarci con i vitigni autoctoni. Perfetti per prodotti di nicchia, ma non per il mercato internazionale. A meno di non voler fare la fine del pinot grigio”. Che gli è successo, scusi? “Era un vitigno italiano per definizione. Ora lo fanno in California e Cile”.
E qui siamo al secondo difetto. In parole grosse, “mancanza di politica industriale”. In pratica, poche strategie comuni, approccio in ordine sparso alla grande distribuzione (altra chiave di lettura dimenticata, ma pesante: quali vini promuoverà una cantina francese che sbarca a Mosca o Shanghai?) e ritardi pure di fronte al problema dei falsi, dei pirati che copiano i nomi Sfurzat o Recioto appiccicandoli a bottiglie prodotte dall’altra parte del mondo. Certo, su questo punto ha calato le braghe persino l’Unione Europea. Ma perché i nostri consorzi (con poche eccezioni) si stanno muovendo solo ora per registrare i nomi dei vini come marchi e proteggerli dalla concorrenza sleale?
Concorrenza. Eccolo lì, il terzo problema: i Paesi emergenti. Australia e Cile, appunto. Ma anche Sudafrica, Nuova Zelanda, Argentina. A medio termine persino la Cina (produce anche lei, e il resto del mondo se ne accorgerà presto).
Non danno fastidio solo a noi, se è vero che anche i francesi se la passano male (meno 9% di export). Però picchiano duro. Proprio come succede nel tessile, nelle scarpe o nella meccanica. Solo che qui non è tanto questione di manodopera a basso costo”. “E’ che i nostri concorrenti sono più liberi”, spiega Zonin: “Hanno meno regole. Possono impiantare quando e dove vogliono. L’Australia produce 10 milioni di ettolitri l’anno. Il Sudafrica quasi altrettanti. Il Cile è arrivato a 6. Crescono al ritmo di un milione l’anno. Noi in Europa abbiamo il blocco degli impianti fino al 2010. E per fare una bottiglia ci vuole più carta bollata che vino”. Conclusion? “E’ come se ci legassero i piedi e poi ci chiedessero di correre”. Vero ma non basta. Legacci o no, i produttori italiani, in media, hanno fatto una scelta: puntare su listini e margini alti. E presidiare poco o nulla la fascia media, quella con il famoso “buon rapporto qualità-prezzo” su cui i nuovi arrivati, invece, hanno sfondato. Scelta rischiosa. Soprattutto quando l’aria si fa grama e i clienti devono tirare la cinghia.
Così si arriva dritti all’ultimo guaio, quello che i consumatori notano per primo: i prezzi. Negli ultimi tempi sono cresciuti troppo. Trenta, quaranta euro a bottiglia per un Amarone qualsiasi, una ventina di Chianti che ve valevano sì e no un quarto ... cifre già stonate in enoteca. Figuratevi quando, come denuncia Giovanni Ricasoli Firidolfi, presidente del Consorzio marchio storico Chianti Classico, “un ristorante le ricarica pure cinque volte tanto”. Ovvio, impossibile generalizzare. Ma il risultato è che la bolla speculativa sta scoppiando. Anche perché chi beve si è fatto più attento: ”Si è accorto che non sempre i vini più cari sono i migliori”, osserva Zonin. E si è accorto pure della mossa fatta da molti negozi e ristoranti: euro cambiato a mille lire e prezzi raddoppiati. Aggiungeteci che l’euro forte si porta via pure l’ultimo sprazzo di aiuto all’export via svalutazione (altra leva molto usata dalle nostre aziende quando ancora esisteva la lira), e il quadro è completo.
I rimedi, allora? Il primo è scontato: calmierare i prezzi. E in fretta. “Ma gestendoli con intelligenza, lavorando al ribasso: le perderemmo comunque, in un campo dove gli avversari hanno meno vincoli e legacci”, dice Francesco Mazzei, storico produttore di Chianti (Castello di Fonterutoli). Poi, appunto, le regole. “Vanno snellite” dice Zonin: “O liberalizziamo anche da noi, o mettiamo limiti alle quote dei produttori extraeuropei. Bisogna trovare un equilibrio tra domanda e offerta. E per farlo serve una regia globale, non solo europea”. Se non siamo alla richiesta tremontiana di dazi sul “made in China”, poco ci manca. Eppure proprio Cina, India, Russia ed Est Europa potrebbero essere i prossimi mercati su cui puntare decisi, a caccia di neoricchi. Ch ci sta già provando, soprattutto a Mosca (un nome per tutti: Gancia), si è già tolto parecchie soddisfazioni. Ma fiere ed expo sono in arrivo anche più a Oriente. Seervono, se ci si muove compatti: “Bisogna mettersi insieme e fare consorzi di acquisto e distribuzione che consentono taglio dei costi, massa critica e varietà di offerta”, dice Mazzei.
Il resto lo fa la fantasia. E operazioni di neomarketing che cercano di sollecitare nuovi tasti del “consumatore più attento”. Al Vinitaly la marchigiana Umani Ronchi (11 milioni di fatturato) lancia le “bottiglie solidali”: il 5% dell’utile sarà devoluto a un progetto di solidarietà. Caprai, invece (4,6 milioni), mette in pista la poesia: stamperà versi celebri sui tappi di un’edizione speciale di Sagrantino. Uno è di Goethe: “la vita è troppo breve per bere vini mediocri”. Perfetto. Ma chi lo spiega ai clienti? (arretrato de "Sette - Corriere della Sera" del 25 marzo 2004)
Copyright © 2000/2024
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2024