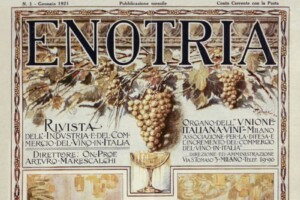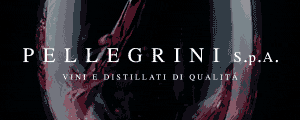“Essere o non essere” era il dubbio esistenziale declamato da Amleto nell’opera di William Shakespeare. E ora, “cambiare o aspettare”, più prosaicamente parlando, è quello che si chiede il mondo del vino, che, come tanti altri prodotti, si trova davanti ad una società e ad uno scenario mondiale che cambiano a ritmi mai visti prima. In una fase in cui, tra mille dubbi, è sempre più chiara la ricerca di “leggerezza”, quando ci si riferisce al vino. Dal punto di vista del grado alcolico, certamente, ma anche dal punto di vista del prezzo, così come dell’approccio e del linguaggio. Come emerge, tra le altre cose, dalla riflessione del professor Gianni Moriani, storico della cucina e del paesaggio agrario italiani, con il quale WineNews si confronta spesso su molti temi, secondo il quale “siamo entrati nell’epoca dei vini leggeri”.
“Il settore vinicolo globale sta affrontando una crisi profonda - scrive Moriani - determinata da un insieme di fattori: il calo costante dei consumi, le sfide legate al cambiamento climatico, i crescenti allarmi sanitari, i dazi commerciali e l’instabilità economica. Di fronte a questa situazione, l’industria si interroga su come reagire: attendere un’inversione di tendenza o cambiare radicalmente approccio? Secondo Eric Asimov, autorevole critico del “New York Times”, la complessità della situazione nasce anche dalla frammentazione della società. Esistono due grandi categorie di consumatori: una maggioranza disinteressata all’origine o alla qualità del vino, attratta solo da bevande alcoliche piacevoli e non esose, e una minoranza appassionata, disposta a spendere di più per vini premium. In mezzo, molte sfumature, ma la tendenza generale è che si beve meno e meglio”.
Ma, nella sua riflessione, Moriani sottolinea come “anche la produzione riflette questa dicotomia. Da un lato, grandi aziende multinazionali ben finanziate e resilienti alle crisi; dall’altro, migliaia di piccole imprese familiari, che pur essendo più vulnerabili, rappresentano l’anima culturale e innovativa del vino, come nella lingua è il dialetto. Negli ultimi decenni, sono proprio questi piccoli produttori ad aver sostenuto e rilanciato l’identità agricola e artigianale del vino - sottolinea il professore - contro l’omologazione industriale. La crisi si fa sentire soprattutto nella fascia più bassa del mercato. I vini senza carattere né radici culturali, da qualche euro, sono in forte declino. Al contrario, i vini di qualità reggono meglio, anche se non sono immuni alle difficoltà: i cambiamenti climatici, con incendi, grandinate e gelate, colpiscono duramente i vigneti, e i piccoli produttori faticano a sopravvivere. Su questo terreno già accidentato, sono ora piombati i dazi, ostacolando l’export, vitale per il vino italiano. Come può reagire il settore? Asimov propone alcune soluzioni concrete. Anzitutto, semplificare l’offerta: oggi si produce più vino di quanto se ne consumi, e un ridimensionamento delle rese, potrebbe aiutare a mantenere sostenibilità e qualità. Poi, abbassare i prezzi: il vino è diventato troppo costoso per le giovani generazioni. Serve una fascia di vini accessibili, sotto i 10 euro al dettaglio, senza rinunciare alla qualità e all’impegno ambientale. Alcuni produttori hanno già intrapreso questa strada”.
Ma non basta, sottolinea Moriani, perché c’è un altro aspetto fondamentale. “Infine, eliminare lo snobismo: molti evitano il vino - scrive il professore - perché lo percepiscono come un mondo elitario e difficile da comprendere. In quanto il vino, da sempre strumento di convivialità, è stato snaturato e trasformato in fine a sé stesso, complice un marketing aberrante che ha creato la cosiddetta “bolla del vino”, gonfiata con nuvole di improbabili sentori e da un cumulo di vacue parole. La più clamorosamente assurda? L’invenzione dei fantomatici “vini da meditazione”: vini strutturati e fortemente alcolici che, più che favorire la meditazione, ti mandano fuori di testa e, se ti azzardi a metterti al volante, rischiano di mandarti fuori strada. Invece, il settore dovrebbe concentrarsi meno sull’educazione forzata e più sul piacere, sull’emozione e sulla convivialità che il vino può offrire. I migliori wine bar oggi attraggono giovani proprio perché offrono esperienze rilassate e inclusive, senza intimidazioni culturali. I produttori devono prendere atto che siamo entrati nell’epoca dei “vini leggeri”, in ogni senso. Il futuro del vino non dipenderà da strategie di marketing su larga scala - sostiene Moriani - ma dalla sua capacità di rimanere rilevante, accessibile e autentico. Se saprà valorizzare i suoi punti di forza - il legame con la terra, il piacere della condivisione e la qualità artigianale - potrà continuare ad avere un posto importante nella convivialità”.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025