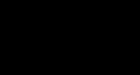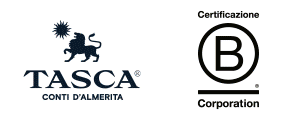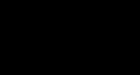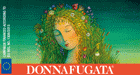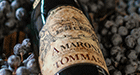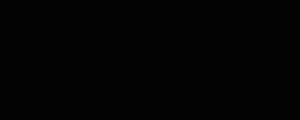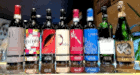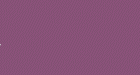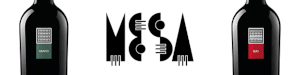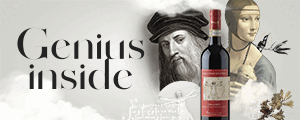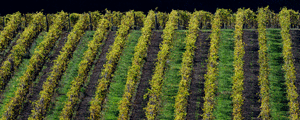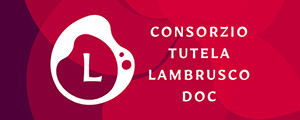Trucchi nascosti nel piatto ... Prodotti tipici Grano australiano nella pasta, maiale danese nella mortadella, bovino brasiliano nella bresaola... è legale? E il cibo che mangiamo è almeno sano?... Antipasto di affettati misti: bresaola della Valtellina, mortadella bolognese e prosciutto cotto. A seguire un bel piatto di pasta (quella di grano duro che tiene bene la cottura) al sugo. Poi salsiccia con fagioli all’uccelletto. E per chiudere un po’ di formaggio. Pranzo all’italiana? Macché, cucina fusion, globalizzata. Perché senza nemmeno sospettarlo vi siete appena ingozzati con prodotti cinesi, australiani, brasiliani, danesi e spagnoli. Alla faccia del cibo “made in Italy”.
E non pensiate che si tratti di una faccenda di nicchia o marginale. Secondo un recente studio della Coldiretti, infatti, oltre la metà dei soldi spesi dai consumatori per riempire il carrello serve per acquistare “prodotti dei quali non è possibile conoscere la provenienza per mancanza di trasparenza nelle etichette”. E attenzione: non stiamo parlando di truffe (che pure ci sono, ma questa è un’altra storia). Si tratta semplicemente di una colossale presa per i fondelli, peraltro perfettamente lecita. Ai danni di due categorie: i piccoli produttori agricoli, che in un mercato agro alimentare sempre più globalizzato rischiano di restare stritolati; e ovviamente i consumatori, che pagano sempre più caro ma non sanno che cosa mettono in tavola ogni giorno.
Il caso della bresaola della Valtellina è emblematico di questo andazzo. Il 31gennaio scorso il commissario europeo alla Salute, Markos Kyprianu, ha firmato un decreto per bloccare l’importazione in Europa di carne bovina brasiliana. Motivo: nessun allevamento carioca soddisfa i requisiti minimi richiesti dalla normativa europea. Appresa la notizia, in ogni borgo della Valtellina si sono alzate grida disperate. Vi chiederete: ma perché? Ecco, il fatto è che la nostra bresaola con tanto di marchio Igp (che significa indicazione geografica protetta) è prodotta, sì, in Valtellina (dove il clima consente una perfetta stagionatura) ma con carni che vengono (meglio, venivano) proprio dal Brasile. E se Bruxelles non concederà una deroga, ha commentato il ministro dell’Agricoltura Paolo De Castro “la bresaola è finita”. In questo sciagurato caso non resterebbe che consolarsi con qualche fetta di “brisaola”: la fanno in Val Chiavenna, con mucche rigorosamente nostrane. È buonissima però ha un difetto: è prodotta solo in poche migliaia di pezzi all’anno. Perciò è rara come un Gronchi rosa.
A sentir pronunciare la parola bresaola anche il quartier generale dello Slow food, a Bra nel Cuneese, risuona di ululati. Ma di indignazione. “Con il consorzio della bresaola della Valtellina sono 10 anni che facciamo liti furibonde. È un marchio truffa” s’indigna Piero Sardo, presidente della Fondazione per la biodiversità dello Slow food. Poi tra lo sconsolato e l’infuriato aggiunge: “E pensare che il marchio Igp era nato per tutelare i prodotti della terra”. Già. “Ma guardi cosa è successo a un formaggio come il Castelmagno. Lo facevano cinque o sei malgari, poche migliaia di forme”, poi è diventato di moda, al punto che non c’è ristorante o pizzeria dalle Alpi ai Nebrodi che non lo contempli nel menù. E allora? “Allora” sentenzia Sardo “il Castelmagno è diventato un formaggio bufala”.
A un prodotto cult come il lardo di Colonnata è andata anche peggio. Un tempo, quando veniva fatto da poco più di una dozzina di produttori di Colonnata, un paesino di 300 anime abbarbicato sulle Alpi Apuane, era conosciuto e apprezzato solo da una ristretta schiera di gourmet. Poi, come è avvenuto per il Calstelmagno, è esplosa la mania. E con essa la domanda: immediatamente soddisfatta. Anche se i produttori, a Colonnata, erano rimasti gli stessi. Un miracolo? No, una furbata. Fiutato l’affare, un gruppo di disinvolti operatori di Massa e Montignoso ha cominciato a riempire gli scaffali di supermarket e salumerie di mezza Italia con una valanga di “lardo in conca di Colonnata”, dove quelle due paroline “in conca” erano scritte a caratteri microscopici sull’etichetta. Ma la materia prima? Lardo spagnolo. E anche surgelato. Che di Colonnata aveva solo una cosa: il prezzo.
Se possono accadere casi come quello della bresaola brasileira, è anche a causa di norme Ue allo stesso tempo labili e complicate (vedere l’articolo a pagina 42). Frutto della pressione congiunta di due lobby assai potenti. Una è quella dei paesi del Nord Europa, grandi esportatori di materia prima che vogliono meno intralci possibile ai loro commerci. La seconda è quella della grande industria di trasformazione, che vuole acquistare dove più le conviene senza troppi lacci e lacciuoli (l’industria alimentare italiana ha un fatturato complessivo di 113 miliardi e 256 mila dipendenti).
Il risultato è che il consumatore può sapere da dove viene il miele che spalma sulla fetta tostata del mattino. Ma ignora quale sia il passaporto del bicchiere di latte che l’accompagna. Conosce la provenienza dell’uovo che mette in padella. Ma non della pancetta con cui sta friggendo. E se decide di cenare con un bell’arrosto misto di pollo e coniglio sa l’indirizzo da cui proviene il primo ma non quello del secondo. Per farla corta, una babele. Che riguarda pressoché tutte le principali filiere alimentari. A cominciare da quella del latte.
“Nel nostro comparto” dice il presidente Luciano Sita, presidente della Granarolo (quasi 8 milioni di quintali di latte lavorato, di cui un quarto acquistato all’estero), “siamo di fatto obbligati ad approvvigionarci fuori d’Italia, perché le quote di produzione che ci impone l’Unione Europea non sono sufficienti a soddisfare la domanda. Noi per esempio compriamo latte soprattutto in Germania e Francia, che utilizziamo per il prodotto a lunga conservazione e in parte per i formaggi, mentre yogurt e latte fresco sono rigorosamente italiani. Detto questo, l’informazione sulla provenienza della materia prima è un diritto del consumatore e un dovere delle aziende di trasformazione”. Servirebbe insomma l’obbligo di indicare quella che gli addetti ai lavori chiamano la tracciabilità del prodotto. Una proposta di apparente buonsenso.
Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo, storica associazione di difesa dei consumatori, è però abbastanza scettico. “Questa faccenda mi puzza un po’. Intendiamoci, il diritto all’informazione su quel che mangiamo è sacrosanto. Ma ho l’impressione che in questo caso il consumatore venga come strumentalizzato. Da chi? Ma dai produttori, è ovvio. Perché mai un prodotto per essere buono e di alta qualità deve essere necessariamente legato al territorio? Il rischio è quello di confondere interessi commerciali peraltro legittimi con le esigenze dei consumatori. Oltre a quello di alimentare, anche inconsapevolmente, politiche neoprotezionistiche”.
Di parere nettamente diverso è invece Lorenzo Bazzana, responsabile economico della Coldiretti: “Ma insomma, in Italia compriamo e mangiamo, senza nemmeno immaginarlo, provole e mozzarelle fatte con semilavorati che importiamo dai paesi dell’Est europeo. Persino il nostro speck è fatto con maiali d’importazione. Per non dire di salsicce, salami e mortadelle, prosciutti cotti e crudi non protetti dal marchio Dop. Dobbiamo ragionare in termini di territorio. E se poi c’è una ricaduta anche sulla nostra economia e sull’occupazione non mi sembra che sia un fatto negativo”. L’elenco dei prodotti alimentari confezionati in tutto o in parte con materie prime d’importazione senza che questa caratteristica sia specificata sull’etichetta è pressoché sterminato. Di latte e formaggi s’è già detto. Ma la globalizzazione tocca anche una bandiera della cucina italiana come la pasta di grano duro: oltre la metà è prodotta con farine che vengono dal Canada e dall’Australia.
Per il pane e i prodotti da forno, il grano viene dall’estero al 65 per cento, soprattutto da Francia e Germania, ma anche Russia e Ucraina. E ancora: il nostro Paese è il più grande imbottigliatore di olio d’oliva, peccato che più di metà delle olive, per l’esattezza il 55 per cento, sia raccolta in Spagna, Tunisia, Grecia, Turchia e persino Siria.
Quanto ai prodotti surgelati, secondo un’indagine della Confagricoltura “la presenza di materie prime non italiane è preponderante”. Come sono d’importazione anche buona parte dei legumi in scatola. Avvertenza supplementare: se sull’etichetta non è precisato che il prodotto è stato raccolto e confezionato in giornata, quasi certamente significa che si tratta di fagioli o piselli secchi provenienti da chissà dove poi rilavorati e inscatolati come similfreschi.
Insomma, per chi vorrebbe mangiare italiano si tratta di un quadro desolante. Ma come si può fare per avere la certezza di non trovarsi nel piatto un cotechino polacco e nel bicchiere un succo di frutta turco? Beh, prima di tutto (e per quanto è possibile) acquistare prodotti Dop. Di molti si può discutere l’effettiva qualità (e associazioni come lo Slow food lo fanno). Ma l’italianità della materia prima non è in discussione. Oppure scegliere prodotti la cui etichetta dichiara la provenienza italiana della materia prima. Se poi siete appassionati del coniglio ma lo preferite made in Italy, meglio che vi procuriate un amico contadino.
Copyright © 2000/2024
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2024