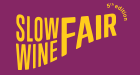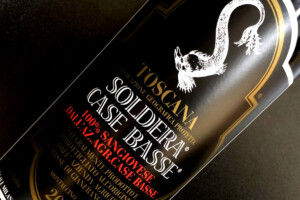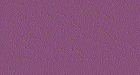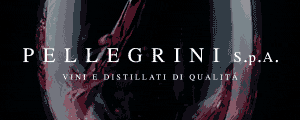Dal prendersi cura delle vigne di molte delle aziende più importanti e prestigiose del mondo e d’Italia (come Château d’Yquem, Château Latour, Château Angelus, Domaines Leroy, Hennessy e Louis Roederer, passando per Biondi Santi, Ferrari, Bellavista, Feudi di San Gregorio, Alois Lageder, Bellavista, Sella & Mosca e Allegrini, tra gli oltre 150 nomi possibili) a “salire in cattedra” in una delle università più autorevoli del mondo come quella di Harvard, il passo non è brevissimo. A compierlo, però, è stato Marco Simonit, creatore, con Pierpaolo Sirch, della “Simonit & Sirch Vine Master Pruners”, che, con il suo metodo di potatura e le sue tante iniziative, è diventata un punto di riferimento a livello mondiale. Marco Simonit è stato fra i relatori del “Vine to Mind: Decanting Wine’s Future with Data Science & AI”, l’importante simposio che ha visto radunati all’Università di Harvard, nel campus di Boston (uno dei tre della storica università americana, con Cambridge e Allston, in Massachussets), luminari del mondo del vino, menti pionieristiche del mondo della ricerca, manager di grandi aziende vinicole.
L’evento, organizzato in collaborazione con il “Journal of Wine Economics” per celebrare l’anniversario n. 5 dell’Hdsr (Harvard Data Science Review), aveva una duplice mission: analizzare il connubio tra le tradizioni enologiche e il dinamismo delle tecnologie contemporanee del Data Science e dell’Intelligenza Artificiale, e disegnare il futuro della viticoltura con intuizioni, innovazioni e collaborazioni basate sul Data Science. Vi hanno preso parte personaggi di spicco internazionale di vari ambiti, come Orley Ashenfelter, presidente dell’American Association of Wine Economists, Laura Catena, dg di Bodega Catena Zapata, Jeffrey Meisel vicepresidente e dg di Constellation Brands, Michael Silacci winemaker di Opus One, Mark Sahn Cfo di Gallo, Saskia de Rothschild Ceo e dg di Château Lafite Rothschild.
Due le sessioni del Simposio, che è stato aperto da Xiao-Li Meng fondatore e caporedattore dell’Harvard Data Science Review, Francesca Dominici, direttrice della Facoltà di Harvard Data Science Initiative, e Donald St. Pierre, co-fondatore e presidente AdaptEdge. La prima “Economia del vino guidata dal Data Science e potenziata dall’Intelligenza Artificiale” ha analizzato come i produttori e i distributori di vino possono sfruttare la ricchezza dei dati e degli strumenti di Intelligenza Artificiale per acquisire una profonda conoscenza dei comportamenti e delle preferenze dei consumatori, valutare gli effetti delle normative e delle politiche pubbliche, perfezionare le loro strategie di marketing e migliorare l’economia del vino in modo efficace e responsabile. La seconda è stata dedicata a “Clima e Uva” ed ha affrontato la questione di come in un mondo in cui il cambiamento climatico ridisegna continuamente i confini, il Data Science possa essere la bussola che guida l’evoluzione della viticoltura. Ad aprirla è stato Marco Simonit con un intervento dedicato alla progettazione del vigneto di fronte al cambiamento climatico, che ha riscosso un notevolissimo interesse.
“Il cambiamento climatico è diventato - spiega Marco Simonit - un tema rilevante negli ultimi anni: sapevamo che avremmo dovuto affrontare nuove sfide in molti aspetti della nostra vita, ma credevamo che sarebbe stato un problema per le prossime generazioni. Ci siamo, però, resi conto di recente che il cambiamento climatico è qui, possiamo vederlo e sperimentarne gli effetti ogni giorno. Gli effetti dei cambiamenti climatici (innalzamento delle temperature medie, eventi estremi come siccità, colpi di calore, forti tempeste …) stanno determinando una frequenza sempre maggiore di effetti sui principali distretti vitivinicoli del mondo. Per sfuggire a questi problemi sono necessarie nuove aree viticole - precisa - quindi abbiamo focalizzato due punti che riteniamo essenziali. Innanzitutto, per l’emisfero settentrionale, considerato lo spostamento a nord della coltivazione della vite già in atto, la ricerca di nuovi distretti vinicoli nelle zone più fresche. E poi quella che potremmo chiamare “Viticoltura d’alta quota”, ovvero l’impianto di vigneti ad altitudini più elevate. In questo contesto - conclude Simonit - è utile favorire la resilienza delle piante alle variabili climatiche: da un lato, preservando l’efficienza del sistema di conduzione dell’acqua nelle piante e migliorando le riserve nel legno vivo, e, dall’altro, gestendo tralci e grappoli nel rispetto delle norme che garantiscano il vigore della pianta. Le densità di impianto dovrebbero essere riconsiderate, al fine di ridurre l’uso di acqua/risorse e avere spazio sufficiente per lo sviluppo dell’architettura delle piante. Bisogna progettare delle architetture dinamiche, che possono essere sviluppate e modificate in base alla vita dell’impianto: saranno loro a costituire la spina dorsale dei germogli e dei grappoli e diventeranno un punto chiave per adattare le piante al loro terroir”.
Copyright © 2000/2026
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026