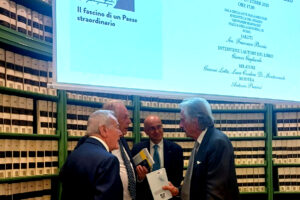A dettare i ritmi dell’accelerazione qualitativa dei vini italiani è stata senza dubbio, a cavallo degli anni Ottanta del Novecento, una recuperata sensibilità nei confronti della viticoltura, non più mero strumento, almeno fin dal dopoguerra, per ottenere il massimo in termini quantitativi, ma, finalmente, una vera e propria tecnica per produrre una materia prima ineccepibile, vero e, probabilmente, unico segreto per una grande qualità in bottiglia. Un lavoro che ha ristrutturato pressoché l’intero patrimonio viticolo italiano, adeguando sistemi di allevamento e sesti d’impianto (ma anche cloni varietali e portainnesti) ai vigneti più importanti del mondo quelli francesi, ovviamente, ma anche a quelli che intanto andavano a costituire il cosiddetto Nuovo Mondo enologico (Stati Uniti, Australia, Sud Africa ...).
Questo, a grandi linee, quello che dice la storia della viticoltura tricolore. Ma nelle pieghe di questa operazione, che resta nelle sue linee fondamentali positiva, anche, evidentemente, un lato negativo. Molti antichi vitigni tradizionali sono stati persi, molti altri sono rimasti allo stato di “reliquie”, molte vecchie pratiche di allevamento della vite (come, per fare forse l’esempio più noto, quella della “vite maritata”) sono pressoché scomparse e molte altre sono diventate assolutamente marginali come il tendone, che rappresenta un po’ il simbolo del sistema di allevamento “quantitativo” (da un ettaro di vigneto allevato con questo sistema si può ottenere anche una tonnellata di uva). Ma anche un impoverimento più profondo, che ha colpito i saperi e le tradizioni della viticoltura e dell’enologia (marginalizzazione dei legni grandi, per esempio) del Bel Paese. Non sono mancate, anche in questo caso, eccezioni, specie nel recente passato, sia dal punto di vista di un recupero squisitamente culturale, sia da quello produttivo e commerciale e uomini che hanno impostato il loro lavoro proprio con l’obbiettivo di sanare, in parte, questo impoverimento, come nel caso del duo friulano Marco Simonit e Pier Paolo Sirch, artefici non solo di una “Scuola italiana permanente di potatura della vite”, ma anche di un lavoro incessante di recupero di vecchi sesti d’impianto e di cura di antiche varietà. Così, solo per fare alcuni esempi, accanto ad operazioni come il progetto di Città del Vino “Senarum Vignae - Le Vigne di Siena”, ci sono anche esperienze come quella di San Felice, a Castelnuovo Berardenga, che ha ridato nuova vita al Pugnitello, quella dell’azienda campana Feudi di San Gregorio che ruota attorno alla valorizzazione di vere e proprie “viti monumentali”, oppure, la scelta pioneristica operata in Umbria da Caprai che ha letteralmente “vivisezionato” le potenzialità del Sagrantino a partire dalla misurazione delle sue “prestazioni” qualitative nei vari sistemi di allevamento, oppure ancora il progetto “Venissa”, la vigna Murata popolata dalla antica varietà Dorona e recuperata da Bisol sull’isola di Burano a Venezia, o l’unico esempio di clone regolarmente omologato che porta il nome di un produttore: il Sangiovese BBS 11 del Brunello di Montalcino di Biondi Santi, fino al recentissimo studio del Consorzio del Soave che rivaluta la pergola rispetto alla spalliera come sesto d’impianto qualitativo e capace di contrastare l’irraggiamento solare sempre più aggressivo.
Ed è proprio il global warming a rilanciare, secondo i pareri di diversi esperti messi insieme e rielaborati da WineNews, quanto meno, un ripensamento complessivo della viticoltura attuale del Bel Paese. Costituita per lo più su un modello qualitativo forte (sesti d’impianto stretti, numero di piante ad ettaro molto alto e rese di uva a pianta molto basse), questo tipo di approccio produttivo sembra non rispondere adeguatamente alle sollecitazioni climatiche, soprattutto quelle provenienti dal caldo che tendenzialmente sta aumentando in tutta la Penisola. Ecco che allora sesti d’impianto meno estremi, sistemi di allevamento tradizionali, rese d’uva un po’ aumentate e/o varietà tardive (certamente meno sensibili alla calura dei primi mesi estivi rispetto ai precoci come il Merlot) possono contribuire a fronteggiare il disequilibrio che caratterizza i vini di quasi l’intera prima decade del 21esimo secolo (grado alcolico elevato, acidità deboli, indebolimento aromatico). In questo senso, la tradizione viticola italiana (consapevole di dover impiantare vigneti in zone tendenzialmente mediterranee e non dal clima continentale) può rappresentare un buon indirizzo, certo modernizzata e aperta alle possibilità messe in campo dalla ricerca, senza però considerarsi un qualcosa di totalmente passato e di inutilizzabile.
Stiamo, evidentemente, parlando di chi persegue l’obbiettivo della massima qualità in bottiglia e che è disposto a “sacrificare” qualche ora in più di lavoro manuale nel vigneto (a cominciare da una gestione più attenta dell’apparato fogliare). Il ricorso ad antiche pratiche agronomiche, infatti, non necessariamente collima con la tendenziale rincorsa alla riduzione delle ore lavorative in vigneto (in Australia siamo già arrivati alle 150 ore ad ettaro e la prospettiva, giudicata non lontanissima, è quella di raggiungere a breve le zero ore, grazie alla meccanizzazione, ma, soprattutto, alla robotica che anche in campo sta facendo passi da gigante). Il tempo del vigneto non è, e probabilmente non sarà mai, il tempo del profitto e dell’economia di scala, se si cerca la massima qualità in bottiglia. Vendemmie anticipate per esigenze commerciali, o decise a calendario per l’ottimizzazione dei tempi e dei costi, impongono scelte agronomiche radicali, e, spesso, incapaci di reagire alla minima discontinuità della natura, finendo con l’influenzare in negativo la qualità finale della bottiglia (benché l’intervento enologico possa, molto spesso, “correggere” una materia prima scarsa). A meno che, il “global warning” sia soltanto un ostacolo passeggero o un falso problema, superabile semplicemente con l’introduzione dell’irrigazione. Ma, lo sappiamo benissimo, stiamo parlando dell’”oro blu”, una delle risorse più importanti del pianeta e, ricordiamolo, non infinita.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025