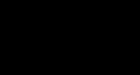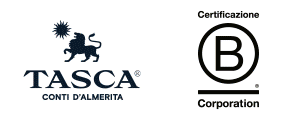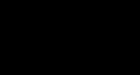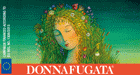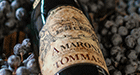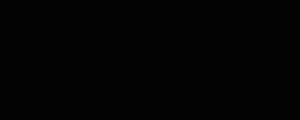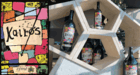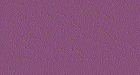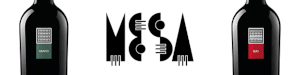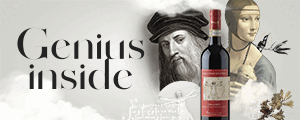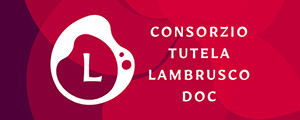La ricetta farnese. Fare vino senza una vigna … Un brindisi in cima al mondo. Valentino Sciotti, 60 anni da Crecchio, meno di tremila anime in provincia di Chieti, ha sempre cercato di abbinare passione e dovere. “Una sera a casa mia a Miami cucinavo degli hamburger con la guacamole, la mia specialità e invitai un gruppo di amici. Con questi si presentò LeBron James, che all’epoca giocava con gli Heats. Ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato un progetto che è arrivato a un passo dalla realinazzione: sì, stava facendo il vino di LeBron James. Avevamo l’idea di fare società assieme, si sarebbe chiamata LeBron James Vinery. Avevamo anche l’etichetta pronta. Il vino si sarebbe chiamato 23, il numero di maglia del campione di basket. Avevamo anche pensato a una bollicina, si sarebbe chiamata Zhuri, come la figlia. Eravamo molto avanti. Poi, le pretese del suo clan sono aumentate, hanno chiesto dei minimi garantiti da tre milioni l’anno e ci siamo fermati lì...”. Tra Crecchio a Miami passano quarant’anni e un’incredibile e modernissima vicenda imprenditoriale. Come Airbnb non possiede alloggi, come Uber non possiede automobili, Farnese produce vino senza possedere un chicco d’uva, in perenne alternanza tra passione e dovere. Parlando di lavoro, la passione di Sciotti si è sempre identificata con quello strano concetto che si chiama mercato. Fin dall’inizio, quando aveva 22 anni e dopo il servizio militare aveva trovato impiego vicino a casa, alla Antonelli, una fabbrica che produceva mezzi industriali 4x4. “Erano mezzi capaci di grandi prestazioni. Ma di queste capacità il nostro cliente ne sfruttava solo una parte. Così, convinsi l’azienda a proporre una macchina senza 4x4: costava molto meno, si rompeva molto meno e faceva lo stesso lavoro. Fu un successo”. Poi c’è il dovere, che ha la voce del padre, all’epoca direttore della cantina sociale di Crecchio. “Mi volle a lavorare con lui a Ortona, dove c’era la centrale di imbottigliamento delle cooperative locali. Non potevo dire no: presi un anno di aspettativa dalla Antonelli e ricominciai. Fu una folgorazione: scoprii il mondo dei prodotti di largo consumo e non tornai più da Antonelli”. Ad Ortona, Sciotti lavorò dall’87 al 1995. Poi, la svolta, con due soci e quell’idea: fare vino senza avere le vigne. Partirono in tre: Sciotti, Camillo De Iuliis, un abruzzese che aveva quattro ristoranti in Inghilterra e Filippo Baccalaro, un piemontese, terza generazione di enologi. “Avevamo alcuni limiti molti stringenti: non avevamo vigne, non avevamo terreni, non avevamo cantine, non avevamo impianti di imbottigliamento. Soprattutto non avevamo una lira”. Il libro dei sogni era aperto, ma le pagine restavano bianche. “Così abbiamo iniziato a pensare diversamente e ci convincemmo che per avere successo non bastano i soldi, servono le idee. E noi un’idea ce l’avevamo. La prima la concretizzammo guardando il nostro territorio: forte vocazione vinicola, ma proprietà altamente frammentata. Microproduttori che conferivano le uve alle cantine sociali perché nessuno raggiungeva una massa critica. Fu la prima intuizione. Capimmo che avevamo a disposizione tutti questi produttori che ambivano soltanto ad avere un reddito costante dalla loro attività. Ecco il nostro molo, l’idea. Abbiamo applicato il modello del ristorante stellato: prendere il meglio sul mercato e metterlo assieme nel miglior modo possibile. E abbiamo investito tutto in vinificazione, affiancando a Baccalaro tre enologi, giovani, australiani, oltre a un enologo francese e a uno trentino”. Il primo gennaio 1996 prende corpo la nuova Farnese Vini. Regola numero uno: costi fissi tendenti a zero: “Neppure i nostri compensi erano degli stipendi fissi, facevamo consulenze per pagarci pranzi e biglietti aerei”. Primo bilancio: 3 miliardi (di lire) di fatturato, poco più di un milione e mezzo di euro. Non male per degli esordienti, per di più tutto maturato all’estero. “Andava bene — dice Sciotti -, ma nell’estate del ’97 andammo in crisi perché dovevamo pagare le tasse e non avevamo liquidità. Stavamo per crollare, quando un funzionario di banca, mentre tutti si voltavano dall’altra parte, ci diede credito. Era della Cariplo, lo ricordo come fosse ieri. Ci finanziò un anticipo su fatture per 800 milioni di lire, peraltro tutti crediti assicurati, e uscimmo dall’incubo”. La grande svolta è nel 2012, quando De Iuliis decide di vendere. “Per la prima volta ci siamo affacciati al mercato del private equity - racconta Sciolti -. Avevamo Ubs come advisor e trovammo Alessandro Benetton, che si innamorò del progetto ed entrò, con 21 Investimenti, nel capitale con una quota di circa il 60 per cento. Rimase tre anni, dal 2013 al 2016. La sua fiducia iniziale è stata ripagata molto bene e ci ha lasciato una società migliorata: ci hanno insegnato il controllo di gestione e ne siamo usciti arricchiti. Nel 2016, con l’uscita di 21 Investimenti entra Neuberger Berman (con il 75 per cento), che aveva rilevato delle attività da Intesa. Anche qui, tre anni di partnership e l’uscita il 31 dicembre scorso per fare spazio al fondo Platinum che è il mio attuale socio, Platinum prende rso per cento, Baccalaro viene liquidato ed esce, io resto con il mio 20 per cento, pronto a correre ancora”. Nel 2019 Famese ha fatturato 75,97 milioni di euro (+4%), per il 97,9 per cento all’estero. “Abbiamo sviluppato mercati inesistenti, come l’Indonesia o il Vietnam, che ci riconosce un prezzo medio 4 volte superiore agli Stati Uniti, dove pure siamo presenti. La Svizzera è un altro grande mercato, come la Francia. E sono convinto che, dopo questa crisi, ci sarà un grande recupero”. Anche senza LeBron James.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025