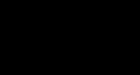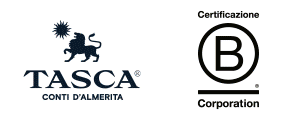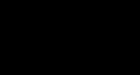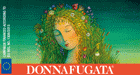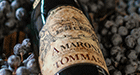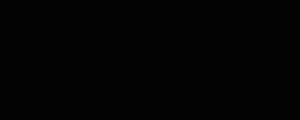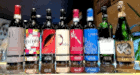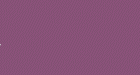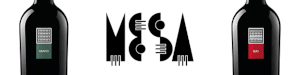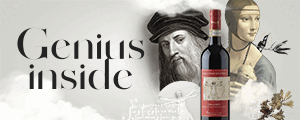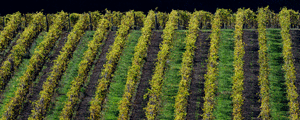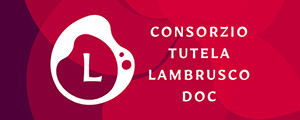Scrivi come mangi ... Il rapporto tra scrittori e cibo: dai banchetti di Trimalcione, alla cucina friulana di Nievo fino al “pollofiat” dei futuristi. Un grande linguista ci illustra un menù fatto di parole e sapori... La ricchezza delle forme e dei nomi che designano i cibi compongono in Italia un colorito mosaico, sfolgorii di voci locali, regionali, dialettali, a cominciare dal pane, dai dolci, dalle zuppe, dai vini. Vale la pena di illustrare in un apposito Convegno tanta varietà. La cucina, inoltre, è cultura, segno di un’identità, ed è simbolo. La cucina è fasto, spettacolo (penso all’ostentazione dei conviti rinascimentali), trionfo dell’immagine, oggetto da mostrare, segno distintivo del potente. Nel settembre del 1510 a Ferrara il Cardinale Ippolito d’Este muore d’indigestione, cosa che non meraviglia, se leggo le descrizioni dei banchetti del Messisbugo.
Tanto fasto perdura nel Seicento nei sontuosissimi banchetti dei signori: si veda soltanto nell’Arte di ben cucinare (1662) del bolognese Bartolomeo Stefani, cuoco alla corte dei Gonzaga, il banchetto allestito per la regina Cristina di Svezia, un’autentica rappresentazione teatrale che doveva soddisfare innanzitutto l’occhio più che il palato. Soltanto a fine Settecento tramonterà la cucina ultrafastosa delle corti e dei signori, e comincia ad affermarsi una cucina democratica, inizia la ristorazione, nasce il cuoco borghese. Una singolare teatralità, ma provocatoria e trasgressiva questa volta, sarà inscenata nel primo Novecento con La cucina futurista di Marinetti e Fillia, quando intendono lanciare una “rivoluzione cucinaria”, “uccidere le vecchie radicate abitudini del palato”, anni folli in cui il ristorante “Penna d’oca” di Milano offriva un banchetto con nella lista “agnelli arrosto in salsa di leone”, e Marinetti coglieva l’occasione per lanciare i suoi strali polemici contro il “pancismo”, la pastasciutta, “vivanda passatista” che “appesantisce, abbruttisce”, “rende scettici, lenti, pessimisti”. A Torino, in via Vanchiglia 2, si inaugura il “Santopalato”, che chiuderà rapidamente per fallimento: nel menu c’era il “pollofiat”, pollo con dentro pallini per cuscinetti a sfere affinché la carne assorbisse il sapore dell’acciaio dolce.
Ma la cucina ha da sempre scatenato invenzione e fantasia degli uomini, a cominciare dalla cena di Trimalcione alla cui tavola si trova ogni inimmaginabile rarità. Da Trimalcione in poi lunga è la serie dei golosi storici: da papa Martino V, che “facea torre l’anguille del lago Bolsena, e quelle facea annegare e morire nel vino della vernaccia, poi fatte arrosto le mangiava”, all’Aretino, ad Agnolo Bronzino, che era solito mangiare col Pontormo in qualche osteria di Firenze, e lodava in versi giuncate, ricotte, ravioli, e panzanella, mentre Andrea del Sarto, per una compagnia di buontemponi, la “Compagnia del Paiuolo”, stupiva gli amici portando in tavola un tempio le cui otto colonne erano salsicciotti con la base di parmigiano, il cornicione scolpito nel marzapane e il pavimento a mosaico di gelatine multicolori, con nel coro della chiesa commestibile una fila di tordi rosolati a guisa di canonici, e piccioni arrosto per cantori (lo racconta Giorgio Vasari).
L’invenzione non ha limiti. Specie tra gli scrittori. Dovrei citare i piatti avventurosi, totalmente d’invenzione, descritti da Salgari, o la torte vena giocoso-burlesco che Calvino ci mostra parlandoci della cucina in casa del futuro Barone rampante, in mano alla sorella dall’animo tristo.
I grandi scrittori sono stati di solito grandi descrittori di tavole imbandite e di cibi, da Flaubert, a Joyce, a Proust, il quale più che di sensi, profumi e gusti si nutriva del contorno delle stoviglie e dell’apparato raffinato. Nelle lettere italiane, tra gli indimenticabili descrittori di banchetti o taverne e quadri di bevitori, annovererei Manzoni, tra i dialettali il Belli. Nella lingua letteraria la gola passa attraverso l’occhio, e attraverso la parola, scorre lungo la qualità fonica del nome. Gli scrittori possono anche berlo un nome: “Albana - annotava Paolo Monelli nel Ghiottone errante (1935)-: sentite che sillabe liquide, che suono di terra lontana, con quelle tre “a” che per pronunciarle dovete atteggiare la bocca nello stesso modo che per afferrare l’orlo del bicchiere, con quella “elle” lunga come una lunga bevuta”.
Assai interessante poi, dal punto di vista della lingua, il registro “alto” delle ricette, dove la parola aderisce costituzionalmente a un suo peculiare “grande stile”. Lo si avverte addirittura nei dizionari. Basta aprire il Vocabolario milanese del Cherubini alla voce “ravioeu”, alla voce “cervellate” (quasi pregaddiane, annotava Angelo Stella), alla voce “risòtt”, alla voce “sorbétt”. Celeberrima in proposito la pagina di Gadda, “Risotto patrio. Rècipe”, da Le meraviglie d’Italia. Il puntiglio compiaciuto di un “grande stile” culinario vi si dispiega come non mai. Con la scrittura il piacere si duplica, si sentono a parole nuovi sapori, sembra di mangiare due volte, come se le parole ricucinassero il tutto. Spesso sulla pagina il cibo diventa ricordo, fa riaffiorare nella mente una coscienza svanita del perduto. Le “madeleines”, recupero memoriale, riempiono l’immaginario simbolico di Proust, e mi viene a mente Bettiza quando in Mostri sacri ci racconta con singolare trasporto della “rosada”, il dolce delle grandi occasioni dell’infanzia dalmata a Spalato,o Gina Lagorio di Inventario che rievoca la nonna intenta a fare i ravioli, e Vittorini di Conversazione in Sicilia, quando ritorna al pasto consumato con la madre, intenso recupero memoriale, riconoscimento dei sapori, degli odori che appartengono all’infanzia e stabiliscono un contatto mitico col passato, oltre che sottolineare una lacerazione ormai consumata.
Indimenticabile anche il racconto La sirena di Tomasi di Lampedusa, quando ritrae (siamo nel 1938), a Torino, il professor Rosario La Ciura, illustre senatore, e grecista, che ricorda con rimpianto i ricci di mare serviti nelle trattorie della sua Sicilia da cui manca da tanto.
Con gli scrittori si può andare a tavola. Si può conoscere, con Flaubert, la cucina golosa di Madame Bovary, possiamo sederci intorno al grande camino delle patriarcali cucine friulane con Ippolito Nievo, si può andare in taverna con Shakspeare, a pranzo con Virginia Woolf, a cena con Goldoni, con un Arlecchino perennemente affamato, come lo sono tutti i servi della commedia del resto, dal Bucco delle Atellane, al parassita divorato dalla fame nel teatro di Plauto, al Lazarillo, il picaro dall’appetito insaziato cui toccano, ahimé, sempre avari o affamati padroni.
Copyright © 2000/2024
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2024