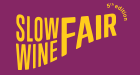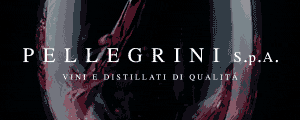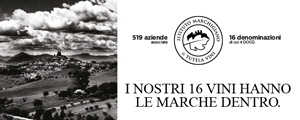Dopo 75 anni scoppia la pace nel Chianti ... Tregua. Firmata dalle opposte fazioni... Ci sono voluti 75 anni, ma alla fine in Chianti è scoppiata la pace tra chiantigiani. E sì, perché a volte e per fortuna anche i più ostinati si convincono che la guerra è sempre peggio della tregua. Se poi la tregua è quella firmata tra i produttori del Chianti classico (40 milioni di bottiglie e 250 milioni di euro in cantina) e quelli dell’altro Chianti (80 milioni di bottiglie e 350 milioni di euro), due vini Docg ma con profili anche molto diversi, allora si può comprendere che la svolta ha valore storico.
È accaduto che gli uni e gli altri si sono accordati sul fatto che ciascun schieramento produca unicamente il vino di pertinenza. E non come stabilisce il disciplinare del 1932 che, in caso di necessità, autorizza (il presente è d’obbligo, poiché l’accordo ha ottenuto il via libera della Regione ma attende ora la conversione normativa da parte del futuro Parlamento) i chiantigiani della zona storica a produrre anche l’altro vino.
E non viceversa, s’intende. Una disputa che poteva essere risolta assai prima ma è durata appunto tant’anni, sull’esempio di lotte intestine tra campanili, signorie e granducati poi risolte nel modo più pratico della forza, o con qualche diabolica furberia.
Ma di conflitti tra locali in nome del vino l’Italia è piena. Si può dire dell’Amarone (13 milioni di bottiglie) in Valpolicella, dove per decenni le aziende della zona classica di collina si sono opposte all’estensione della produzione. Senza risultato, perché l’Amarone è figlio diretto della Valpolicella (50 milioni di bottiglie) e quindi senza alcuna possibilità di restringere le superfici vocate. Non solo, ma con l’infausta situazione che un vino di grande pregio come l’Amarone, che ha tutti i diritti di stare all’apice del triangolo della qualità, non ha ancora il riconoscimento della Docg.
E che dire allora del Prosecco, forse il prodotto più gettonato del momento (e anche il più falsificato) in Italia e nel mondo. C’è il prodotto di élite di Conegliano e Valdobbiadene e c’è quello generico della pianura che arriva fino a Pordenone. Tutti e due sono Prosecco, solo che per fare il primo la resa massima è di 120 quintali di uva per ettaro, per il secondo si arriva a 250, con tutti i risvolti qualitativi del caso.
Anni di dispute sul che fare. Ora sembra ci si avvii verso la soluzione. Con quale compromesso? Con la “riserva del nome”. Vale a dire fare sì che il nome Prosecco venga riservato da una legge al Triveneto. Modestamente rammentiamo che Prosecco è nome di vitigno. Dunque nessuno può vantare l’esclusiva. Forse potrà andare bene rocambolescamente in Italia, ma nel mondo nessuno potrà tutelarne l’autenticità.
Copyright © 2000/2026
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026