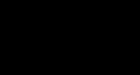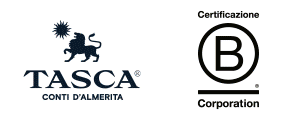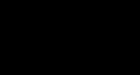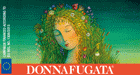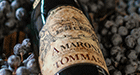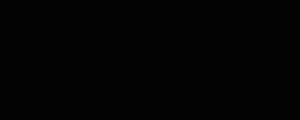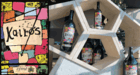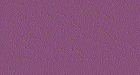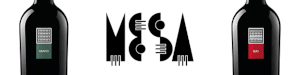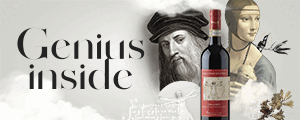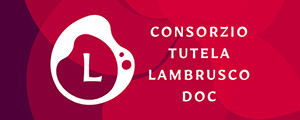Grappoli di vite vissute. Il fascino del Lambrusco. Il segreto del Sangiovese. Il profumo del Montalcino. Il vino come letteratura … Nei prossimi giorni arriva in libreria “Confesso che ho bevuto. Racconti e confessioni sul piacere del bere” a cura di Luigi Anania e Silverio Novelli, edito da Derive e Approdi. “L’Espresso” ne anticipa i testi di Francesco Guccini, Roberto Benigni e dello scrittore-disegnatore Jiga Melik.
Pistoni di Lambrusco
di Francesco Guccini
Di modenese, dico sempre, mi sono rimaste dentro due cose fondamentali: l’accento, che però si va via via attenuando, e un’altra che fortunatamente non si attenua, l’amore per il Lambrusco. Sarebbe meglio dire i Lambrusche, perché, minimo, sono tre, ma questa è roba da tecnici: io qui parlo da bevitore volgare, di quelli che non si intendono di cru o bouquet, ma che amano avere sempre, quando mangiano, un sano “pistone” sulla tovaglia. Già, il “pistone”. Era anticamente la misura vinaria da due litri, ma negli anni Cinquanta significava semplicemente una bottiglia di vino, soprattutto Lambrusco.
La parola viene probabilmente da pistone nel senso di “stantuffo”, “pestello”, ma non ha importanza la storia linguistica.
Era la parola sempre usata, tocco un poco malevolo e ammiccante di lingua zerga, e ricordo la bottiglia, di vetro grosso e scuro, e quando la si stappava col tirabuson, e lo schiocco che produceva, e come ci si affrettava a mettere sotto un bicchiere per cogliere il primo sbuffo di anidride carbonica (prodotta dalla fermentazione naturale) e di violacea schiuma. perché a quei tempi non c’erano tanti frigo a tenerle, le bottiglie, che venivano servite massimo a temperatura di cantina, chi ce l’aveva. E dato che quelle bottiglie non c’erano tutti i giorni, quando si stappava era festa.
Si preannunciava, quella festa, d’autunno.
Quando la stagione cominciava a declinare, e le prima fumane interrompevano le pallide giornate di sole, e la scuola già avviliva lo spirito, passavano, provenienti dalla campagna, i carri carichi d’uva, che allora la gente si faceva il vino in casa, e girando per le strade della città vecchia si sentiva, dalle cantine, provenire l’odore indimenticabile del vino che si stava facendo.
O avevi la fortuna di avere un amico con un po’ di terra in campagna, e allora eri invitato ad assaggiare il vino nuovo, col sole che stava raso la piana o una fumana da chiederti come fare per tornare a casa. Ma dentro, in quelle vecchie case coloniche semiabbandonate, si stava bene, e nelle cantine quell’odore di vino in fermentazione ti prendeva la gola e le narici e già ti dava ebbrezza, come la dava ai nugoli di moscerini impazziti contro le lampade fioche che pendevano, appese a un filo, dai soffitti neri. Mani amorose di resdore impastavano pasta per fare lo gnocco fritto, e qualcuno affettava salame e, qualche rara volta, addirittura prosciutto.
Era un tutt’uno spettacolo per i cinque sensi, le donne affaccendate, lo gnocco che friggeva nello strutto e veniva servito bollente e dorato, i tappi che saltavano del Lambrusco vecchio e le caraffe del vino nuovo, odorosissime, che vanivano messe in tavola, il colore sul rosso rosa dell’affettato, quello viola del vino e le mani unte che mangiavano, e le bocche che bevevano, e le prime leggere ebbrezze che ti facevano lucidi gli occhi ed affrettate le parole. Ora so che i Lambruschi sono quattro, Sorbara, Castelvetro, Salamino S. Croce e Reggiano, e ne conosco le diverse caratteristiche, e conosco etichette e marche e tutto. Ora è festa spesso, e il Lambrusco posso averlo quando ne ho voglia. Ma qualcuno mi ridia, se mai possibile, anche una sola di quelle antiche giornate d’autunno e la sensazione di quel frizzare d’un tempo contro palato e gola.
Salute
di Jiga Melik
Il vino da bambino non mi piaceva. la presenza del vino sulla tavola era legata al gesto di mio padre il venerdì, quando alzava il calice e benediceva il signore Dio, Creatore del frutto della vite. Poi spezzava il pane, poi cenavamo. Ma quello della benedizione era un vino dolciastro e noi non conoscevamo il comune vino da pasto. Non che mio padre fosse contrario: semplicemente non c’era mai una bottiglia di vino sulla tavola. Quando avevamo sete, c’era l’acqua. Il vino non lo bevevamo, L’unico riflesso dell’esistenza del vino era una piatto di rame dal bordo azzurro e il fondo rossastro proprio di quel metallo. Era appeso solitario a un parere della sala da pranzo. Il piatto riportava una scena sbalzata a rilievo. Due giovinetti che portavano a spalla il tralcio di un grandioso grappolo d’uva, una piramide di acini che scende sino alle caviglie dei portatori. Mi piaceva questa proporzione la paese dei giganti. Come si legge in Numeri 13, i portatori erano due degli esploratori mandati in avanscoperta da Mosè per vedere come era la Terra Promessa e cosa vi crescesse, e che tornavano con quella prova documentale fantastica, che avevano trovato la valle di Escol, la valle del Grappolo.
Poi la vita si srotolò dolce e anche durissima, e a tratti euforica, poi ingannatrice, e le cose succedevano, e per strada vicino al Mercato delle Pulci mi dicevano: ebreo di qui non ci passi, e io crescevo lo stesso. A casa nostra venne una signora toscana ad aiutare mia madre e stette con noi per molti anni. Era una vedova. Abitava dalle nostre parti. Arrivava la mattina presto e se ne andava la sera, prima di cena. Teneva pulita la casa, stirava, aveva una fitta peluria sotto il naso e mi sorrideva. Si chiamava Elisa. Veniva da un paese che si chiamava Montalcino. Era il 1960.
Come ho detto, a casa nostra non bevevamo il vino, eravamo una famiglia della esigua minoranza ashkenazita di Firenze che viveva in mezzo alla relativa maggioranza sefardita, al margine di una vita separata da cui si intravedevano il bianco e il nero del Duomo e quelle stradine di glicini e ulivi dove salivamo con mia madre a odorare le colline di Firenze. A rivederla così, sembrava una vita dell’Ottocento. Fu a stento verso il 1962 che prendemmo contatto con l’esistenza della modernità italiana, la pizza margherita sul lungomare di Viareggio e le biciclette in affitto. Invece non emergeva in modo tangibile di abitare dalle parti del Chianti e di quelle vigne famose in tutto il mondo. Noi non bevevamo il vino, non lo conoscevamo.
Adesso vi voglio dire di anni fa, siccome questo racconto è inserito nel mistero antico secondo cui quando un seme muore a se stesso, solo allora dà frutto. Era successo che avevo preso moglie, che la moglie era di Montalcino, che io ero tornato in Toscana e vivevo a Montalcino e che mio figlio era nato a Montepulciano. Ero finito in mezzo al piatto della mia infanzia, nella terra della mia promessa, ma ancora non mi ricordavo di questo piatto e di quel grappolo immenso. Abitavo a Montalcino dalle parti della strada di Sesta, proprio di fronte alla montagna. E’ uno dei punti migliori per il Brunello, dicono. A un certo punto mi capitò di andare a lavorare a Roma in un giornale. Stavo via anche 20 giorni e avevo forti malinconie dato che ero lontano dalla famiglia e dalla terra intorno alle mie finestre. A quei tempi il treno passava in fondo alla valle del Pentolaio, e quando succedeva si sentiva un fischio bucare l’aria di cucina. Poi hanno chiuso la tratta perché il binario era vecchio, ma quando tornavo da Roma, oppure ci andavo, e vedevo casa scorrere davanti ai miei occhi, ebbene fu proprio in quel modo e nella terra del miglior bere che capii cosa volesse dire il bere qualcosa con uno sguardo. Andando via col treno, passavo sotto le finestre e mi bevevo a casa.
Una sera che ero tornato a Montalcino, entrai in un’enoteca. Volevo parlare di quello che mi succedeva quando ero a Roma, ma non era facile. Mi vergognavo a fare una domanda che mi pareva quasi di ordine mistico. Alla fine mi feci coraggio e parlai al negoziante sottovoce, come fosse stato il mio direttore spirituale. Come era possibile, chiesi, che mentre ero a Roma e bevevo un bicchiere di vino di quella tale bottiglie, e solo di quella tale bottiglie, io sentissi il profumo di violetta che c’è nel vento d’autunno sotto alle mie finestre? Quando bevevo quel vino mi commuovevo come se avessi ritrovato un vecchio amico, o una parte della vita andata persa. O come se fossi a casa. L’uomo disse che non mi sbagliavo. Dove abitavo, alla base delle viti crescevano le violette di campo. Era quello l’odore che sentivo arrivarmi dalla gola al cuore quando bevevo. Tutta la vita in un grappolo.
Al Sangiovese
di Roberto Benigni Io son toscano, se ne sono tanti e nacqui proprio nel decimo mese ho sentito parlar sempre del Chianti mi sono trovato a fare il Sangiovese. Sono anche astemio, io non bevo vino quindi il più adatto a dirne la goduria un poco come fa Sant’Agostino quando parla di vizio e di lussuria.
A me mi basta un rosso acino appeso l’odor dei tralci e quale un colibrì volo nel cielo, come avessi preso quaranta grammi d’elle esse dì. Base di tutti i vini il Sangiovese dei vitigni mondiali egli è la stella ci fanno il Chianti, il vino piemontese forse ci fanno pure la Nutella.
Il Sangiovese è scevro da magagne d’ogni virtù dei vini è la scintilla al suo confronto anche lo champagne diventa una volgare camomilla.
Bevete il Sangiovese, quello scuro d’anni ne camperete centomila fa bene alla salute, e v’assicuro fa far l’amore dieci volte in fila.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025