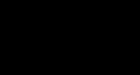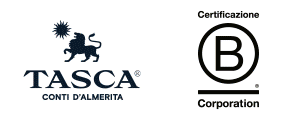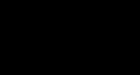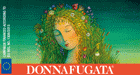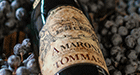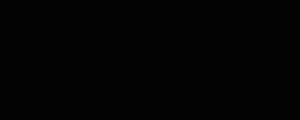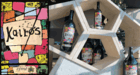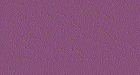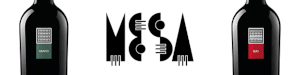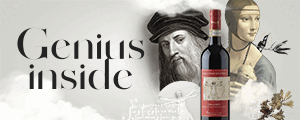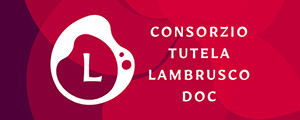Grande madre Campania ... L’epopea della ricca Capua granaio di Roma. Terra del vino falerno, del giurano e del massico, dolceamari come il sangue. Del fatto che è con il sonno gli amplessi e il vino che va sbaragliato un esercito. Ma il Nostro non abusò mai delle italiche donne... “Attento alla femmina dell’Ager Campanus”, mi avverte Marino Niola con una telefonata da Napoli. Sto andando a Capua, la terra degli “Ozi” di Annibale, e so che gli antropologi sono dei visionari che sparano immagini estreme; quelli napoletani figurarsi. “La donna capuana - incalza Marino - è allo stesso tempo Persefone e Demetra, luogo di morte e di fertilità”. Mio dio, penso, chissà quali esperienze avrà avuto. Ma lui galoppa ancora: “Capua è il ventre caldo delle madri che toglie le forze ai Cartaginesi”.
Quando arrivo scopro che la donna dell’Ager Campanus esiste eccome. Ne vedo subito una oltre il traffico e la plebe, davanti al numero 22 di via Alessio Simmaco Mazzocchi a Santa Maria Capua Vetere (nelle terre dei Borboni un nome di due sole parole non è degno di considerazione): una matrona del Volturno dagli occhi come braci, dominatori e indifferenti, adorna di una cascata di riccioli neri e un peplo di bianco lino plissettato, aperto con generosità sulle sue bellezze. Praticamente Giunone. La Campania è piena di donne così, simili alle Grandi Madri, le antiche gigantesse di pietra cariche di spighe e bambini che quando entri al museo di Capua sembrano saltar su e urlare tutte insieme “Attento, questa è la terra delle donne!”.
Certo, tutto è cambiato da quando l’antica Capua aprì le porte ad Annibale invitandolo a godersi la vita: eppure, tutto è rimasto lo stesso. Antico e moderno generano intrecci da mal di testa. Quando ti siedi al caffè non sai se al tavolo vicino c’è Socrate o Peppino de Filippo. Per strada confondi satiri e bottegai, comari e torbide Clitennestre, ombre di aruspici e parroci di campagna, ninfe delle fonti e commesse di supermercato, parche tessitrici di destini e cameriere russe capaci di sparare ordinazioni con la durezza di una fucilata. “Amplexu multoque mero somnoque virorum / profliganda acies”. Silio Italico, nel suo poema sulla guerra punica, scrive della vecchia Capua che “è con gli amplessi, il molto vino e il sonno che va sbaragliato un esercito che né spade né fiamme, né Marte sfrenato hanno potuto abbattere”. Aggiunge perfidamente: “Gusti, il condottiero, i piaceri che si insinuano nel profondo delle viscere”. Come dire: muori Cartaginese. Dimenticava che nel grembo delle Madri gli africani lasciarono anche figli. Il seme della rinascita, e quindi della rivincita. “Ah - sospira Giovanni Brizzi, la mia inclita guida annibalica, subito catturato dal fascino del luogo - dovettero godersela assai i soldati da queste parti In quattro anni, di donne ne avevano viste poche...”. Beh, gli dico, ci saranno pur stati degli stupri. “Difficile. Annibale su questo era severo. Proibiva di toccare le donne del nemico”. Non ci credo, come li tieni dei soldati vincitori?
“Lui era inflessibile. Chi trasgrediva era duramente punito. Sapeva che se tocchi il nemico nell’onore, scateni l’impensabile. Trasformi in leone anche un agnello. E soprattutto, dopo la guerra, rendi impossibile un’alleanza duratura con l’avversario. Era una scelta politica”. Africano anomalo questo tuo generale “Il suo modello era greco: Alessandro Magno, che dopo la vittoria non toccò un capello alla moglie e alle figlie del re persiano Dario. Tutta la famiglia di Annibale era così. Talmente continenti che gli altri clan cartaginesi li accusavano di pederastìa”. Annibale non ebbe donne? Non ci credo. “La moglie Imilké era lontana, in Spagna, ma questo non cambia le cose. Nella sua vita le donne sono quasi assenti”. Non si concesse una prostituta? “Plinio il Vecchio racconta che ne ebbe una in Puglia, in un paese di nome Salapia, poco lontano da Canne, nei mesi del campo invernale”. E che dice Plinio? “Dice che gli abitanti di Salapia erano ancora così orgogliosi di questo primato, che secoli dopo portavano ancora i viaggiatori a vedere la casa degli amplessi. Significa che nessun altro, in Italia, poteva vantare fughe amorose di Annibale”. Davanti all’anfiteatro dei gladiatori c’è un cane bianco e nero che dormicchia sotto le arcate.
Occupa platealmente la passerella d’accesso, poi ci fa passare con uno sguardo pigro da usciere. Scavalcare questo metafisico abitatore di rovine è come varcare la soglia dell’altro mondo. Siamo con due universitari napoletani buoni osservatori del terreno, Giacomo de Cristofaro specialista di storia romana, e Osvaldo Sacchi studioso delle fonti del diritto romano. Rievochiamo, gesticolando, la storia. In principio fu Capua, la più meridionale delle colonie etrusche. Il punto di contatto con le terre selvagge dei Sanniti. La città più ricca d’Italia. La terra del vino falerno, del giurano e del massico, dolceamari come il sangue, inimmaginabili ai palati di oggi. Terra di argentieri, profumi e frutta formidabile, bestiame e unguenti come il meliloto della rosa. Qui Roma impara il rituale gladiatorio, qui Spartaco formerà l’esercito dei suoi ribelli. Qui nasce la commedia popolare detta Atellana. Qui è il granaio di Roma, fino alla conquista della Sicilia e dell’Egitto. C’è la defezione della città italica dall’alleanza con Roma, ci sono gli “ozi”, poi la riconquista e la punizione terribile. La classe dirigente si suicida o viene messa a morte. Da allora, una lunga decadenza e l’oblio.
Ma Capua resta egualmente così ricca e invidiata che le usurpano anche il nome. La vicina Casilinum diventa Capua per decisione vescovile, e la capostipite viene declassata a Santa Maria Capua Vetere. Poi, a due passi, nasce Caserta, con la reggia dei Borboni. Due città figliastre in trenta chilometri. E in mezzo lei, prolifica come una grande madre. Non c’è nessuno oltre a noi. Fruscio di passeri nella sterpaglia, passerelle, voragini che si aprono sugli inferi dei gladiatori e delle belve. Il moncone sud dell’anfiteatro che si staglia nel cielo bianco come il teschio di un bisonte. Questo non è il Colosseo, infestato di orde in bermuda. Tutto è infinitamente più intrigante, come sulla Trebbia o a Canne. Dove è passato Annibale la magia resta, e la peste dei non-luoghi non attecchisce. C’è un’energia primordiale che percepiamo ovunque. Qualcosa di molto più vecchio di Roma. “Qui l’antico riaffiora persino nella circolazione stradale” spiega Osvaldo Sacchi mostrando dall’alto un fittissimo labirinto di mura medievali, viabilità borbonica, ville romane e chiese barocche.
“Qui l’asse egemone dovrebbe essere quello Est-Ovest, la via Appia” dice indicando la “N 7” tangente al centro storico. “E invece no! Quando sono arrivato qui ho capito che le strade laterali avevano tutte la precedenza e spezzavano l’onda verde della via Appia Era chiaro: comandava un asse molto più antico, quello Nord-Sud, che parte dal tempio di Diana sul Monte Tifata! Qui Cardo e Decumano sono invertiti rispetto al normale. Che roba è questa se non un inconscio rifiuto dell’impianto spaziale romano?”. Ci inghiottono gli inferi del Mitreo, un sotterraneo dove si sacrificava il toro bianco del dio Mitra. Nel semibuio intravediamo l’affresco dell’uccisione, la vasca del sangue, il serpente e il cane che lo bevono, lo scorpione che punge i testicoli dell’animale, il corvo vaticinante, le costellazioni. Usciamo muti di meraviglia dal secondo secolo dopo Cristo, un’epoca che ha già alle spalle Annibale e l’eruzione di Pompei. I barbari sono ormai alle porte, Capua è già l’ombra di sé: ma la luce abbacinante dell’esterno ci sbatte in un presente così volgare che persino quel tempo ci sembra una meraviglia di “humana pietas”.
Brizzi ha capito e sorride. Ora vorrebbe viaggiare come Don Chisciotte, hidalgo fuori-tempo fra i cialtroni. Ormai è Calcutta. Caldo monsonico, fiori e cumuli di immondizie, roghi di sterpaglia, nebbie rossastre della sera. Una negra statuaria e altissima ci taglia la strada; pare Atropos, la gladiatrice che aveva il nome della parca che taglia il filo della vita. Non torneranno più per Capua i fasti di Annibale. Quando ebbe in mano la resa senza condizioni della città, il console Quinto Flavio Flacco mandò a morte i 53 maggiorenti che non si erano già suicidati, fregandosene del parere del popolo romano. Una lettera del Senato gli raccomandava clemenza, ma lui la tenne chiusa apposta fino a esecuzione avvenuta.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025