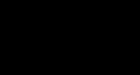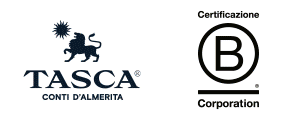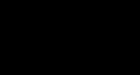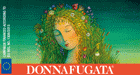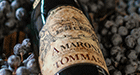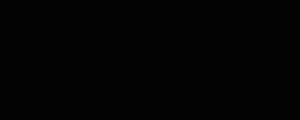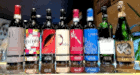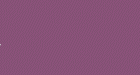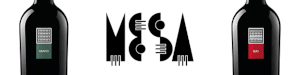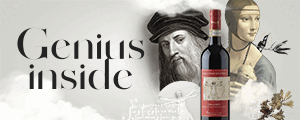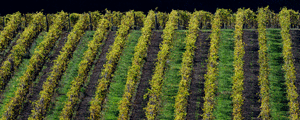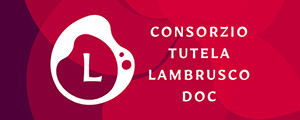Il Valpollicella di Hemingway ... Quando andavamo a zonzo fuori dai confini italiani non c’era nessuno che entrando in un ristorante ordinava “maccaruni” e vini nostrani, che comunque non avrebbe trovato. Il viaggio non veniva assimilato alla magnata fuori porta e quando incontravi qualcuno che faceva quel gesto osceno delle tre dita che ruotavano come una forchetta sul piatto, per segnalare il bisogno di mangiare spaghetti, ci davamo alla fuga fingendo di non conoscerlo. Se uno coltivava interessi gastronomici, questi venivano molto meglio appagati dalla scoperta di nuove pietanze, dai sapori e dagli odori mai sentiti.
Semmai un atteggiamento da evitare era quello contrario: l’eccessiva disposizione, come si arrivava in un paese esotico e lontano dall’Europa, a mangiare lungo la strada, affascinati dalle verdure multicolore disposte in piramidi e circondate da sacchi di iuta gonfi di fave, di lenticchie, di semi di cumino e di tutte le erbe aromatiche che rendevano la spesa un’iniziazione ai misteri e ai profumi del paese. Chi fingeva di essere un habitué del posto, comprando direttamente dai venditori di specialità locali e azzannando a morsi la frutta per far vedere che lui era il più tosto e il più gagliardo, si ritrovava a rantolare sul letto dell’albergo annientato da tremende dissenterie.
L’incontro con i vini era totalmente affidato al caso e non aveva nulla a che fare con la qualità. A una cerimonia ufficiale nello Yemen, nella quale ero capitato per
sbaglio, venni fermato da un autorevole dignitario di corte che mi chiese con tono perentorio: “Venegazzù?”. Per qualche attimo feci ciondolare la testa in attesa che mi arrivasse una qualsiasi
illuminazione. A togliermi dall’imbarazzo arrivò dalle cantine una bottiglia di prosecco gelato di
Venegazzù. Solo molti anni più tardi sono riuscito a dare un senso all’evento surrealista: durante
gli anni Venti un governatore dell’Eritrea, nato a Venegazzù, aveva assoldato per l’Africa orientale
italiana cinquemila cavalieri yemeniti e da allora la gratitudine dei governanti dello Yemen
verso l’Italia, identificata con Venegazzù, era passata a tutti gli abitanti di quel paese e aveva coinvolto anche il prosecco.
A memoria, i vini in cui mi sono imbattuto, spesso in contrade lontane
da Dio e dagli uomini, sono stati l’Est Est Est, senza che ci fosse una ragione apparente per un simile primato; il Lacrima Christi, forse per il suo nome così evocativo; e qualche rosolio siciliano. Il nome del Valpolicella aveva fatto il giro del mondo ed era diventato popolare per essere la bevanda preferita di Ernest Hemingway, che ne trincava otto litri al giorno, secondo la leggenda, mentre stava a Venezia e andava a spasso con le signorine Ivana Ivancich e Afdera Franchetti. I baroli, i barbareschi, i bianchi del Collio, cioè alcuni tra i migliori vini del mondo, sembrava non esistessero. Fuori dai confini nessuno veramente aveva un’idea precisa delle nostre abitudini gastronomiche. L’unica volta in cui programmaticamente scelsi di bere un vino italiano, il più costoso che riuscissi a trovare, fu a Montecarlo.
Avevo appena venticinque anni e ero stato invitato da La Société des Bains de Mer e dalla Mondadori a passare una settimana all’Hotel de Paris di Montecarlo insieme a due amici per mettere insieme il numero zero di un giornaletto legato alla nascita di Radio Montecarlo, avvenuta pochi mesi prima. La sera del nostro arrivo ci precipitammo al Grill, il ristorante dove andava sempre Onassis, situato all’ultimo piano dell’hotel e con una vista famosa sul principato. Eravamo ospiti senza limite di spesa e con la protervia degli anni giovanili ordinammo una cena sontuosa, che doveva essere accompagnata dal vino più caro. Quando il sommelier si presentò con la lista dei vini, io la rimandai indietro chiedendo della lista “reserve”; e
quando questa si materializzò sulla tavola, feci scorrere il dito sui prezzi arrestandomi sul più alto di tutti, che stava accanto a un nome italiano.
La faccia del sommelier diventò grigia: “Ci
sono solo due bottiglie di questo vino”, disse. “E lei ne porti una”, ebbi la prontezza di rispondere.
Quaranta minuti più tardi, dopo un’attesa interminabile, si presentò una piccola carovana composta da tre persone che portavano la bottiglia dentro un canestro di paglia, e che avevano la stessa attitudine ieratica dei sacerdoti che portano in giro l’ostensorio. Fu un momento che i cattivi scrittori definirebbero “indimenticabile”. Appena il sommelier ebbe finito di versare qualche goccia del vino sul fondo del bicchiere, io buttai in gola, con un gesto rapidissimo della mano, come
fosse una gazzosa, un liquido ambrato che sembrava aver perso ogni sapore, mormorando “pas
mal”. Fu un miracolo che non ci cacciassero a pedate dall’albergo. Quando ho raccontato questa
storia ad uno dei più grandi esperti di vini italiani, mi disse che dovevo essermi sbagliato: quel vino
non poteva essere che francese. Un vino italiano non ha mai raggiunto, né prima né dopo, i prezzi
riservati a Montecarlo ai vini di casa.
Autore: Stefano Malatesta
Copyright © 2000/2024
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2024