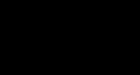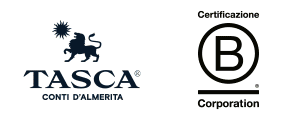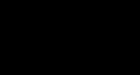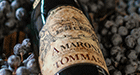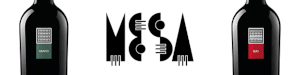Buon Appetito!
- “Buon Appetito!” Lo dico in italiano anche se siamo quattro amiche inglesi a pranzo in Toscana. Esiste l’equivalente inglese di “Buon appetito”? Ci pensiamo un minuto. No. Prima o si diceva la piccola preghiera chiamata “Grace”, o non si diceva niente.
“Prima della "food revolution" del dopoguerra quando ci siamo tutte messe a cucinare, ci era vietato di parlare di cibo o di entrare in cucina: era considerato volgare nelle case delle medie e alte classi”, racconta Barbara, signora raffinata londinese di una certa età, che da trent’anni vive anche nel Chianti e che cucina benissimo.
“Si. Nell’Inghilterra il cibo non era mai associato con il piacere”, dice Mary, straordinaria pittrice oltre novantenne che cucina spesso per i suoi ospiti allo studio a Londra. “Si teneva in casa una cuoca per poter liberare le nostre menti ad argomenti più intellettuali”. I bambini erano quasi sempre costretti a mangiare da soli nella nursery, con la "nanny", cibo di basso costo, blando e terribile, senza sostanza e sapore.
“Mia madre non sapeva bollire un uovo prima del ’40, quando si è buttata nella cucina per necessità”, aggiunge Barbara.
Però si è sempre mangiato molto bene in alcune parti del Regno Unito, a differenza dell’idea che hanno tanti stranieri. “Mio marito mi raccontava che tra le due guerre, nelle case private, mangiava divinamente chi aveva soldi per tenersi la cuoca”, spiega Barbara. I prodotti della terra e del mare erano buonissimi, dal burro giallo di mucche fuori sempre al pascolo, ai grandi formaggi come lo Stilton o i Cheddar, alle carni, la cacciagione, il pesce. Con pane sostanzioso, di vari cereali.
“Anche nelle case di campagna il "real English food" era ed è tuttora meraviglioso”, dice Mary. Torte salate, carni arrosto, verdure stagionali, e tanti buonissimi dolci, specialmente alla frutta.
E il vino? “No, a casa quasi mai, tranne a Natale o forse per un compleanno. Non faceva parte del nostro quotidiano”, dice Mary. “Infatti, dopo la guerra, quando con mio marito Julian, anch’esso pittore, andavamo all’estero, come in Spagna o in Italia, ci consideravano osé perchè bevevamo il vino locale. Bere il vino come accompagnamento al cibo è un’idea recente per noi”.
“Si”, conferma Barbara. “A casa lo sherry era l’unico alcolico ad essere considerato accettabile e "genteel", da sorseggiare prima del pranzo o della cena. Adesso che ci penso mi fa sorridere, visto che il contenuto alcolico dello sherry è molto più alto del vino”.
Il vino si trovava nei club degli uomini, con la birra, o nelle cantine private di chi, come il mio patrigno, andava ogni anno a Bordeaux per comprare “en primeur” i vini "to put down", come si diceva per vini da tenere in cantina almeno quattro anni prima di essere bevuti. Vini sempre rigorosamente francesi.
L’avvio del Sale
- Una settimana in Toscana per cercare un po’ di ristoranti e trattorie buoni - non stellati - e mi sono quasi avvelenata dalla quantità di sale che ormai si trova in quasi ogni piatto. Si, lo so, in Toscana tutto deve essere più salato (o saporito come piace dire ai toscani) perchè il pane è sciocco. Ma io mi ribello, non solo contro un carico di sale che stordisce lingua, palato e cuore, ma anche per il menu quasi regimentato che si ritrova ovunque. Lo conosciamo a memoria: crostini misti (sempre gli "usual suspects"), affettati toscani, la ribollita (spesso non disponibile in questa stagione ma neanche tolta dai menu), pici all’aglione, pappardelle alla lepre o ai funghi, la fiorentina (eccellente quando lo è, ma anch’essa servita sotto un dito di sale, poveraccia) … dove sono andati a finire i piatti veramente locali, la ricchezza di sapori dei contadini o dei Medici, le verdure dell’orto? I piatti semplici ma gioiosi delle stagioni? Possibile che il turismo straniero abbia così standardizzato e ridotto questa regione? Che i fagioli bolliti cosiddetto "al fiasco" siano le uniche espressioni della terra che rimane? Ci sono tanti buoni ristoranti, per carità, ma è anche vero che esistono troppi luoghi dove i cuochi si sono seduti, se non addirittura assentati. Peccato.
Per fortuna sono anche tornata a ritrovare due ristoranti che, da tanti anni, non avevo visitato: Silene, sull’Amiata (a Pescina, Seggiano, tel. 0564/950805), dove il giovane Roberto Rossi cucina i robusti piatti di carne della montagna con discrezione ed equilibrio, da accompagnare con rossi toscani di carattere - come Le Trame di Giovanna Morganti - e da Walter Redaelli, a Bettolle (vicino all’uscita Sinalunga dell’A1, tel. 0577/623447). Che piacere riconoscere subito la mano e il fine palato di questo chef nei suoi piatti: un soffice timballo di melanzana che sapeva della quintessenza di quella verdura, non di uovo; gnocchi di funghi porcini come cuscini terrosi punteggiati di tartufo; pici di grano macinato a pietra con un sugo estivo - tutto delizioso e leggero. E per finire, dolci di grande tecnica, tra cui una delle migliore torte di cioccolato che ho mai avuto la fortuna di incontrare. Tutto in una sala semplice ma giusta, con ottimi vini, 22 posti e un giardino per le serate calde d’estate.
Show me a rose
- Mio padre, Carmen Capalbo, regista di teatro della generazione di Strehler, ha portato l’opera di Brecht a New York in una delle primissime produzioni off-Broadway, "The Threepenny Opera", con la diva di Kurt Weill, Lotte Lenya. La Lenya era affascinante ma mi faceva anche un po’ paura con la sua voce quasi maschile tinta di tedesco. Ero piccolissima, e suo segno di affetto per me era di pizzicarmi sempre sulle guancia, forte, come una prima lezione del dolore nel piacere. Quando cantava aveva una voce indimenticabile che mezza cantava, mezza parlava. Al contrario, la voce di Weill (che non ho mai conosciuto di persona), era alta, eterea, quasi femminile. Lo so perchè mio padre aveva una collezione di dischi immensa, che negli anni '60 andava dal rock (è stato lui a far conoscere ai suoi figli Lou Reed, non il contrario) al classico. Nel reparto teatrale c’erano tutti i musicals e anche tante registrazioni mai pubblicate, prove di canzoni per eventuali musicals alla ricerca di sponsor. Tra questi c’era un disco intitolato "Try-out" di canzoni di Kurt Weill cantati da lui in inglese mentre suonava al pianoforte. Qui c’erano sia le memorabili canzoni "Sing Low" e "That’s Him", sia canzonette ironiche su ragazzelle di Flatbush, dove Weill poteva vantarsi della cultura americana appena acquisita. Mio disco preferito era di Groucho Marx. Cantava canzoni dei titoli pazzeschi: "Go West!", "Father’s Day"… e "Show me a Rose", con musica romantica e parole surreali:
Show me a rose and I’ll show you a girl named Sam,
Show me a rose or leave me alone …
(Mostrami una rosa e ti farò conoscere una ragazza di nome Sam,
Mostrami una rosa o lasciami solo …)
Saranno 15 anni che non sento più quel disco a 33 giri, ma ogni estate mi torna in mente quando sento i profumi delle sessanta varietà di rose antiche che coltivo nel mio giardino in Piemonte. Una collezione modesta (la moglie di Gianfranco Soldera, a Case Basse, a Montalcino, ne ha più di 2.000) tutta costruita intorno ai profumi diversi di questi ed altri fiori.
Un repertorio dell’olfatto utile anche per il vino. Forse è per questo che mi piace tanto il Pinot Nero: in grande annate (come il Mazzon di Gottardi 2000) ritrovo la stessa complessità e bellezza di questi fiori, che vanno dalla sensualità voluttuosa di una rosa nera-porpora del 1865, Souvenir du Docteur Jamain, alle note speziate e fini della tenue New Dawn. Ho messo il mio naso in ogni fiore che ho incontrato in tutta la mia vita, spontaneo e non, e mi ricordo i loro profumi: lo suggerisco come studio a tempo indeterminato per tutti gli appassionati del vino. Show me a rose!
Carla Capalbo
Copyright © 2000/2026
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026